“Descrivendo un’epoca della mia vita cerco di definire il senso di un’epoca della storia europea e, così facendo, di dimostrare il valore della riflessione come guida dell’esistenza umana. Una tesi che ha gran bisogno di essere sostenuta.” Così dice Simkha Opatchevsky per mezzo della voce di suo figlio Pierre Pachet, che raccoglie la sfida ambiziosa di raccontare la vita di un altro uomo, suo padre appunto, come se fosse la propria.
In Autobiografia di mio padre, romanzo edito dalla casa editrice L’orma editore nella collana Kreuzville Adelph, Pierre Pachet narra l’esistenza di un esule ebreo all’inizio del novecento. Quando nel secolo breve inizia a serpeggiare l’ignobile spirito antisemita, i genitori di Pachet, ebrei russi originari di un villaggio nei pressi di Odessa, si trasferiscono a Parigi dove il piccolo Pierre nasce nel 1937. Per nascondere la propria appartenenza ebraica durante l’occupazione nazista, il padre Opatchevsky arriva all’atto estremo della negazione, occultando la sua identitaria fede religiosa e iscrivendo i figli ad una scuola cattolica. Con la liberazione l’intera famiglia si muove a Vichy dove Simkha diventerà medico specializzato in stomatologia. Quella che condurrà sarà un’esistenza volta alla salvaguardia della sua famiglia, una sopravvivenza senza grandi eroismi, anche quando le circostanze lo avrebbero richiesto. Nel lento fluire verso quella fase della vita nella quale i ricordi acquisiscono un’importanza determinante, si dipanano le memorie di un uomo declinate dalla consapevolezza letteraria di un altro.
Quella che Pachet ci consegna è la figura di un esule che, dai pogrom di Kishinev ai rastrellamenti nella Parigi assediata, vive i drammi della storia del suo tempo senza compiere atti valorosi o gesta memorabili, ma con l’occhio di chi, patendo l’angoscia dell’occupazione, il rischio costante di essere scoperto, riesce a osservare la realtà intuendone tutte le sue interpretazioni, leggendone sapientemente ogni sfumatura. Da profondo conoscitore della mente umana, riesce a farlo anche quando questa viene deviata dalla bruttura, dall’avversità e dalle atrocità. Anche quando, a livello personale, sperimenta su di sé frustrazione e fallimento, guarda fuori e si osserva dentro con un approccio malinconico e al tempo stesso profetico rispetto al quale riesce difficile non provare empatia. Riconoscimento. “Andavo per Parigi tormentato dal ricordo di una notte terribile del passato, subito dopo la bocciatura a un esame importante di odontoiatria; avevo vagato in preda alla disperazione, pronto al suicidio – che la grande città disumana sembra sempre pronta a suggerire a chi non si trova al proprio posto. A grandi passi salivo e scendevo per il boulevard Saint Michel, guardavo le coppie felici che dai ristoranti si avviavano alle sale da ballo, leggevo le targhe degli studi medici sui portoni dei palazzi di lusso. Per fortuna la fatica mi aveva ricondotto a casa, dove avevo trovato una portinaia chiacchierona con la quale confidarmi. La banalità e l’assurdità della circostanza erano bastate a ridarmi coraggio; in ogni caso sapevo da sempre che il suicidio non faceva per me: ero troppo abituato alla malinconia.”
Dal titolo-ossimoro Pachet dà vita a un soliloquio intimo, instancabile. Tra le pagine scorre una voce straordinaria che senza eccessi indaga i moti dell’animo, l’atto di negazione per potere resistere al male e così esistere, il rapporto di suo padre con il proprio padre, l’incontro tra i suoi genitori, l’evoluzione della loro relazione, l’avvento della malattia e la vecchiaia incalzante che assottiglia la pelle e i ricordi; rende la parola meno fluida e il pensiero più arduo a esplicitarsi.
Pierre Pachet, professore universitario e scrittore, critico letterario e intellettuale indefesso, rende unico l’esperimento della narrazione biografica e lo fa senza assumere il punto di vista del padre, ma entrando nella sua mente. Così facendo il timbro paterno, che lo aveva accompagnato durante la sua infanzia e giovinezza, guadagna tonalità inedite per dire quello che l’uomo avrebbe detto se avesse potuto farlo in quel preciso momento della sua esistenza nel quale questa storia ha preso forma.
Un’eredità al contrario quella che questo scrittore riconosce al suo genitore, un tributo encomiabile a quel quesito che da sempre assilla chi ha vissuto il lutto della perdita della figura maschile, l’uomo che più di ogni altro direziona scelte e plasma come un demiurgo la personalità di ogni essere umano: cosa si perde quando si perde un padre?
Nella splendida postfazione di una sempre puntuale Liza Ginzburg la risposta. “Quello che si perde è una voce… Il lascito starebbe dunque in sonorità divenute interiori perché introiettate giorno dopo giorno sin dall’infanzia, e che Pierre Pachet re-intona traslandole sul timbro di suo padre, la cui voce – ora aveva missione esorbitante: raccontarsi in tutta la propria ampiezza, rigenerarsi in assoluta solitudine, assumersi intera la responsabilità della propria esistenza.– ”
Angela Vecchione

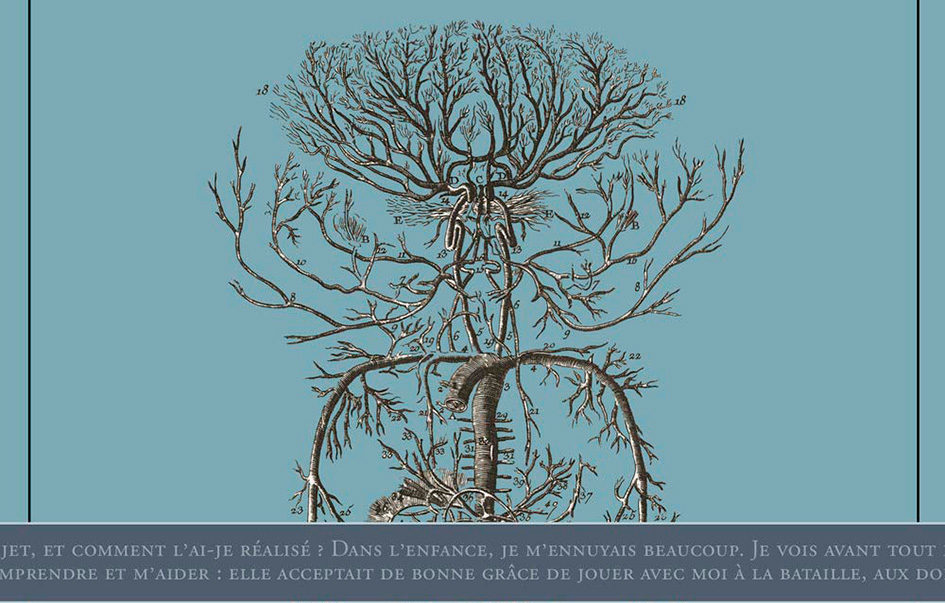
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?