Seguire le sorti del romanzo è abbastanza noioso soprattutto quando si comincia a farne l’obituario, suscitando una reazione di déjà-vu, a parlare in modo più soft di “crisi” della narrazione (Byung-Chul Han), specie di anticamera della fine o dell’inizio, a schierarsi contro chi ne fa il funerale, fino a difenderne come una paladina la sua integrità, perché “il romanzo non deve morire” (come ci ricorda Giulia Caminito nel suo contributo alla recente edizione del festival Multipli Forti, tenuto dall’Istituto di cultura italiano di New York, e apparso su La Stampa). Ma ritorniamo all’inizio o ad uno degli inizi, a quel momento in Francia in cui si comincia a teorizzare quello che poi di lì a poco sarà chiamato il “nouveau roman”, dando oramai per scontata la morte del romanzo ottocentesco. Negli anni Venti sulla rivista Transition esce il manifesto “Le roman est mort, vive le roman”. Se prima c’era stato Zola ora ci sono André Breton, il Joyce di Finnegans Wakes e non solo, Beckett, Breton assieme ai surrealisti, Gertrude Stein, la stessa Woolf, così come appena prima c’era stato Marcel Proust. Sulle ceneri del romanzo simbolista, dopo il surrealismo, in quel letto preparato dalla nuova filosofia del dopoguerra (l’esistenzialismo), l’insofferenza per il romanzo tradizionale è sempre più sentita. Attorno alle figure di scrittori e intellettuali come Robbe-Grillet, Natalie Sarraute, Claude Simon ma anche Duras, Queneau, ecc. si forma quello che prende il nome di scuola del Nouveau Roman. Nel corso degli anni Sessanta e settanta il dibattito francese arriva in America dove nelle università nasce la famosa French Theory, anche grazie ad autori come Susan Sontag, che imbevuta dell’esperienza artistica francese, da Barthes alla nouvelle vague passando per Foucault, chiamerà a quella rivoluzione della sensibilità artistica che va sotto il nome di Against Interpretation. Ma questo è già l’inizio di un’altra storia. Il punto d’arrivo sarà una nuova morte e l’occasione per una nuova rifondazione in questa ruota che gira.
“Novel is dead” è soprattutto un’affermazione tronca, il preliminare necessario per riformare e ricominciare daccapo, ben consapevoli quindi che se un certo tipo di romanzo, quello cosiddetto realista e naturalista della grande tradizione francese, è finito assieme alla società che lo ha prodotto e animato, il romanzo come grande contenitore di storie è destinato a seguirci fin dove chi verrà dopò di noi andrà, specchio meraviglioso dei nostri limiti più che delle nostre capacità in un determinato periodo storico. Dire che il romanzo è morto è una messa in scena, un melodramma. Alle ossessioni di un’epoca si sostituiscono quelle della successiva, in una rivisitazione continua di quell’antica querelle tra antico e moderno. Noi che ci struggiamo tra quei soliti due estremi, la nascita e la morte della tragedia, del romanzo e di noi stessi (da La nascita della tragedia di Nietzche a “The death of tragedy” di Susan Sontag).
A rileggere quel manifesto apparso su Transition mi viene da sorridere, con tutta quella enfasi sul futuro, ma anche i semi della direzione che seguirà. La notte che entra nel romanzo, l’inconscio, la magia, la lenta (davvero lenta) ma necessaria distruzione dell’eroe, alter ego dello scrittore, facile da teorizzare ma più difficile da mettere in pratica. L’antiromanzo che va nascendo negli anni Cinquanta e sessanta, per tentativi, ma anche e soprattutto spontaneamente, non solo in Francia, passa per quello che continuiamo a chiamare decostruzione (della linearità di una storia, dei personaggi, del rapporto tra autore e lettore), la sperimentazione sulla voce narrante e la fine di quel narratore omnisciente così insopportabile. Ma soprattutto per una specie di disillusione che abbiamo portato alle estreme conseguenze. Per dirla con Sarraute (che a sua volta ha una visione personale e non completamente allineata all’école del romanzo) “life is not that life like”.
Oggi in quest’epoca cosiddetta “post-narrativa” in cui alla comunità narrativa si è sostituita la community, ovvero una comunità di consumatori (come argomenta Byung-Chul Han), non so quanto sia necessario o piuttosto artificioso cercare nuove strade per raccontare nuove e vecchie storie. O provare a delineare e catalogare le caratteristiche sfuggenti e libere del romanzo contemporaneo (la tassonomia per fortuna è superata). Si fa il punto su quanto il romanzo abbia prestato all’autofiction (o nonfiction) -altra variante dell’autobiografia o del memoir (che quasi sarebbero delle sottocategorie con caratteristiche proprie) – per poi riprendersele in una specie di rivincita in una curiosa storia di rivalsa e “empowerment”. Come scrive Claudia Durastanti nell’ultimo numero della Berlin Review, sarebbe una questione di “percentuale” maggiore o minore di non-fiction diluita nel romanzo in una ricetta ideale che porterebbe sulla strada di un nuovo romanzo. In questo strano esercizio di spostamenti di pesi ed originalità, compare poi la “scrittura femminile”, come vettore capace di plasmare il romanzo del futuro.
In occasione della riunione del circolo filologico miumiu, Sheila Haiti, scrittrice canadese (su Lucy sulla cultura), ha parlato della “scrittura femminile”, come tutto quello che non rientra nella scrittura maschile, nel canone: una liberazione ed emancipazione dallo sguardo maschile sulla realtà, quasi quel pezzettino di realtà sottratto al dominio maschile, per accedere ad una visione più completa del mondo. In una parabola che va dall’entusiasmo per Sibilla Aleramo de Alba de Césped fino a Rachel Cask e al suo ultimo libro (Maternità di Sheila Heti pubblicato in Italia da Sellerio). La scrittura femminile (l’écriture feminine o écriture-femme) però viene da quella stessa avanguardia di cui parlavo all’inizio. Anche se in questo caso è necessario piuttosto un movimento contrario a quello dell’avanguardia: ritornare indietro, proprio a quelle scrittrici e poete di fine Ottocento, inizi novecento (dalle Bronte a Dickinson) che già scardinavano da dentro il romanzo ottocentesco o avevano sempre praticato un’altra via. Passa per le opere di Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, per la teorizzazione ad opera di pensatrici femministe radicali e separazioniste come Helene Cixous (la stessa che già aveva previsto che in qualche modo la scrittura femminile avrebbe liberato anche l’uomo), e Luce Irigaray (Speculum), fino ad arrivare a Julia Kristeva. Nasce anzitutto come necessità di smontare la costruzione patriarcale che stigmatizza e declassa la letteratura di donne, da donne o per donne, come genere letterario minore. In Italia in quegli anni Settanta in cui si teorizzava senza teorizzare la scrittura diversa, femminile, c’è stata Carla Lonzi, che mi interessa qui proprio come interprete (la critica d’arte autrice di Autoritratto) che porta il femminismo nella critica, sperimentando nella critica l’abbandono di ogni forma di sapere istituzionalizzata, per spostarsi al linguaggio imprevisto, improduttivo, creativo. Arrivando a noi, sicuramente è stata Sandra Petrignani ad aver indicato la strada e ad essersi avvicinata alla scrittura femminile in un modo nuovo, con una nuova scelta estetica. Perché la scrittura femminile più che una serie di caratteristiche condivise dalle romanziere è anche e soprattutto un modo diverso di raccontarle, di rileggerle, di interpretarle, entrando nelle loro case, e stanze come entrando nelle loro frasi per suggerire quel femminile che si capta e che fugge.
A questo punto forse meglio arrendersi e confidare che uno scrittore è fattore e fattrice di un frammento di realtà, del suo personalissimo posto nel mondo, in un equilibrio precario e meraviglioso tra quei due estremi “non troppo vera perché il vero è mobile e ti scappa sotto gli occhi; non troppo falsa perché se no a che serve?”, come ci dice Domenico Starnone in quella sua riflessione sull’arte che è anche Via Gemito. E lì, nel giorno del dubbio scrivere quella storia che ci riguarda, tutti.
Forse, più che cercare i contorni del nuovo romanzo, sarebbe più interessante chiedersi quale debba essere il posto del romanzo in questo nuovo mondo in cui le tecnologie hanno alterato tutto, non solo come comunichiamo ma peggio ancora ciò che comunichiamo. Soffermarsi sul ruolo dell’editoria pronta a pubblicare tutto pur di fare numeri, quell’editoria che sembra sempre più una industria cinematografica, con i reel per la promozione delle nuove uscite e le serie prodotte da Netflix, con la proliferazione di podcast e altri format che ci allenano ad evitare ancora e ancora il gesto della lettura. E soprattutto sul ruolo della critica letteraria.
La critica quella capace di restituire potere alla lettura e ristabilire la bilancia tra libri e lettori (che faticano sembra, che sono meno dei libri che si producono), potrebbe compiere un’addizione più che una sottrazione, aggiungere un sovratesto piuttosto che scavare tra le righe in cerca del cuore, del sottotesto, di quello che lo scrittore voleva dire per davvero. Muoversi più che tra i significati (il “vero” significato del romanzo) su un altro terreno: tra suggestioni, sensazioni e connessioni. E da lì, da quel posto in cui si arriva con un po’ di tempo, di lavoro, ma anche devozione e ossessione, invitare alla lettura.
Ma in fondo anche io non sto dicendo niente di nuovo e vi sto annoiando. Era il 1966 e Susan Sontag aveva già, tra grandi ambivalenze, spostato l’asse della discussione dal romanzo alla sua ermeneutica.
Silvia Acierno

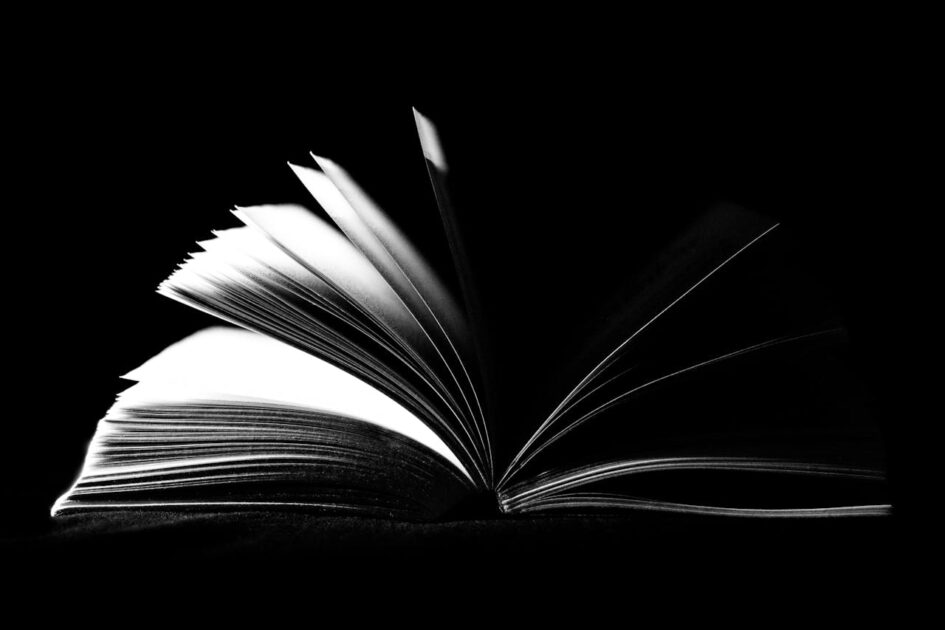
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?