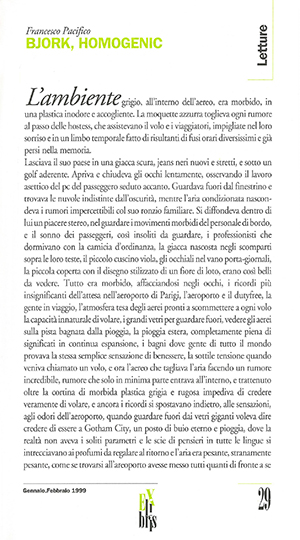
Numero 16 | Gennaio-Febbraio 1999
L’ambiente grigio, all’interno dell’aereo, era morbido, in una plastica inodore e accogliente. La moquette azzurra toglieva ogni rumore al passo delle hostess, che assistevano il volo e i viaggiatori, impigliate nel loro sorriso e in un limbo temporale fatto di risultanti di fusi orari diversissimi e già persi nella memoria.
Lasciava il suo paese in una giacca scura, jeans neri nuovi e stretti, e sotto un golf aderente. Apriva e chiudeva gli occhi lentamente, osservando il lavoro asettico del pc del passeggero seduto accanto. Guardava fuori dal finestrino e trovava le nuvole indistinte dall’oscurità, mentre l’aria condizionata nascondeva i rumori impercettibili col suo ronzio familiare. Si diffondeva dentro di lui un piacere stereo, nel guardare i movimenti morbidi del personale di bordo, e il sonno dei passeggeri, così insoliti da guardare, i professionisti che dormivano con la camicia d’ordinanza, la giacca nascosta negli scomparti sopra le loro teste, il piccolo cuscino viola, gli occhiali nel vano porta-giornali, la piccola coperta con il disegno stilizzato di un fiore di loto, erano così belli da vedere. Tutto era morbido, affacciandosi negli occhi, i ricordi più insignificanti dell’attesa nell’aeroporto di Parigi, l’aeroporto e il dutyfree, la gente in viaggio, l’atmosfera tesa degli aerei pronti a scommettere a ogni volo la capacità innaturale di volare, i grandi vetri per guardare fuori, vedere gli aerei sulla pista bagnata dalla pioggia, la pioggia estera, completamente piena di significati in continua espansione, i bagni dove gente di tutto il mondo provava la stessa semplice sensazione di benessere, la sottile tensione quando veniva chiamato un volo, e ora l’aereo che tagliava l’aria facendo un rumore incredibile, rumore che solo in minima parte entrava all’interno, e trattenuto oltre la cortina di morbida plastica grigia e rugosa impediva di credere veramente di volare, e ancora i ricordi si spostavano indietro, alle sensazioni, agli odori dell’aeroporto, quando guardare fuori dai vetri giganti voleva dire credere di essere a Gotham City, un posto di buio eterno e pioggia, dove la realtà non aveva i soliti parametri e le scie di pensieri in tutte le lingue si intrecciavano ai profumi da regalare al ritorno e l’aria era pesante, stranamente pesante, come se trovarsi all’areo porto avesse messo tutti quanti di fronte a se stessi, a pensarsi intensamente, a proiettarsi un po’ oltre il presente, a guardarsi indietro, a pensarsi guardato da un cittadino di qualunque altro paese di qualunque altro continente e chiedersi che cosa rappresento per lui, anche delegato, guardare i diversi modi di fare, e per un momento essere tesi, e il momento dopo essere in una nuova pelle, già stanchissimi.
Dopo aver trascorso il Natale, tra estranei non più estranei, dopo aver discusso l’appartenenza al proprio gruppo, dopo aver vissuto in un altro corpo, il corpo di uno straniero, dopo aver segnato sui foglietti dell’albergo appunti di cose da ricordare, per ricordare di essere stati in un altro modo. Camminare in un posto mai visto prima e ammettere di non riuscire a immaginare che davvero per qualcuno quella sia la casa, e nel frattempo essere in parte desiderosi di sapere cosa si prova, a guardare le cose di colpo da lì, invece che da dove sei partito. Le buste dei regali, adagiate nella valigia, con la loro plastica spessa pochissimo familiare, e di colpo anche familiare, come se tutto venisse discusso proprio adesso, nell’aereo era soprattutto bello guardare il silenzio degli altri, il modo in cui ogni persona si sistemava nel suo posto, nella sua piccola nuova casa per qualche ora, come accomodava il cuscino, come decideva cosa leggere, se lavorare, se pensare, se rischiare di pensare se stessa, di guardarsi nel finestrino ovale e chiedersi da quanto tempo non ci si sentiva così individui, non si sentivano i propri pensieri girare per tutto l’aereo senza disturbare nessuno ma liberandosi sgranchendosi, tingendosi di un’emozione senza polo, assoluta, se si potesse girare all’infinito, da un aeroporto all’ altro, senza dire niente, senza parlare con nessuno, o per lo meno chiedere di avere il tempo necessario per ritrovarsi un po’, e camminare su quelle moquette fino ad allora.
Il film proiettato sul telo bianco, le cuffie di plastica viola, l’uomo accanto con un walkman sottilissimo per minidisc e tutta l’aria di ascoltare perfettamente Homogenic,
a Tokio dovrò fare la fila per il taxi,
vorrei essermi dimenticato com’è la mia casa,
per un attimo l’odore mi invaderà le narici,
nuovissimo e vecchissimo, estraneo e innestato in me,
come una discendenza,
ma chi discende da chi?,
e scritte, tutte queste cose sembreranno meno belle,
a meno che il mio cd portatile mi entri nella pelle
e suoni ancora.
Francesco Pacifico

 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?