Quando ho preso in mano Lettere a mia nonna, di Djamila Ribeiro, il mio approccio era quello classico da lettrice appassionata di storie di famiglia che si tramandano da una generazione alla successiva. Insomma, ero pronta a trovare profumi legati a eventi o persone passate; ricordi di foto con parenti più o meno conosciuti, con sorrisi a riflettere vite o nascondere difficoltà, le cui esistenze e movimenti nello spazio hanno segnato momenti importanti nella vita dell’autrice; aneddoti divertenti, scandalosi, difficili da credere; perle che altrimenti sarebbero dimenticate. E, in effetti, è stata proprio una foto di dona Antônia, la nonna dell’autrice, ad accogliermi, vestita con gli abiti tipici del candomblé, come ho scoperto alla fine del volume grazie al piccolo testo di approfondimento di Francesca De Rosa, insieme ai traduttori Alessia Di Eugenio e Nicola Biasio. Tutto filava secondo le mie aspettative. Poi ho iniziato a leggere.
E le parole di Djamila Ribeiro, rivolte alla nonna come a tutti noi, mi hanno messo davanti agli occhi sì una storia familiare, ma soprattutto una riflessione su quanto sia difficile, anche emotivamente, ma imprescindibile rinegoziare la propria libertà tanto per l’individuo quanto per un’intera comunità. In questo caso, tanto per le donne nere come per la comunità afro-brasiliana, che in queste pagine si fanno spazio per raccontarsi e trovano una voce. Scrivendo lettere alla nonna mancata da tempo, l’autrice racconta la storia di tre donne (lei stessa, dona Antônia e la madre, dona Erani) che è anche specchio di quella che viene definita nella sinossi una “genealogia collettiva familiare e degli oppressi”; un termine che a mio parere esprime bene il tema di fondo dell’opera, e ripropongo qui.
Nei suoi ricordi della nonna, che “sanno di mango verde e torta alla zucca”, che hanno “il profumo di fagioli e di cena alle sei del pomeriggio”, Djamila Ribeiro fa emergere una donna che, pur non essendo schiava, di fatto passa la propria vita come domestica per datori di lavoro bianchi. Nelle memorie della madre, fatte dei rossetti e dei curatissimi vestiti di lino, dei profumi di sottomarca che indossava nelle rare uscite con le amiche e dei prodotti con cui puliva alacremente la casa, c’è il desiderio di difendersi dai possibili pregiudizi delle persone del loro quartiere di Santos, prevalentemente bianco. E c’è la sofferenza per i tradimenti del padre delle sue figlie, che nonostante sia un buon genitore e porti avanti cause politiche giuste, appare come un marito e compagno assente.
Le lettere in cui Djamila Ribeiro racconta della sua infanzia e adolescenza fino al suo diventare accademica e attivista, di dona Erani e di dona Antônia, offrono tuttavia una storia che affianca quella di esclusione e violenza collettiva che la comunità afro-brasiliana ha visto perpetuare nei suoi confronti nel corso dei secoli, e ne va al di là. Certo, è un racconto di donne nere e della loro difficoltà ad assicurare ai propri figli, e soprattutto alle proprie figlie, un futuro completamente libero dal punto di vista sentimentale e professionale nel Brasile tra la seconda metà del Novecento e l’inizio degli anni Duemila. Ma è anche un racconto di riscatto e di valori che vengono portati avanti di generazione in generazione: l’amore trasmesso attraverso parole, gesti e spiritualità; la ricerca di dignità e l’autodeterminazione che le donne della famiglia di Djamila Ribeiro fanno arrivare fino a lei, e che lei passa in eredità alla figlia Thulane.
Vorrei chiudere quello che è più un cocktail di impressioni che una recensione vera e propria con un’ultima immagine, tratta dal libro e a mio parere l’essenza delle 190 paginette scarse che la filosofa brasiliana ci regala:
Al funerale di mia madre, la mamma di un’amica mi disse: «Non piangere, devi essere forte per i tuoi fratelli». So che non lo disse con cattiveria, ma quanto è crudele dire a una giovane di vent’anni che non può piangere la morte di sua madre? E in più: che deve essere forte?
Questa immagine della donna nera forte è molto crudele. Le persone si dimenticano che non siamo naturalmente forti. Dobbiamo esserlo perché lo Stato è negligente e violento. Restituire umanità significa assumere fragilità e dolori propri della condizione umana. Siamo rese subalterne o siamo dee. Io chiedo: quando saremo umane?
Fabia Brustia

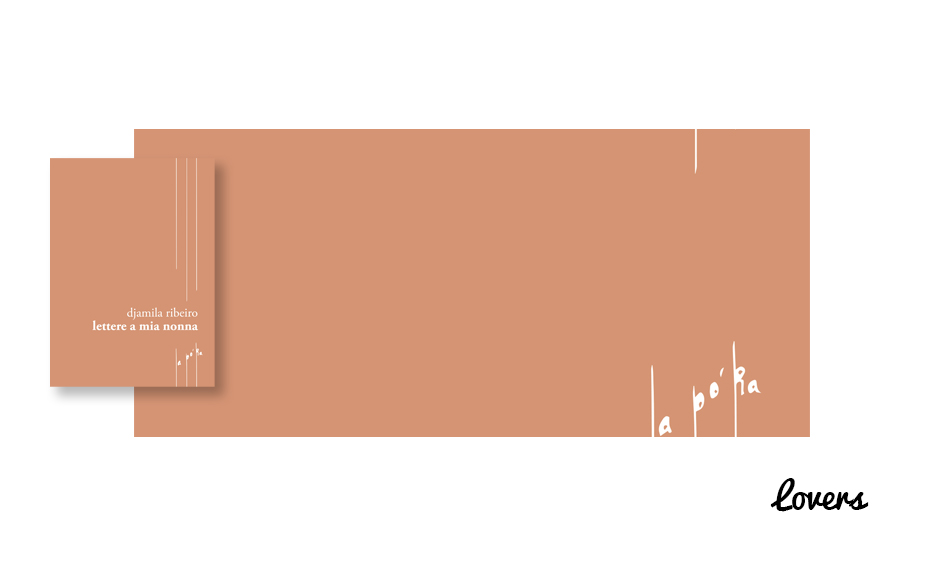
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?