Il nuovo racconto uscito dalla penna di Alessandro Baricco, Abel, edito da Feltrinelli, si inserisce con continuità e coerenza nella produzione del suo autore, e tutto quello che, iniziando la lettura, potrebbe spiazzarci, rientra poi, in modo evolutivo, nei canoni e nei totem che lo scrittore ha da sempre, e forse del tutto spontaneamente, scelto per la sua creatività. L’ambientazione “western” in cui si svolgono le imprese del protagonista, lo sceriffo Abel Crow, non è parsa così distante dai luoghi prima simbolici, immaginali, e solo dopo inseribili in un contesto di realtà e storia, che hanno accolto altre scritture: il Cristal Palace, le praterie domate dal treno in Castelli di Rabbia, la locanda Almayer unico approdo in mezzo all’Oceano Mare, il Giappone di Seta, la nave-mondo su cui cresce Novecento. Forse ciò che fa la distanza di questo Ovest dagli altri luoghi, ci è evidente subito, dalle prime righe, è il suo essere, nel tempo del racconto, infinito e indomabile per l’uomo, patrimonio di una natura più saggia e istintuale di quanto qualsiasi umano possa ambire a essere. Perché in ciò che narra il protagonista della sua vita e della sua famiglia – balzando avanti e indietro in un tempo che non è possibile imbrigliare, mantenere consequenziale – si fa chiaro da subito che né la filosofia, né la scienza e la ragione, ma neppure l’esperienza, possono arrivare al livello di pura mistica che solo possiede la natura, e coloro che con lei hanno fatto un patto di non belligeranza. Eppure, il romanzo della famiglia Crow inizia, e il narratore ci dice subito che questo indomabile spazio è ora sondato, e come tale, perduto. “Quegli spazi che giacevano muti, ai margini del conosciuto, nel profondo Ovest, ora non esistono più, sono finiti.” Dal momento che “siamo già stati dove non siamo mai stati, e anzi, a dirla tutta, veniamo da lì” Abel ci rivela dopo poche pagine che, della possibilità che ha l’uomo di mantenersi largo nell’indefinito, molteplice di connotazioni che gli sfuggono, egli stesso non sa fare tesoro. Non si parla qui come nelle prime opere di tecnologie, scoperte, imprese che domano la natura, ma della natura che accoglie e cura l’uomo solo quando egli stesso è disposto a riconoscerla come unica sovranità. Il “West” rimanda in questo racconto a quello letterario e cinematografico che conosciamo, ne mantiene le luci, la polvere su cui si scrivono le traiettorie umane, e ci sono (ovviamente, dice Baricco) i selvaggi. Sono loro a possedere la vera conoscenza: la bruja, che sa aggiustare i destini, i Dakota, gli Absaroka che “quasi con noia” scannarono il padre del protagonista. “Infine, che cosa sia il respiro del mondo l’ho capito in un villaggio Pajute, l’inverno che passai lì a morire, e morire ancora e poi a vivere”, dice Abel.
Ad amministrare la vita e la morte non è il dottor Wood, la cui figlia, la selvatica e indomita Hallelujah, entra ed esce dalla vita di Abel con poche parole, mantenendo distanze spaziali che permettono di convivere con la sua attività di pistolero, e di rimanergli vicino al cuore. Il Maestro, che conosce le geometrie delle traiettorie, che si fa leggere i libri per ripassare il sapere dei mistici e dei sapienti, crede nelle intenzioni ma non possiede gli intuiti. Il giudice, che si illude di possedere le leggi, sembra altrettanto incapace di amministrare le regole nella vita dell’uomo. L’intuito necessario a comprendere i misteri del vivere lo possiedono i cavalli bagnati che lottano contro la fatica e il fango, le praterie vessate dalla furia degli elementi, il mare, da qualche parte, le “impervie montagne verso la pancia del paese”, che incoronano il ventre del territorio, “le pozzanghere lasciate indietro dall’uragano in fuga”, dove si specchia il cielo e “il racconto di quello che sei stato”.
“A quella distanza che cosa puoi fare se non sparare?” Lo sparo partito dallo Sharps del padre di Abel sfiora il fratello David come una carezza, ed è l’unica possibilità di vicinanza tra qualcuno che fugge lontano e chi non può più fermarti. Nell’andirivieni temporale della storia, conosciamo tutti i membri della famiglia Crow. Quello che pare un gruppo slegato e sfrangiato, si ricompone come unità, ha un’appartenenza e trova il collante nell’impresa che cerca di salvare la madre, fatta prigioniera a Yuba.
Le città sono fantasmatiche, possiedono una vena dove scorre il sangue, la Main Street, e dalla quale il sangue si svuota verso l’altrove. Possiedono chiese che non sono luoghi dello spirito, le città, sono trappole, sono assiomi ai quali non credere, non posseggono la poesia della vita, che Baricco riserva, anche linguisticamente, alle sconosciute norme di ciò che non abbiamo appreso, e non possiamo apprendere: l’infinito. In Abel, lui che ne è indubbiamente un maestro, riesce a conservare il registro evocativo e visuale che conosciamo del suo scrivere. Le pause, che prima “suonavano” di molte reminiscenze, ora si sono fatte più secche, amplificano il suono di ciascuna parola, creano un’eco che la fa rimbombare e la rende più pregnante. C’è un po’ di realismo magico, tra queste pagine, ed è forse la dimensione che più di tutte contiene la verità. Non è esagerata, è più pacata l’invenzione – la cosa “pazzesca” per dirla con un termine molto caro all’autore – rischia di essere più sobria dei fatti scarni. C’è un filo rosso, nell’opera di Baricco, che ci porta alla fine di questa storia, e ci fa chiudere il libro senza rimanere delusi.
Anna Bertini

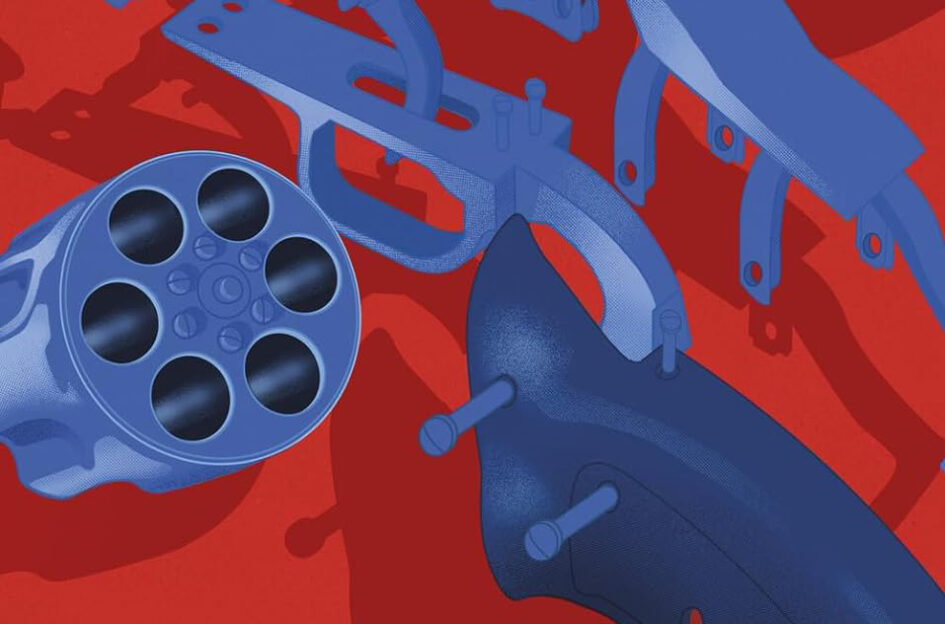
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?