‘’Tu vieni accusato, ingiustamente, di essere un maestro nel fare affiorare la bruttezza e nello scavare sempre più a fondo. Nulla di più sbagliato! In letteratura, infatti, o meglio, in tutti i campi della vita, gli ossimori sono indispensabili, e noi non potremmo comprendere e goderci la bellezza se non conoscessimo il suo contrario. E persino la bruttezza, in te, Hassan, è diversa, trasuda umanità, e questa è la cosa che ti invidio.“
Hassan è la voce che racconta e si racconta in Allah 99, testo collettore di esperienze e di contrasti, di alto e di basso, pubblicato da Utopia Editore, nella traduzione dall’arabo di Barbara Teresi. È un ex veterinario, le cui vicende biografiche rifrangono quelle dell’autore, fuggito dal fuoco, prima della guerra poi delle faide religiose, dalla caduta del dittatore all’arrivo dell’ISIS, della sua Baghdad verso il ghiaccio di Helsinki. Nella nuova esistenza il suo pensiero è sempre rivolto alla ‘Mezzaluna fertile’ (fertile di atrocità) che si è lasciato alle spalle: non dimentica di vivere in tempi strani in cui ‘circola oramai cattiva moneta’, tempi di rettili velenosi che si credono enormi solo per essere imparentati con i dinosauri, benché estinti. Come non dimentica che estirpare le proprie radici per piantarle altrove, sotto la consolatoria etichetta di: rifugiato, non significa abbandonare l’antica medicina che ha sempre con sé, la scrittura, quella che interroga e registra con una razzia di parole, quella che, per dirla alla Voltaire, è la pittura della voce, in queste pagine spesso dispersa e inascoltata. Così apre un blog, il cui titolo provocatoriamente si rifa’ ai 99 nomi del Profeta, per accogliere altrettanti nomi e storie frutto delle sue interviste a chi come lui ha abbandonato la propria patria o a chi vi è rimasto. Sentire parlare e ricordare gli altri, mentre sono sul ciglio del burrone del ricordo o nell’angolo di una esistenza riciclata o adattata, è un balsamo per Hassan per dare continuità e senso alla sua scrittura, nonostante i tanti ottundimenti che si impone spesso l’uomo solo. E, pure in presenza di parole arrotate ma scolpite di umanità, come gli fa notare un suo interlocutore nella citazione riportata, in lui sono vive sia la gratitudine per chi decide di rispondere alle sue domande sia la consapevolezza che qualcuno sta aspettando di leggerlo.
Tra le voci intercettate c’è l’ex infermiera che si rifugia nell’antro arrabbiato e oscuro della musica techno e diventa DJ a Berlino dove può ballare e fare ballare, con un intento compensatorio, al suono di quelle note che tanto apprezzava il compagno ucciso dall’ISIS. C’è un artigiano che realizza maschere mortuarie che riproducano le fattezze dei volti non ancora deturpati dal fuoco delle autobombe, degli attentatori suicidi e delle esecuzioni perché i familiari hanno bisogno di accomiatarsi da visi riconoscibili. E passando alle nuove generazioni, spesso propensi a mettere in burla ciò che fa soffrire gli altri, c’è un designer che si inventa un videogioco in cui i viaggi clandestini dei profughi sono controllati da una figura alla Trump, sferzante trasposizione di quei percorsi verso Occidente che hanno il colore dell’orrore e l’odore dell’incertezza. E ci sono tante altre storie in queste pagine che fanno da cassa di risonanza ad un mondo che non c’è più. Ma, benché lontani, nel testo si torna sempre a Baghdad, a quel molosso sul Tigri che non sarebbe sé stesso senza un pizzico di allucinazione, a quella città che, in fondo, è rimasta sempre la stessa, è solo invecchiata, i suoi colori sono sbiaditi, i capelli le si sono riempiti di armi e sotto gli occhi le è comparso un alone scuro di terrore e sofferenza. La sua gente continua a risparmiare soldi per pagarsi un posto sull’Arca di Noè dei trafficanti di rifugiati e i suoi marciapiedi, che si sono adattati alle metamorfosi della capitale, offrono, minimarket h24, tutti gli accessori di vita e di morte.
Con la sua struttura labirintica e la sua prosa veloce e graffiante, che dà l’idea, nell’esperienza di lettura, di un lavoro in corso, non ancora concluso, Allah99 accoglie pagine di meraviglia e repulsione, erudizione e oscenità, quieta contemplazione e improvvisa violenza. Le quali sono inframezzate, quasi come aree di sosta, come un momento per ‘riveder le stelle’ prima di riprendere la discesa nei gironi infernali, dai testi delle e-mail che Hassan riceve da una donna intellettuale che sta per spegnersi. Si tratta di un’enigmatica mentore, traduttrice in arabo di Cioran, lettrice e filosofa, le cui parole, auliche, ispirate e interroganti, fanno da contrappunto ai dialoghi su disastro, morte e sesso di cui la scrittura non si priva. Le e-mail vengono riportate ma senza le risposte del protagonista. Una scelta sintomatica, questa, che conferma l’intenzione di Hassan Blasim di lasciare spazio, come nelle interviste, all’interiorità dei suoi interlocutori: devono essere loro a parlare e non altri al posto loro, come spesso succede. Sono parole che devono quindi avere il proprio spazio, che potrebbero andare all’infinito perché 99 è un numero troppo risicato per racchiudere la molteplicità di esperienze del rifugiato. L’intertestualità va ancora oltre. Il narratore ha infatti in Palomar, osservatore del mondo e delle persone, un interlocutore immaginario, una sorta di coscienza critica. E il testo di Calvino è l’unico libro che Hassan porta con sé nella sua traversata migratoria verso la Finlandia, un libro rifugio come Dante per Primo Levi, in quella che si configura non tanto come una lunga marcia per raggiungere, passo passo, la saggezza ma una discesa nell’abisso delle atrocità che gli uomini sono capaci di commettere nei confronti di altri uomini.
Dunque più nuclei narrativi che si intersecano e che rendono questo libro polifonia e testimonianza. I quali si avvitano su due convinzioni di fondo che attraversano il testo: una sul ruolo di chi si rifugia in un altro paese e l’altra di chi lo fa nelle parole scritte. Un rifugiato è sempre una persona in precario stato di equilibrio, come se non bastasse ciò che si è lasciato alle spalle. Ha un piede nel nuovo paese in cui è riparato e l’altro sollevato pronto a tornare in una casa che potrebbe non esistere mai più e ‘’siede nella valletta dei salici e torna a riprendere ancora il suo arduo mestiere: sperare’’ come ricordava Brecht. Di più: un rifugiato porta dentro di sé i cocci di una vita distrutta e si trova al contempo a vivere in un’altra terra da colpevole perché spesso gli occhi degli altri lo leggeranno come nuovo invasore, per giunta arretrato e infido. In qualche modo gli si chiede di cambiare pelle ma non gli si dà il tempo di elaborare il trauma. Inoltre scrivere Allah 99, censurato nei paesi di lingua araba, è un riuscito atto di rivolta contro chi ha perso la speranza di una nuova letteratura araba che sappia sprigionare scintille, benché la sua legna sia umida e tarlata dopo essere stata stipata per anni in cantine buie. Una letteratura che può raccontare la storia di un gabinetto chiuso accanto a una sull’infinito del cosmo e che, allo stesso tempo, mescola l’inquietudine grottesca e lo sferzante realismo come nella storia dell’eroe di Gogol’ a cui è stato rubato il soprabito, la propria identità, all’attesa snervante di chi aspetta Godot. Leggere Blasim è l’unguento che lubrifica le giunture della vita e non lascia che si formi la ruggine del facilmente rubricabile perché non ci riguarda, è la vendetta indiretta di coloro che trovano la vergogna insopportabile e che usano le parole per ribellarsi, è la fotografia di chi oggi si divide tra il non credere in niente di Cioran, perennemente insonne, e nell’osservare tutto di Palomar, perennemente in cerca.
Claudio Musso
Profilo Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002725770017
Profilo Instagram: https://www.instagram.com/claudio_musso/?hl=it

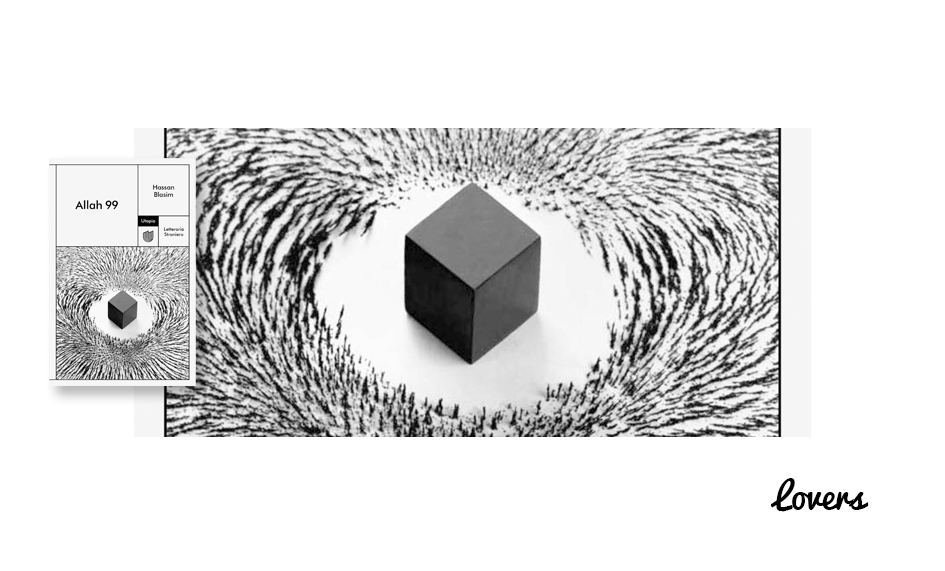
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?