Siamo nel cuore, con il defibrillatore, del nostro Novecento nel quale la storia degli uomini prende a martellate il Tempo: frammenti acuminati volteggiano in aria e lo spazio paralizzato, chiamato ancora Regno d’Italia, subisce l’8 settembre del ‘43, il giorno dell’armistizio. Quest’ultimo arriva sotto forma di urlo, verso sera, mentre c’è chi lo fugge, chi invece resta in ascolto e si ricicla e infine chi pensa all’oggi o al domani ma mai al dopodomani. Intorno a questo tempo malato, che porterà alla guerra civile, si aggira sulle prime un popolo sbandato e disorientato perché senza più punti cardinali come riferimento e poi un coagulo di diverse correnti carsiche che da decenni assistono allo sfascio del Fascio e trovano ora il proprio tempo, una nuova dimensione di esistere. E in questa lenta riscoperta di un nuovo sé ci sono i protagonisti del romanzo di Meneghello.
Questi sono gli uomini che vogliono associarsi e cominciare a agire qui e ora, sono le forze, come la foresta risolutrice che si avvicina al Re Macbeth con la corona vacillante, in cui convergono l’anarchia politica, i ladri di galline, lo storicismo crociano e l’antifascismo. Sono tutte anime che hanno in comune la viva sensazione di «essere testimoni di un singolare processo storico, qualcosa che riguardava le componenti sommerse della vita italiana». Ognuno, in qualche modo, si conta e cerca di capire da che parte stare e come starci. Ma lo sguardo si fa plurale nel tentativo di capire cosa fanno gli altri, perché in fondo, dopo anni di ideologia da masse compatte e inquadrate, fa male pensare da soli e forse solo insieme agli altri si può fare qualcosa di decisamente risolutivo.
«Spero che anche altri fossero disorientati, in Italia, a questa vigliaccata che faceva il regime di uscire dal ring senza neanche aspettare non dico il primo pugno, ma almeno che qualcuno s’infilasse i guantoni. Certo noi eravamo disorientati: il regime si squagliava come i rifiuti superficiali di un letamaio sotto l’acquazzone, e ciò che contava era la confusione in cui restavamo, la guerra, gli alleati-amici, i nemici-alleati».
Luigi Meneghello, con la sua preziosa capacità, nel Novecento letterario, di fare dell’esperienza racconto e darle un senso, ci porta in queste pagine tra un gruppo di studenti vicentini di cui lui stesso ha fatto parte. Sono giovani che hanno imparato in fretta i rudimenti della naia e a diventare uomini anzi tempo e, altrettanto in fretta, vogliono sull’Altopiano di Asiago, dove si svolgono le vicende, gridare il loro ‘no’ radicale, spazientito, a loro presente. Procedono inevitabilmente a tentoni in questa nuova fase della guerra tra disorganizzazione e improvvisazione e parecchi errori perché ognuno può nascere patriottico ma non può diventare partigiano dall’oggi al domani se, fino al giorno prima, teneva il naso sui libri universitari.
Occorre infatti prima guardare a cosa si è costretti a diventare, a sentire il bisogno di ricominciare, animati dalla rabbia ma anche dal senso di ‘salvare il paese’, poi a riconoscerlo per accettarlo. Per quanto incomba sempre la sensazione di una fine imminente, occorre darsi una mano gli uni con gli altri, tra paesani, come si fa in una calamità naturale, specie quando lo Stato non c’è più e i rastrellamenti dei tedeschi diventano la minaccia che toglie il sonno. Pertanto questi ragazzi, prima incapsulati nel regime e poi catapultati in un mondo che non si aspettano, si organizzano come possono. Incrociano le fiere formazioni comuniste che suscitano l’ammirazione generale, ma anche i ‘grandi villeggianti della guerra civile’, i figli della borghesia urbana che in quei mesi si schierano energicamente dalla parte degli angeli e domani faranno carriera nella nuova Italia.
Meneghello è stato uno di questi ragazzi che ha partecipato al moto resistenziale. Fino ai vent’anni ha conosciuto solo il Fascismo il quale per lui comincia a cadere già nel 1940 quando conosce, e sarà una figura cardine in questo testo, il suo primo antifascista. Ma la novità, se pensiamo alla letteratura precedente, è il tono che decide di adottare in queste pagine. La sua narrazione si configura infatti da un lato come cronaca autentica e dettagliata di chi ci è stato e ha visto e dall’altro come resoconto ragionato e difficoltoso, data la distanza di vent’anni dagli eventi descritti tra lucidità e annebbiamenti del ricordo, dell’uomo e scrittore che è poi diventato. Meneghello, liberando le proprie parole dal neorealismo e dalla memorialistica, separa la retorica, che è ciò che sembra bello ma non è vero, dalla verità effettuale della Resistenza con una precisa volontà etica, raccontandoci attraverso i suoi piccoli maestri come si smette di essere fascisti. E lo fa lasciandoci la sensazione di scherzare con l’orrore e il tragico della guerra strappandoci qualche sorriso.
«Quei giorni sono avvolti in un’aria di confusione; da allora ne parliamo, ne parliamo, quelli che siamo ancora qua, ma una versione ufficiale non esiste, il nostro canone è perduto, la cronologia è a caleidoscopio. Ciascuno ha le sue ancore, i cavi s’intrecciano a sghimbescio»
I piccoli maestri, con una prima edizione nel 1964 poi riveduta nel 1976, frutto di un’intensa opera di rielaborazione, si propongono di ripristinare la cronologia delle vicende nei suoi aspetti più reali. Le sue pagine sono punteggiate con forza da un approccio antieroico cristallizzato grazie all’uso di colloquialismi, insieme a un’ironia, come si è detto, sempre profonda, anche se spesso mascherata sotto forma di leggerezza. C’è molto rispetto per quanto è stato fatto dalle forze partigiane in quegli anni decisivi ma si rifiuta di proporre il mito eroico del partigiano. Si preferisce rievocare piccoli intellettuali che, come su un’isola deserta, sperimentano l’arte di arrangiarsi, nominano capo banda chi ha più cultura, chi ha più studiato, sono incapaci di accendere un fuoco normale, figurarsi quello di sbarramento, hanno in mano armi diverse ma con un sacchetto di proiettili tutti uguali, non sanno tenere a bada le proprie scappatelle come le proprie evacuazioni e rubano in modo rocambolesco pile di formaggi da donare alla popolazione locale la quale, per possibili ripercussioni, se ne libera di notte. Certo, c’è anche la violenza con il prosieguo del racconto, ma, dati questi accenti, emerge subito il ritratto di una Resistenza lontano dalla monumentalità in cui è stata confinata. Un elemento, questo, che farà storcere il naso a una parte della critica organica.
Meneghello dunque propone la sua versione, mai apocrifa, della Resistenza e lo fa in uno specifico momento della storia italiana. Prende posizione, come aveva fatto da giovane, e comincia a scrivere questo libro in anni in cui si sta sempre più diffondendo un senso comune di inutilità della Resistenza stessa fino ad arrivare al 1960, l’anno in cui il governo democristiano Tambroni viene appoggiato dai neofascisti del MSI e l’Italia intera viene attraversata dalla protesta. Meneghello, come Fenoglio, si mette a scrivere sulla Resistenza quando il nero sembra essere tornato di moda.
Questo libro è decisamente diverso da tutti gli altri che lo hanno preceduto. Non ha nulla di devozionale, gli manca, a parere della critica più attenta, quel retrogusto fastidioso che incolla al suolo delle troppo buone intenzioni la letteratura di impronta resistenziale, non propone casi edificanti, non vuole suscitare né pietà né indignazione, né commozione. Esso è invece un atto di sincerità morale, un tentativo di raccontare le cose per come sono avvenute, ma nella loro interezza, lontano dai topoi spirituali che pervasero la narrazione del dopoguerra. Con anche l’onestà di affermare: «Macché atti di valore. Non eravamo mica buoni, a fare la guerra». Nelle sue pagine Meneghello piega l’eroico in eroico-comico non per un intento donchisciottesco di contrasto ma per un innato spirito di contraddizione che sa cogliere nel reale la nota più bassa, il punto di rottura del sublime come emergenza della verità da condividere subito con il lettore.
L’autore ci porta così dietro le quinte di un’Italia costretta a ripensarsi. Dopo l’euforia attivista, quel moto popolare, anziché travolgere, di fatto travolge sé stesso e si spegne nella rassegnazione e nei bozzoli privati. Secondo lo scrittore, dopo l’8 Settembre si sarebbe dovuto proclamare l’insurrezione non la resistenza, perché la carica esplosiva era politica e non convenzionalmente militare, perché solo così «l’Italia avrebbe provato il gusto di ciò che deve voler dire rinnovarsi a fondo e le nostre lapidi sarebbero oggi onorate da una nazione veramente migliore».
Invece si passa dunque alla guerra per bande, già teorizzata da Mazzini, dove ogni uomo è creatore della propria sfera d’azione. E così fanno i giovani studenti che, come ne La Tebaide del Beato Angelico, sono i ‘piccoli’ monaci che operano isolati dal mondo e si rifugiano in anfratti e nicchie dove si creano una nuova esistenza. In un sottile gioco di richiami la Tebaide è anche una regione desertica dell’Egitto dove gli eremiti si chiudevano in preghiera in una natura aspra esattamente come quei giovani che, datisi alla macchia in un luogo inospitale, sentono il bisogno di purgarsi del fascismo che li ha plasmati. Ma la Tebaide, a ben guardare, è anche un poema di Stazio sulla guerra tra i figli di Edipo, una guerra tra fratelli, la stessa che i piccoli maestri combattono contro visi noti e dialetti familiari frapponendo tra loro e il proprio mondo il parabello:
«Questa faccenda della Tebaide c’è per me in ogni altra fase della guerra, è una componente fissa; ma qui sui monti alti si sentiva tanto di più. Era il posto migliore per isolarci dall’Italia, dal mondo. Fin da principio intendevamo bensì tentare di fare gli attivisti, reagire con la guerra e l’azione; ma anche ritirarci dalla comunità, andare in disparte. C’erano insomma due aspetti contradditori nel nostro concetto della banda: uno era che volevamo combattere il mondo, agguerrirci in qualche modo contro di esso; l’altro che volevamo sfuggirlo, ritirarci da esso come in preghiera»
Mentre altri compagni dell’università continuano tranquillamene i propri studi pianificando carriere, anche politiche, questi petits maîtres – così definiti in un saggio inglese del ‘700 i beneducati banditi da strada del tempo – cercano con le loro azioni quotidiane, in un contesto in cui la gente comune ancora si chiede se esistano per davvero i partigiani, di propugnare una nuova forma di vita. Imbevuti dalle parti vive, energiche, armoniche del paesaggio, per la prima volta si sentono veramente liberi, ben distaccati dalla pianura, arroccati sopra l’Italia, in un’altra patria, come tra le rovine di una città abbandonata ma non ancora contaminata. Sono ragazzi che preferiscono la parola all’azione, sono studenti di lettere, ingegneria e medicina che rifiutano le gerarchie militari e non si danno nomi da battaglia, sono ‘la banda del perché’ in cerca di un ‘come’.
Per questi giovani la Resistenza non è solo una crisi politica ma anche metafisica, non spaventano tanto il collasso degli istituti e delle meschine idee su cui si era fondata la realtà italiana quanto la struttura della mente stessa dell’uomo che non si è purgata del tutto dal Fascismo. I piccoli maestri credono che, una volta che la corrente si sia ritirata, essa avrebbe rivelato le saldature tra gli appigli, lo zoccolo di roccia, umido, del nuovo mondo nel suo infinito amore per la libertà propria e degli altri. Ma in fondo si sono sbagliati perché, come dimostra la realtà degli Anni Sessanta, il periodo in cui Meneghello scrive, la Resistenza non ha sradicato nel profondo la presenza fascista, si è rivelata una ‘’rivoluzione mancata’’ per l’Italia sia sul piano politico sia su quello storico.
Tuttavia essa ha rappresentato per quel gruppo di giovani che l’ha vissuta con entusiasmo e convinzione e una buona dose di approssimazione, una vera e propria rivoluzione interiore, un’occasione di rieducazione, una fuoriuscita da ciò che il giovane Meneghello definisce il «pozzo» in cui essi sono stati immersi, che permette ora di rieducarli ai veri valori della cultura italiana. «L’intera esperienza dei miei piccoli maestri», commenta Meneghello nel 1986, «si può vedere quasi come un corso di perfezionamento universitario, la conclusione della nostra educazione». In fondo quei banditi gentiluomini si sono allontanati dall’università per frequentare quella della vita.
Questo testo ha il merito di condensare nelle proprie pagine alla sopracitata prospettiva rieducativa anche l’interpretazione, nuova, dell’esperienza della Resistenza come punizione ed espiazione delle colpe della loro educazione e, forse, di tutto il Paese, entrambi macchiati dal Fascismo:
«Oggi si vede bene che volevamo soprattutto punirci. La parte ascetica, selvaggia, della nostra esperienza significa questo. Ci pareva confusamente che per ciò che era accaduto in Italia qualcuno dovesse almeno soffrire; in certi momenti sembrava un esercizio personale di mortificazione, in altri un compito civico. Era come se dovessimo portare noi il peso dell’Italia e dei suoi guai…»
Claudio Musso

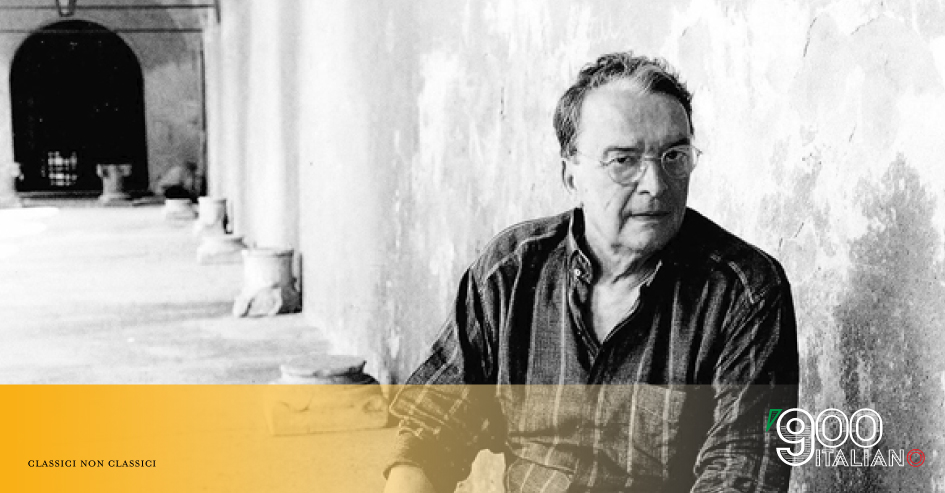
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?