La straniera è stato per me un tuffo dal trampolino nei pieni e nei vuoti della mia terra, la Basilicata, e in tutto ciò che la famiglia, i luoghi che attraversiamo e quello che scegliamo di diventare ci tolgono e ci lasciano.
In questo libro la scrittura di Claudia Durastanti è magnetica, rigorosa e pacificante.
C’è una distanza misurata tra chi scrive e la storia che si dipana lungo un’esistenza intera, tra luoghi fisici e spazi interiori sconfinati. Da Brooklyn a un piccolo paese della mia terra nella valle dov’è nato mio padre: la Val d’Agri oggi nota per i giacimenti di petrolio, le perforazioni, lo stravolgimento idrogeologico. E dove lo spopolamento, il silenzio e i colori diversi in ogni stagione – giallo intenso delle ginestre a maggio, verde brillante delle querce in primavera, grigio delle pietre nelle fiumane secche d’estate e l’oro e il rame delle foglie in autunno – sono risorsa e dannazione. La storia ci porta fin sui ponti di Roma e poi a Londra, in un ritmo cadenzato di andate e ritorni.
A me è parso che in questo racconto ironico, pacificato col passato, molto lontano dalla narrazione patinata degli itinerari turistici degli ultimi anni e degli studi antropologici ormai datati, ci sia una grande e profonda domanda sottesa, comune a quanti nascono in un luogo e poi si spostano, e poi magari tornano per poi ripartire. Una domanda universale sull’identità di ognuno di noi: cosa significa provare a mettere radici una volta e poi molte altre, provare a sentirsi accolti e allo stesso tempo rifiutati, distanti, mai del tutto parte dei luoghi in cui stiamo per scelta o per caso. Il tentativo di fare pace con l’idea che l’occupazione principale possa essere ricostruire, analizzare e interpretare codici, cercare un linguaggio e gettare ponti per sentirsi meno stranieri, per sempre.
La potenza dello spaesamento e la solitudine che ne consegue, che poi impariamo a riempire di relazioni profonde scelte con cura (e non per forza d’amore), di viaggi, di immagini del passato, di bellezza estetica e paesaggi impressi nell’anima.
Di libri, di letteratura e di storie.
Nonostante a scuola mi chiedessero in continuazione quanto doveva essere strano aver lasciato l’America per ritrovarmi in uno spazio così limitato in cui c’erano quasi più pecore che bambini, a me pareva di stare in un posto molto simile al New Jersey dove abitava mio zio Paul, un luogo di rotonde e strade laconiche e privo di centro. In Basilicata ho trovato la stessa dispersione dei sobborghi americani, lo stesso desiderio di trincerarmi in una stanza che avevano le mie cugine oltreoceano prive di un posto in cui andare che non fosse un centro commerciale o uno scantinato in cui stordirsi.
In questo libro ho trovato i pieni e i vuoti della mia terra e tutto quello che, in generale, trovi e lasci o perdi e poi ritrovi in una forma evoluta, cambiata, anche grazie alla capacità di esplorare gli anfratti della propria anima, interpretare lingue e codici alternativi, leggere episodi e comportamenti di quello in cui capiti o in cui sei nato e ti resta dentro.
La capacità di raccontare anche il dolore con ironia, con la consapevolezza che può essere un passaggio che ci ha spinti fin dove siamo. La consapevolezza orgogliosa che il dolore possa essere un momento che ci ha spinti a evolvere, altrimenti tutto si sarebbe fermato.
Il rapporto con le origini, la trama sottile che ci lega inevitabilmente a chi ci ha generati di cui siamo, in fondo, solo una diversa evoluzione.
Passeggi sulle rovine della tua famiglia e ti accorgi che alcune parole sono state cancellate, ma altre sono state salvate, alcune sono sparite mentre altre faranno sempre parte del tuo riverbero, e poi finalmente arrivi al margine di tuo padre e di tua madre, dopo anni in cui hai creduto che morire o impazzire fosse l’unico modo per essere alla loro altezza. È lì che capisci che tutto nel tuo sangue è un richiamo, e tu sei solo l’eco di una mitologia anteriore.
Lo sforzo faticoso e potente che a un certo punto facciamo nel riavvolgere il nastro, darci delle spiegazioni o fare pace con quelle che mai troveremo, che non ci coglieranno mai come un’illuminazione.
La classe sociale, la migrazione, le barriere fisiche e culturali.
La classe sociale in alcuni anni, in provincia, sono una giacca o i jeans firmati a segnare le differenze, le vacanze sulla neve a molti chilometri di distanza, i regali di Natale, i club esclusivi che i tuoi genitori frequentano o meno, la loro professione. Di fatto, però, si va tutti allo stesso liceo un’anonima costruzione brutalista, un cubo con un enorme parcheggio davanti, costretti a proseguire su un solco che sembra ineluttabile finchè non si può scegliere, magari mettendo in mezzo molti chilometri, e trovando così sulla propria strada anime che ci corrispondono e ci fanno identificare in persone con sogni e ambizioni diverse, persone finalmente libere.
Ne La straniera c’è il racconto di come scrivere storie possa essere una strada per emanciparsi dalla propria condizione, uno strumento per scegliere, una parola alla volta, la forma che vogliamo dare alle nostre esistenze.
E poi c’è il rapporto con la madre.
In un’intervista l’autrice parla così di quello che l’ha spinta a incentrare il romanzo sulla figura di sua madre: “In termini generazionali mi interessa questo amore tradito che non si trasforma mai in odio, diventa solo un rapporto in cui a volte sono più forti loro e altre volte siamo più forti noi, in un costante alternarsi di sconfitte e vittorie che è il rapporto con una madre. Una madre che vince o perde sempre è una madre finita, non ha una storia”. Non avrebbe potuto trovare parole migliori per raccontare l’altalena di abisso e di splendore che il rapporto tra una madre e una figlia riesce a generare.
Giovanna Solimando

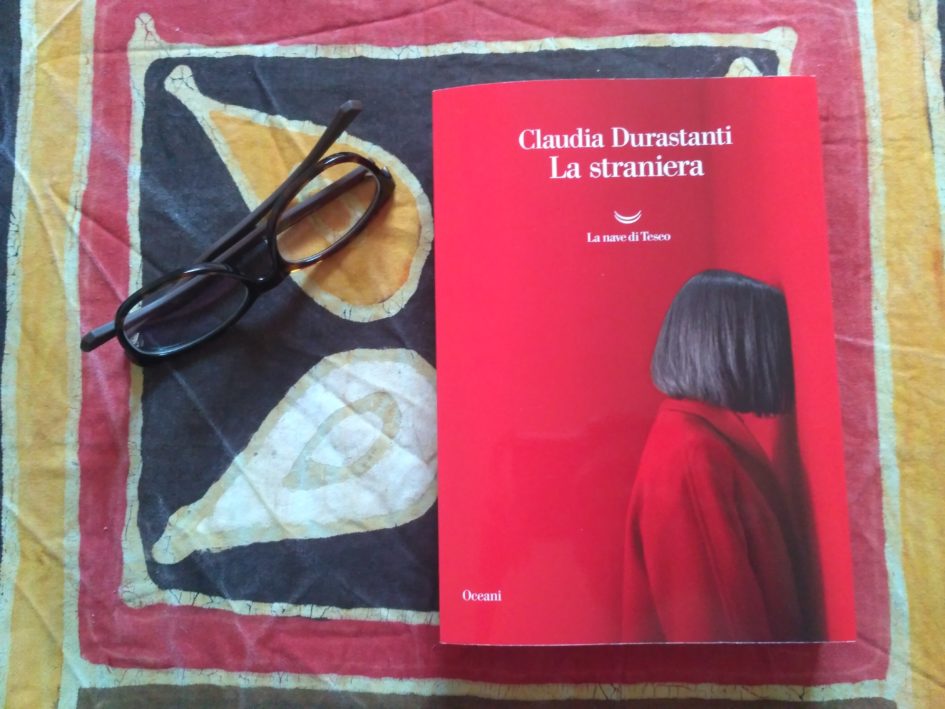
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?