
Provo, contea di Utah, nella Utah Valley: eccovi qui – benvenuti – ai piedi delle Wasatch Mountains, tra il lago Utah e il fiume Provo. È una cittadina importante, non troppo piccola e non troppo grande, piena di giovani, quasi del tutto mormone (cattolici e protestanti, una minoranza strettissima). Un centro importante, dicevo, poiché vi si trova la Brigham Young University, fondata dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni – la Chiesa Mormone – il 16 ottobre del 1875. Migliaia di giovani si trovano a Provo per questa ragione.
C’è una montagna davanti al campus, la Y Mountain, che porta su un fianco, ormai da più di un secolo, una grande e bianchissima Y – in pietre piatte e poi, più tardi, cemento, per fissarle meglio – in onore di Brigham Young, un tempo Presidente della Chiesa Mormone.
Guardate la foto qui sotto. In alto a destra: vedete la Y?
È un’attrazione turistica.


L’acqua del lago e del fiume Provo, e insieme montagne e bellissimi canyon. Sull’altra sponda del lago – sorpresa – si stende invece il deserto, “grigio e marrone e arcigno come ogni altro deserto”. Proprio il deserto. Arriva la polvere, a Provo, quando tira vento: ti finisce in bocca, negli occhi.
È una terra strana, lo Utah.
Volevo dirlo perché mi sembra importante: ogni scrittore sa bene quanto la terra dia forma al linguaggio, quanto lo plasmi e lo pieghi, quanto il linguaggio e le storie somiglino in fondo alla terra su cui accadono (il Colorado di Haruf o il Maine della Strout, il Kansas di Truman Capote).
La storia di oggi, vedrete, somiglia molto allo Utah: è spaccata in due, con la promessa dell’acqua da un lato e poi dall’altro il deserto.

A nord di Provo, dieci chilometri circa, c’è la cittadina di Orem, un po’ più piccola. Città sorelle, cresciute l’una a ridosso dell’altra.

Statali e interstatali. Provate a percorrerne una – immaginate di farlo – da Salt Lake City, sede del più vicino aeroporto, diretti a Orem e poi a Provo (oppure a Spingville o a Spanish Fork, più piccole ancora) in una bella giornata di sole, magari a bordo di un vecchio pickup, nell’aria che sa di montagne, di lago e deserto, che sa di sale e di polvere, magari accendendo la radio, intercettando una vecchia canzone di Johnny Cash.

C’è una canzone di Cash in particolare che mi piacerebbe sentiste. S’intitola Folsom Prison Blues. Chiudete gli occhi, ascoltate:
I hear the train a comin’
It’s rolling down the bend
And I ain’t seen the sunshine since I don’t know when
I’m stuck in Folsom prison, and time keeps draggin’ on
But that train keeps a rollin’ on down to San Antone
When I was just a baby, my mama told me
“Son, always be a good boy, don’t ever play with guns”
But I shot a man in Reno just to watch him die
When I hear that whistle blowin’, I hang my head and cry
Eccovi a Orem, sulle ultime note di Cash, tra le montagne, l’acqua e il deserto, e infine a Provo – la canzone è finita. Giunti in città, potreste imboccare un’ampia strada scorrevole, University Avenue, e poi fermarvi a mangiare un boccone al Table Top Dining, un locale da asporto dietro l’ufficio postale. Un piccolo diner qualunque, qualche alberello stentato e un parcheggio.
Seduti in macchina, col vostro pranzo, nel centro di Provo, vi trovereste di fronte un palazzo a tre piani, marrone chiaro e mattoni, in cui ha sede il dipartimento dello Sceriffo. Potreste dargli un’occhiata veloce: niente di particolare, in effetti, niente che attragga lo sguardo.

Poco più avanti, oltre un bel prato curato e una siepe, c’è un edificio massiccio, molto più vecchio, molto elegante, un frontone greco e colonne di pietra. Vale la pena di guardarlo meglio. È il tribunale di prima istanza della contea di Utah, è l’edificio più grande del centro di Provo.

All’orizzonte, a sinistra, vedreste invece montagne – le cime ancora innevate, facciamo finta – e il vostro sguardo alla fine potrebbe appuntarsi laggiù: aria pulita e sentieri, sbuffi di neve. Natura.
Per questa tappa del viaggio, però, sarebbe meglio guardare quei due palazzi, e guardarli a lungo. Perché è successo qualcosa, là dentro, nel luglio del ’76. C’era qualcuno, là dentro: un uomo di trentacinque anni, capelli arruffati e pizzetto, la mano sinistra ferita e ingessata, scortato da poliziotti dopo il suo arresto, in quell’estate caldissima, e messo sotto processo.

Volevo arrivare fin qui, portandovi a Provo, volevo arrivare da lui. Che ci faceva lì dentro? Aveva ucciso due uomini. No, due ragazzi. Bravi ragazzi mormoni – vent’anni, più o meno – entrambi ancora studenti, con mogli giovani, con figli piccoli. I loro nomi? Max Jensen e Benny Bushnell.
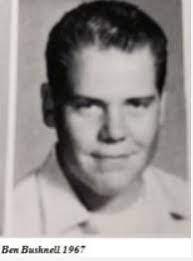

Bravi ragazzi, davvero. L’uomo li aveva ammazzati con una pistola automatica di cui si era maldestramente disfatto, buttandola dentro un cespuglio, riuscendo persino a ferirsi – era partito un colpo – lasciando la scia del suo sangue. Li aveva ammazzati senza pietà, le notti del 19 e del 20 luglio del ‘76, a Orem il primo e a Provo il secondo, in quell’estate caldissima tra le montagne, l’acqua e il deserto, in quelle notti tranquille dell’Ovest. Poi c’era stato l’arresto e quei due palazzi, davanti ai quali vi siete fermati.

Quello che invece non trovereste, neppure cercandolo a lungo, è un distributore Sinclair in una stradina di Orem: non esiste più. Lì, il 19 di luglio, è morto Max Jensen. Lavorava al distributore. Se ancora esistesse, alle sue spalle vedreste montagne.

Non trovereste nemmeno il City Center Motel, lungo una strada di Provo, non troppo lontano da dove vi siete fermati e non troppo lontano dalla Brigham Young University. Molto economico eppure pulito. È in quel motel che è morto Benny Bushnell, il 20 di luglio. Gestiva il motel con la moglie Debbie.

L’uomo li aveva freddati, dicevo, a sangue freddo: Max dentro al bagno del distributore, sul pavimento che quel povero ragazzo aveva appena pulito; Benny nel piccolo ufficio-reception, dietro il bancone. Rapine finite nel sangue. Colpi alla testa – due esecuzioni – e per nient’altro che qualche dollaro. Notti di sangue nella Utah Valley.
L’uomo si chiamava Gary. Gary Mark Gilmore.
Era uscito dal carcere tre mesi prima, uscito sulla parola dalla prigione di Marion, in Illinois, con tutto quello che possedeva ficcato dentro una sacca. Parte della sua famiglia – una cugina e gli zii – gli avrebbe offerto una casa e un lavoro.
Povero Gary, pensavano: ha trascorso in carcere quasi metà della vita – rapine e furti d’auto. Entrava e usciva, ma poi entrava di nuovo. Però non è stupido, tutto il contrario, pensavano: è intelligente e sensibile, dotato persino di un certo talento, quasi un artista.
Guarda che lettere scrive, e guarda che bei disegni.
Adesso basta col carcere, basta, pensavano: si rifarà.
È che la vita non è stata buona con lui; gli ha dato un padre violento, un impostore, un ubriacone. Un’adolescenza difficile, solo un inizio sbagliato.
Ma adesso basta.

Dalla prigione di Marion, Gary Mark Gilmore era arrivato così nella Utah Valley, tra le montagne e il deserto, dove la sabbia, nei giorni di vento, ti finisce in bocca e negli occhi. Sbarcato all’aeroporto di Salt Lake City – aprile del ’76 – con la sua sacca, un blazer marrone e scarpe nere di plastica. Libero. Salito in auto, con la cugina e il marito di lei, in una notte di aprile. Eccolo a Orem, più tardi, a casa della cugina. Eccolo a Provo, il giorno dopo, dentro il negozio di scarpe di proprietà dello zio.

Eccolo, libero, davanti al mondo, nella Utah Valley.
Non ne sapeva più niente, del mondo, oramai – sapeva solo di sbarre e di celle, d’isolamento e di rabbia, di tentativi falliti di farla finita, sapeva di serrature – eppure c’era tornato. E si sarebbe rifatto.
“È cambiato tutto”, disse Gary.
Sopra di loro c’era l’azzurro sterminato del forte cielo del West americano. Quello non era cambiato.
In quell’estate caldissima, sotto quel cielo, aveva presto incontrato una donna, Nicole: diciannove anni, già tre divorzi e due figli, piena di ombre. Un amore folle, violento e rabbioso, durato sei settimane. Non sapeva nulla neppure di quello – l’amore. Gary Mark Gilmore non sapeva più niente di niente.

Tre mesi dopo l’arrivo, solo tre mesi, aveva ucciso Max Jensen e Benny Bushnell – freddati per pochi dollari, o almeno così sembrava – ed era stato arrestato di nuovo.
Provo, per lui, sarebbe subito rimpicciolita: nient’altro che quei palazzi che prima avete guardato, lungo University Avenue. Un breve processo e la condanna a morte, la decisione di Gary di non appellarsi, lasciando che lo uccidessero, chiedendolo anzi a gran voce. L’accettazione della sua fine e l’esecuzione.
Recentemente ho cominciato a ragionare con un minimo di buon senso. Io ho un debito da saldare, da tanto tempo… Una volta tu mi hai chiesto se ero il diavolo, ricordi? No, non lo sono… Ma potrei essere più lontano da Dio che dal diavolo. E non è una cosa buona. Sembra che io conosca più intimamente il male del bene, e neanche questa è una cosa buona.
Ma perché diavolo l’aveva fatto? Perché li aveva ammazzati, ora che avrebbe potuto rifarsi? Che cosa c’era dentro quella testa?
Vi ricordate il racconto di Carver, intitolato I chilometri sono effettivi? La domanda che il venditore di auto usate, quello che ha appena comprato la decapottabile, rivolge a Leo: what is it?
What is it, Gary?
Oggi è una bella giornata, nella Utah Valley.
Il sole splende, e il vostro pranzo è finito. Tocca rimettersi in marcia, tocca partire di nuovo. La sosta termina qui, con una domanda: perché?
C’è proprio questo – quella domanda e gli ultimi mesi di vita e di morte di Gary Mark Gilmore – nel libro di Norman Mailer, Il canto del boia, che vinse il Pulitzer nel 1980 e che vi consiglio di cuore di leggere.

Non è un romanzo, non solo. E non è solo la storia di un uomo, una storia vera, verissima.
È un libro pieno di voci. Voci che vengono dalla Utah Valley – decine – voci di un’America fitta, fatte di terra e di polvere, fatte di vento, montagne e deserto. Intorno a loro macchine guaste, statali e interstatali, distributori e motel, piccole case e roulotte. Pistole e cappelli e stivali. Un nuovo inizio, poi due delitti e un castigo.
Voci che si alzano ancora, da allora.
Il canto umano del bene e del male, di quello che non capisci – non capirai mai – eppure senti che vuoi raccontare, senti che devi, perché neppure un respiro vada perduto, neppure un’ombra.
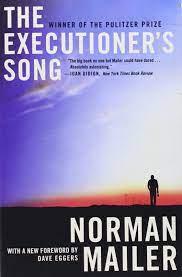
Gary Mark Gilmore amava da pazzi la musica di Johnny Cash. Amava la sua voce e quella canzone, il canto del prigioniero. È in questo modo che è andato a morire, volendo morire: accompagnato da Johnny, dicendo alla fine, davanti al plotone di esecuzione: “Let’s do it”.
Era un prigioniero, ed era anche il boia: il canto è il suo. Questa è la storia di oggi, e somiglia molto alla terra.
Bisogna mettersi in marcia, comunque, uscendo da Provo. La Y Mountain è un lampo bianco nel sole. L’acqua del lago Utah un lampo azzurro. Oltre, il deserto è grigio e marrone. Un ultimo sguardo a quei due palazzi e poi via.
La musica scorre dalla radio accesa, e tra le note c’è sempre la stessa, medesima, vecchia domanda: perché facciamo quel che facciamo? Che cosa c’è nelle nostre teste?
What is it?
When I was just a baby, my mama told me
“Son, always be a good boy, don’t ever play with guns”
But I shot a man in Reno just to watch him die
When I hear that whistle blowin’, I hang my head and cry
La voce di Cash ritorna piano nel vento, quel vento che porta la sabbia nel naso e negli occhi, che porta il deserto. Un vento che acceca, che a volte può farlo. Let’s do it. Per molte ragioni – ma chissà quali, chissà – può andare così.
Elena Varvello

Leggi la presentazione di Americana


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?