«Le corps textuel féminin, c’est toujours sans fin. C’est sans but, ça ne se termine pas… »
H. Cixous
Dietro Louise Bourgeois, l’artista che nella sua townhouse newyorkese al 347 West 20th Street aveva cominciato a realizzare le prime istallazioni dell’arte contemporanea prima che lo facessero tutti gli altri, ancora impegnati con quel che restava del surrealismo, dietro i sette corpicini di stoffa stretti nudi su una brandina (“Seven in bed”, 2001), dietro quel filo rosso che non ha né capo né coda, che percorre come un inchiostro di sangue e d’amore tutti i ricami di “Ode à l’ Oubli” (2004), dietro c’è l’insegna cigolante di un negozio familiare di tappezzerie, Aux vielles tapisseries.


Nel laboratorio di tappezzeria di famiglia a Nizza è racchiuso anche un gesto tra altri: il taglio (le figure ghigliottinate, le membra ritagliate che ritornano incessantemente nella sua produzione artistica), quel gesto che precede ogni ricucitura; conficcato nell’infanzia e nei suoi tradimenti, proseguimento del gesto del padre, che a cena intagliava figurine nella buccia d’arancia, come aveva imparato sul fronte, mentre diceva a Louise, questa sei tu. Ma anche proseguimento del gesto della madre che tagliava via i genitali dei cupidi dai tappeti che il marito riportava dai suoi viaggi perché altrimenti le ricche signore troppo puritane non li avrebbero acquistati. In quella casa-laboratorio, la bambina disegnava, ricamava, spiava i tradimenti degli adulti (l’amante del padre viveva con loro, sotto lo stesso tetto, sotto la scusa di insegnare ai bambini l’inglese), e a tavola modellava figurine con la mollica di pane, sfidando il padre dritto negli occhi, mentre con le mani lo faceva a pezzi, smembrandole. Ma, “the more you cut, the bigger it grows”, diceva Louise: più tagli più le ferite non si rimarginano, anche se in fondo per capirle davvero, per capire davvero quello che abbiamo vissuto bisogna che le ferite restino in qualche modo vive.
Laggiù è quel posto, quel “somewhere” da cui cominciare a dipanare il tormento (to unravel the tormenti it must begin somewhere). Laggiù c’è quel posto come non potrebbe essercene nessun altro. Mi piace l’immagine del tappeto e della trama fitta che contiene tutti i dettagli; eppure, in cui i dettagli si perdono perché sono troppi. Per il filo e i fili che ci tengono legati al passato e a quello che è stato prima di noi. Perché la trama è una metafora della fabbrica della vita, ma con uno spirito antiepico assolutamente contemporaneo, quello di Louise: tessere non le gesta memorabili da ricordare, ma tutto quello che si è tenuto assieme con la cadenza umile e povera del cucito per cercare ciò che è stato dimenticato, trascurato, perduto, eppure è lì senza segreti. In quella vita familiare che girava attorno ai tappeti palpita e si inabissa il cuore della scultrice, la sua anima. Lì, c’è la stretta di una profezia che è sempre anche un’autoprofezia.
Indietro, dove si è mossa la vita, è il posto in cui Giulia Caminito prova a tornare per raccontarci e riportarci cinque scrittrici molto amate e assieme a loro anche sé stessa. Elsa Morante, Paola Masino, Natalia Ginzburg, Laudamia Bonanni e Livia De Stefani. Sandra Petrignani, come mi è capitato spesso di ricordare, è stata la prima nel panorama italiano a percorrere questa strada: raccontare la vita delle scrittrici, cercando il senso delle loro opere nelle vicende biografiche, nei dettagli, negli oggetti minimi, nei luoghi che a volte è come se continuassero ad essere abitati, nei luoghi che, tornando per un attimo a Louise Bourgeois, possono assumere la fisionomia di un corpo, una specie di “femme-maison”, fino a rintracciare quello che Petrignani definisce “lessico femminile”. Petrignani è la prima ad aver legato la vita di scrittrici e scrittori alle loro opere (Lessico femminile). Ad averle legate in modo intelligente ed originale, scavallando la distinzione tra biografia e biofiction, tra documento e narrazione, senza sovrapporsi alla scrittrice raccontata ma ascoltandone la voce. Perché in quegli oggetti magari ordinari, nella stanza con il letto a ridosso della finestra a Monk house (la dimora dove Virginia Woolf si fece arredare dalla sorella Vanessa quella stanza tutta per sé che avrebbe usato poco preferendo la rimessa in fondo al giardino), nella casa di Nuoro in cui tutto continua a succedere anche quando Grazia Deledda finalmente lascia l’isola per il continente, nell’abbraccio avvolgente della Petite Plaisance (la casa con gli abbaini di Marguerite Yourcenar), nella stanza rossa di Colette con il suo eccesso di femminilità, la materia liquida e informe dell’io, le sue sbavature e il suo contegno si sono sedimentati, e i residui dei sogni e dell’opera si mescolano per essere raccontati (La scrittrice abita qui).




Caminito aggiunge un pezzo ulteriore a questa riscrittura dei generi, a questa interpretazione “erotica” (nel senso usato da Susan Sontag in Against Intepretation) dell’opera delle scrittrici, “amatissime” appunto.
In Amatissime, gli oggetti e i luoghi, la grande fotografia di Elsa Morante appesa nella casa dell’infanzia, gli abiti di Paola Masini, o quel poco o niente che resta di Livia De Stefani, non sono solo talismani che contengono una parte dell’anima di chi li ha posseduti, per disegnarne la sagoma, o completarne il disegno. Ma sono piuttosto ciò che lega le scrittrici che si susseguono nel libro a Giulia Caminito, in un racconto in cui chi ama e chi è amato si distinguono eppure si legano, come sulla soglia di uno specchio, che rimanda a Caminito sempre una sembianza diversa. Non credo che siano “la scusa” per passare dalla biografia delle scrittrici raccontate all’autobiografia dell’autrice. Preferisco non usare i termini biografia o autobiografia, che non mi sembrano adatti a descrivere questo filone narrativo.
Sin da bambina Caminito è abituata a guardare la foto di Elsa Morante, che sua madre, studiosa dell’opera della scrittrice, tiene in casa, e per Caminito è come se la donna ritratta in quella foto fosse già parte del suo albero genealogico, un ritratto in cui ritrovare la propria carnagione, anemica e febbrile. I vestiti che Paola Masino intreccia alle parole sono anche quelli che non si indosseranno per nessuna occasione, destini messi da parte per abbracciarne altri, per arrivare, alla fine dell’album, lì dove la notte, l’assenza di colori, anche per Caminito, scioglie il guinzaglio alla paura, e può solo custodirsi nell’abito nero del lutto. Il mondo editoriale del dopo guerra, con i suoi indimenticabili protagonisti, in cui si fa strada Natalia Ginzburg, a modo suo, senza compatirsi, con la morte del marito Leone ancora addosso e addosso anche la responsabilità dei figli, lasciati ai genitori per poter lavorare a Roma, cede spazio al desiderio di Caminito di poter ricevere uno di quei consigli schietti e concisi della Ginzburg: “c’è il pericolo di fare i furbi e truffare (Le piccole virtù). L’ultimo manoscritto di Laudomia Bonanni, riscritto per un’intera vita, “il più dimenticato dei romanzi” che nessun editore avrebbe pubblicato, quel no di Bompiani che sarebbe stato l’anticamera della fine della scrittrice, fanno crescere la rabbia e l’insofferenza di Caminito, quel no, fa stridere i denti per tutti i manoscritti dimenticati. E finalmente, il buco dell’oblio in cui è caduta l’ultima artista, Livia De Stefani, più che dimenticata, cancellata dai capricci della memoria anche collettiva, e dalle scelte di un mondo di uomini. Sull’orlo di quel buco ci sono le reliquie di una storia, la foto di una donna molto bella e carismatica, le cartelle dei brogliacci di Livia De Stefani e soprattutto una domanda, quella che assilla Caminito: una domanda che ha a che vedere con il senso della scrittura, un rivolo tra “farsi carico” e abbandonare. Quella domanda che ogni scrittore dovrebbe sempre tenere stretta.
E così gli oggetti e le vite delle scrittrici raccolte in questo libro cedono il passo alle emozioni di Caminito, emozioni anche a fior di pelle, tutte sotto un unico segno: “strappare ai bordi le regole”. Questi oggetti sono la parte manifesta di un legame viscerale di cui è la zona latente, forse addirittura rimossa (da chi ama e da chi è amato), ad interessarmi e a stringere davvero le maglie della narrazione. Lì dove per Caminito quella foto di Morante in qualche modo si confonde con sua madre, con il suo percorso di donna (la prima ad essersi laureata in famiglia), una voglia di riscatto, il sapore di un ricordo futuro, di un lascito. Lì dove lo stesso rapporto di Elsa Morante con sua madre Irma Poggibonsi, cerca di andare oltre gli aneddoti, e di dare un senso a quella storia che Marcello Morante racconta in Maledetta, benedetta, dei due biglietti destinati alla madre, che Elsa avrebbe fatto scivolare sotto la porta della stanza da letto della madre; lì dove non importa davvero se sia andata proprio così; lì, nella zona della finzione che è anche la materia di cui è fatta la vita degli scrittori e di noi tutti.
Così preferisco usare un altro termine: “intertestualità” (nel senso originale usato e coniato da Julia Kristeva nella teoria letteraria sul finire degli anni Sessanta). Non si tratta però qui di pastiches, di stili che si rincorrono, di citazioni di altri autori. Di un circuito aperto di rinvii e di passaggi da un genere ad un altro, saggio, poesia, dramma, a descrivere un lessico o un “metodo” che di metodico non vuole avere più niente, perché ci si muoveva già allora nel terreno dell’incomunicabile, della soggettività, del desiderio, del censurato, dell’inespresso, del gioco, e finalmente della poesia.
Ma di un passo oltre: intertestualità nel senso di interconnessione, quasi un “plagio di vite”, dei sé, in una linea verticale ma anche orizzontale. È una nozione che vorrei prendere lì dove l’ha lasciata Kristeva, con tutto il potenziale e l’ambiguità che sono nascosti nelle parole usate da lei: assimilazione, e trasformazione. “Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte. À la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité”. E portarla in un’altra direzione, non in quella che ha avuto dopo di lei per diventare solo una specie di tecnica interpretativa, un gradino di un “palinsesto” sempre più ricco (dall’architextualité alla hipertextualité) per comprendere la genesi di un’opera (Genette). Ma piuttosto nell’humus della narrazione dove oltre ai testi anche le vite di chi narra e delle scrittrici di cui si narra formano questo tessuto intertestuale. Proprio come quei vestiti degli anni Venti, che un bel giorno degli anni novanta Louise Bourgeois chiese al suo giovane assistente di portarle subito (Bring all the clothes) ed iniziò a tagliare, imbastire, trasformare in quel suo “fabric book” che è l’Ode à l’oubli. In quel suo ultimo gesto di perdono e riconciliazione. Solo in questo modo le scrittrici, che costituiscono il testo di partenza, possono formare anche un “corpus”, quel sistema, o quel lessico, conosciuto e sconosciuto che Caminito è (come scrittrice ed editrice) impegnata a proteggere dall’oblio. L’intertestualità è essenziale alla scrittura femminile, prendere la parola a nome di tutte le altre. Perché quello che interessa a Caminito (e al progetto editoriale “Mosche d’oro”) è questa continuità semantica con le scrittrici del passato, alcune minorizzate o dimenticate, e riattivarle. « Je lui dirai je suis contente à cette femme du bout du monde. Cette femme initiale dont je cherche la trace » (Denys Boucher). Un corpo testuale senza inizio né fine.
Silvia Acierno

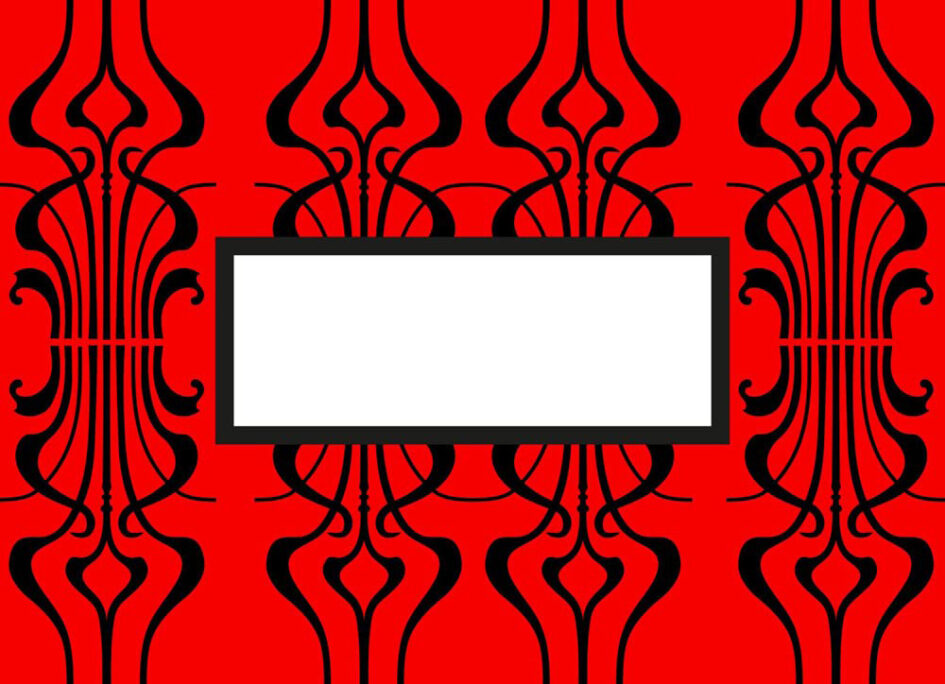
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?