
Riprendo il viaggio dove mi ero fermata, due settimane fa. Ce ne stavamo tra Alaska e California, ricordate?
Il padre di David – il nostro ragazzino – all’altro capo del telefono, in Alaska, voleva chiedergli qualcosa. Ci aveva riflettuto molto a lungo, oppure forse no, gli era venuto in mente all’improvviso. Non lo sapremo mai.
Ciò che voleva chiedergli, comunque, era se David, che allora aveva tredici anni, avesse voluto trascorrere con lui, suo padre, un anno intero, se avesse voluto trasferirsi per un anno là in Alaska, il paese in cui era nato e in cui era cresciuto – nella cittadina di Ketchikan, molto vicina al confine col Canada. Sarebbe stato bello, pensava: il padre e il figlio insieme. Fu quello che gli chiese, mentre lui, David, in quella calda estate a Santa Rosa, California, nel 1979, se ne stava in piedi nel soggiorno di casa sua, la casa in cui viveva con la madre, teneva la cornetta premuta contro l’orecchio e lo ascoltava, ascoltava la voce di suo padre, l’uomo che, negli ultimi tempi, aveva cominciato a comportarsi in modo strano e spesso, quando lo chiamava, scoppiava a piangere o se ne stava in silenzio, sovrappensiero, o si lamentava, dato che anche il suo secondo matrimonio era finito male e si era rivelato un altro fallimento.

David lo ascoltò – di certo non se l’aspettava.
Forse rispose che avrebbe voluto pensarci sopra un attimo, perché l’aveva colto di sorpresa, e poi, il giorno dopo o quello dopo ancora, lo richiamò e gli disse di no. O forse, dopo un istante di sconcerto, nel suo soggiorno, gli disse subito che proprio non poteva: aveva la scuola, aveva i suoi amici, aveva la sua vita a Santa Rosa, la bicicletta, lo skateboard, il basket, un gruppo di lettura, chi lo sa, un gruppo di scacchi, e un anno sarebbe stato troppo lungo, davvero troppo lungo.
“Mi dispiace, papà.”
Ci fu un lungo silenzio, all’altro capo del telefono, in Alaska? Oppure il padre rispose subito che, certo, lo capiva: in effetti, se ne rendeva conto, era stata una richiesta assurda.
“Però, sarebbe stato bello.”
“Lo so, papà.”
“Mi dispiace.”
“Anche a me.”
“Ma va bene, dico sul serio. Va tutto bene. Ok, allora ci sentiamo.”
“Ok. A presto, papà.”
“A presto.”
Quella telefonata tra Alaska e California si concluse, e David, il nostro ragazzino, un ragazzino come tanti, tornò alla sua vita, alla sua bicicletta, ai suoi amici, agli ampi cieli azzurri e alle strade alberate di Santa Rosa. Non aveva idea, non poteva immaginare – nonostante i silenzi e i pianti improvvisi di suo padre – ciò che sarebbe accaduto pochi giorni dopo, ciò che suo padre avrebbe fatto. Era soltanto un ragazzino. Allora, tutto sommato, per quanto ne sapeva lui andava ancora davvero tutto bene.
A presto, papà.
A presto, David.
Il padre di David si sparò: è questo quello che successe.
Quando dall’Alaska partì un’altra chiamata, la voce che correva lungo i cavi, spingendosi fino in California, portò quella notizia terribile. David non avrebbe mai più risentito la voce di suo padre, non avrebbe mai più parlato con lui, e l’ultimo ricordo che avrebbe conservato di quell’uomo sarebbe stata la telefonata durante la quale gli aveva detto no: non verrò a vivere con te, non rimarrò in Alaska per un anno insieme a te.
No, non lo voglio fare.
No, papà.
Ma David, in fondo, non era un ragazzino come tanti. O forse sì, prima di quella notizia, prima di quello strappo. Se lo era stato, in ogni modo, smise di esserlo il giorno in cui venne a sapere di suo padre, del suo suicidio.
Certo, per quanto sia terribile non c’è niente di strano: ciascuno di noi sarebbe cambiato, e cambiato per sempre. La vita si può stravolgere in un attimo, e quando meno te lo aspetti. Eppure, per David, c’era qualcos’altro, qualcosa di più, un peso insostenibile. Già, perché quel giorno lui si convinse di una cosa, e in seguito, per molti anni, continuò a esserne sicuro, continuò a tormentarsi, e questo lo cambiò ancora più radicalmente.
Di cosa si convinse?
Forse potete immaginarlo. Si convinse del fatto che fosse stata colpa sua.
È tutta colpa mia.
Se solo gli avesse risposto “sì, papà”, se solo avesse accettato quell’invito, se solo avesse capito quanto suo padre era disperato, quanto si sentiva perduto, finito, quanto sarebbe stato importante, per lui, avere con sé suo figlio, provare a ricominciare. Se solo…
Che enorme differenza può esserci tra un sì e un no, due paroline, due soffi di voce due sillabe minuscole, tutto qui – appena pronunciate e già svanite – e quali conseguenze.
Quel giorno, a Santa Rosa, sotto perfetti cieli azzurri, cieli estivi, il ragazzino di appena tredici anni imboccò la lunga strada che l’avrebbe portato a scrivere una storia bellissima e terribile come L’isola di Sukkwann, bellissima perché terribile, terribile perché bellissima, impeccabile e implacabile – sono anni che la tengo qui con me, è sempre accanto a me, nella mia memoria: mi ha accompagnata, un passo dopo l’altro, lungo la mia strada, mentre lavoravo a La vita felice, mentre scrivevo di mio padre, un uomo che somigliava al padre di David, che era depresso e poi di colpo euforico e poi di nuovo depresso.
Quel giorno, il ragazzino David, nato e vissuto per un po’ lassù Alaska, prima di trasferirsi insieme alla madre in California, imboccò la strada che avrebbe fatto di lui, un giorno, lo scrittore David Vann. Intanto l’estate del ’79 continuava, il cielo baluginava d’azzurro, il sole splendeva contro i vetri e sui tettucci delle macchine, un po’ di vento caldo faceva dondolare le foglie degli alberi che costeggiavano i viali. E poi l’estate terminò.

David Vann cominciò a scrivere la storia di suo padre, di sé e di suo padre, a diciannove anni. Ne impiegò dieci, un arco di tempo molto lungo per scrivere e riscrivere, tentare e cancellare, accumulare pagine per poi buttarle via, sempre con un peso tremendo sulle spalle, cercando di afferrare il modo giusto, la forma più adeguata.
Avrebbe dovuto raccontare com’erano davvero andate le cose: il suo rifiuto in risposta a quell’invito, la notizia del suicidio, il lutto, il suo senso di colpa? Essere fedele alla vita, ai suoi movimenti, per quanto terribili?
Ci provò, eccome se provò, ma molto presto scoprì che non aveva senso, almeno non per lui, che non andava bene, che l’aderenza a ciò che era successo non gli serviva a niente. Non funzionava e basta. Non l’aiutava affatto. Ricominciò da capo, mentre gli anni passavano, passavano altre estati, venivano altri inverni. E infine capì quel che doveva fare: provare a immaginare – immaginare, sì – un padre e un ragazzino che si trasferiscono su un’isola, l’isola di Sukkwann – che lui non conosceva, su cui non aveva mai messo piede – per vivere insieme un anno intero, soltanto loro due, il padre e il figlio, su quell’isolotto dell’Alaska tutto foreste e montagne e acqua, nessuno a parte loro, perché il padre del ragazzino l’ha invitato a vivere con lui quell’avventura – “vedrai che ci divertiremo” – e il figlio gli ha risposto: sì.
Sì, papà.

Così, finalmente, arrivò la storia, L’isola di Sukkwann – “scrivere vuol dire trasformare”, ripete molto spesso David Vann – che nel suo cuore, esattamente al centro, ribalta tutto quanto, sovverte quello che, leggendo, eravamo sicuri che sarebbe accaduto. In questo ribaltamento sorprendente, soltanto immaginato – scrivere vuol dire trasformare – David Vann ha rintracciato il senso più profondo della propria esperienza, ha fatto i conti col suo senso di colpa, con il mistero della vita, dei suoi accadimenti.
Quel ragazzino tredicenne, che pedalava spensierato a Santa Rosa, California, in un giorno d’estate, è ritornato in vita ma con un altro nome e con un’altra faccia, un’altra storia e un altro destino, ed è tornato in vita un padre molto amato eppure sconosciuto, vicino e irraggiungibile, perduto all’improvviso.
Scrivere vuol dire trasformare, tocca ripeterlo di nuovo.
È una lezione importantissima, centrale. Ed è così che la scrittura si fa davvero viaggio: è un modo per capire, non solo raccontare.
Mentre lavoravo a La vita felice, vi dicevo, tenevo accanto a me il libro preziosissimo di David. Da figlio a figlia, da padre a padre. Lo aprivo a caso, leggevo nuovamente qualche riga. Mi ripetevo che andava tutto bene, che avrei potuto farcela, perché c’era qualcuno che, prima di me, era già stato lì, dove la vita viene trasformata, presa da un’altra angolazione, dove le cose cambiano per andare più a fondo.
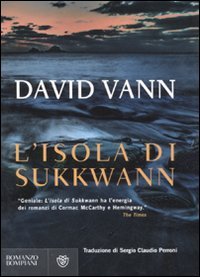
I grandi libri non li leggiamo e basta: i grandi libri ci spostano più in là – sono correnti silenziose – ci portano dove non eravamo. Non è solo lettura: è la vita che cambia davanti ai nostri occhi, e non saremo più ciò che eravamo prima. Mettere i piedi sull’isola di Sukkwan, insieme a David Vann, vuol dire proprio questo.

Elena Varvello


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?