
Secondo me tutto cominciò a causa degli Ewell, ma Jem, che ha quattro anni più di me, diceva che bisognava risalire molto più indietro, e precisamente all’estate in cui capitò da noi Dill e per primo ci diede l’idea di far uscire di casa Boo Radley.
Il buio oltre la siepe, Harper Lee
Quand’ero piccola, un bosco chiudeva su due lati la casa in cui abitavo. Mi sembrava bellissimo. Era bello, per una banda di ragazzini, giocare laggiù, all’ombra degli alberi, nei pomeriggi primaverili e soprattutto in quelli estivi, quando dovunque, altrove, il caldo era opprimente.
Di quella banda facevo parte anch’io.
Avevamo ereditato da alcuni ragazzi più grandi – mio fratello e certi suoi amici di cui non riesco a ricordare il nome: ormai sono fantasmi, nella mia memoria – una capanna costruita tra due alberi, una specie di piattaforma in legno scricchiolante a cui si accedeva arrampicandosi, o forse grazie a una scaletta di corda: anche di questo ho perso memoria. Trascorrevamo così molte giornate, tra foglie e rami caduti, salendo a piccoli gruppetti su quella piattaforma. Sapevamo che, attraversando il bosco, alla fine saremmo arrivati giù in città: riuscivamo a intravedere alcuni palazzi. Avremmo voluto provarci, ma non accadde mai: stavamo bene lì.
Prima che il sole tramontasse, ciascuno di noi tornava a malincuore a casa propria.
C’erano sere, allora, in cui i miei genitori uscivano, affidandomi alle cure di mio fratello, che aveva sedici o diciassette anni e un motorino orribile, dipinto di giallo a pois marroni. Era un adolescente: nessuna voglia di perdere il suo tempo con una ragazzina. Usciva anche lui, pochi minuti dopo, in sella al motorino, con la promessa di riportarmi qualcosa di buono – un pacchetto di patatine o di caramelle – se non avessi spifferato tutto quanto. La bocca chiusa, poteva contarci, era la mia specialità.
Rimasta sola, mi barricavo in camera. Dalla finestra vedevo proprio il bosco, ed era lì che spesso mi piazzavo, in piedi dietro il vetro, come una sentinella. Quando calava il buio, quel parco giochi naturale perdeva all’improvviso tutta la sua innocenza. Era inquietante e misterioso. Cosa si nascondeva tra quegli alberi? Ero certa che ci fosse qualcosa, oppure qualcuno. Chi c’era laggiù? Di chiunque si trattasse, mi stava fissando? Aveva l’intenzione di venire a prendermi?
Avrei voluto scappare, trovare un nascondiglio – me ne ricordo bene – eppure non arretravo di un passo, come dovrebbe fare una vera sentinella, almeno fino a quando non ero troppo stanca. Restavo lì a guardare il bosco, nel buio, oltre la siepe che cingeva il giardino. Coraggio, mi dicevo, guarda.
Non c’è più traccia di quella piattaforma, ormai. Non c’è più traccia neppure di quel tratto di bosco, se è per questo: case di nuova costruzione l’hanno respinto un po’ più in là.
Non è rimasta traccia di moltissime cose, compreso quel senso di pura innocenza. È questo quello che fa il tempo: in parte è il suo lavoro, ed è un lavoro necessario.
Queste piccole vicende personali accadevano in Piemonte, tra la fine degli anni ’70 e i primissimi anni ‘80. Davvero un’altra epoca, a pensarci.
Facciamo ancora un passo indietro: dieci anni prima, nel luglio del 1960, era comparso negli Stati Uniti un romanzo dal titolo To kill a mockingbird (cioè, letteralmente, uccidere un mimo, volgarmente detto tordo beffeggiatore, un uccello passeriforme diffuso in America Centrale e Settentrionale, capace di imitare il canto di altri uccelli, dotato di grande intelligenza, molto protettivo nei confronti del proprio nido, pronto ad aggredire per difenderlo ma per il resto del tutto innocuo).
Il romanzo ebbe da subito un grandissimo successo. L’autrice aveva trentaquattro anni, ed era sconosciuta. Nelle Harper Lee, questo il suo nome di battesimo, ma sulla copertina di Nelle non c’era traccia. “La maggior parte delle persone lo pronuncia come Nellie”, avrebbe detto in seguito, “ed è una cosa che non sopporto. L’ho eliminato solo per evitare confusione”.

Nelle viveva a New York, nell’Upper East Side, in un appartamentino in affitto, senza neppure l’acqua calda. Aveva lavorato per una compagnia aerea – agente di viaggio – abbandonata quando una coppia di amici molto cari le aveva regalato per Natale una considerevole somma di denaro perché potesse scrivere senza più distrazioni, perché era questo quello che Nelle voleva fare: scrivere. Voleva farlo da quando era bambina.
Il romanzo arrivò in Italia nel 1962, ed era intitolato Il buio oltre la siepe.
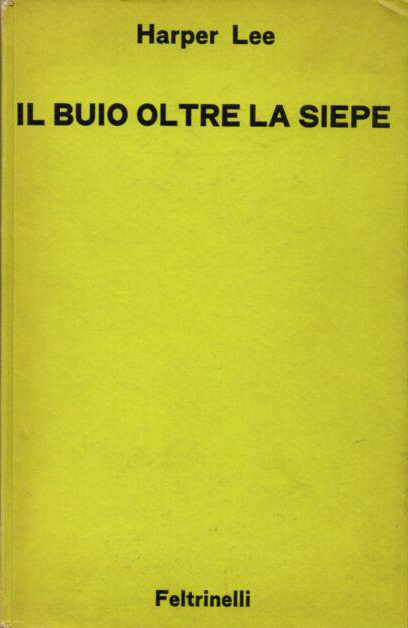
Nelle Harper Lee non era di New York, nemmeno per sogno, per quanto l’amasse. Lei era nata a Monroeville, nella contea di Monroe, nel sud dell’Alabama, nel 1926, un tempo di segregazione. La piccola città di Monroeville, lontana dal fiume Alabama, lontana dalla ferrovia, lontana da Montgomery, la capitale dello Stato. Lontana, lontanissima, da una città come New York.
Monroeville contava allora circa 1300 abitanti; ne conta, adesso, appena più del triplo.
Nel 1960, quando il romanzo uscì, la maggior parte delle case di Monroeville era ancora in legno, a un solo piano. Quasi tutte erano dotate di portico, e, sotto i portici, erano appesi i dondoli.

Immaginate Nelle, fotografata accanto a casa sua in Alabama Avenue, nei primi anni ’30: capelli corti, frangetta, vestiti da maschiaccio (abitualmente salopette). Amava fare a botte, amava i giochi da maschiaccio e amava molto leggere. Aveva due sorelle e un fratello maggiori. Sua madre, Frances Cunningham Finch, era spesso malata; suo padre, Amasa Coleman Lee, avvocato e poi legislatore, aveva comperato il giornale locale.
Nella casa accanto, oltre un muretto in pietra, viveva un ragazzino, il suo migliore amico. Lui si chiamava Truman Streckfus Persons, ed era un tipo strambo, con una vocetta stridula, più basso di Nelle anche se di due anni più grande. Era stato affidato dalla madre in difficoltà a due cugine perché si occupassero di lui (sua madre andava e veniva da Monroeville). Spesso, durante l’estate – le lunghissime, torride estati dell’Alabama – Nelle e Truman, entrambi “ragazzini a parte”, trascorrevano il tempo nella casetta che l’amatissimo padre di lei aveva costruito sopra un albero nel cortile sul retro.
Della casa di Nelle non è rimasta traccia: al suo posto trovereste oggi un locale, il Mel’s Dairy Dream, dove mangiare burgers e coni gelato, cookies e bacon cheddar fries, un grande chiosco bianco e azzurro con due panche all’esterno, una pagina Facebook e molte recensioni positive.

Perduta anche la casa del ragazzetto strambo dalla vocetta stridula, che il mondo avrebbe ricordato col nome di Truman Capote, stampato sopra una copertina in particolar modo, su un titolo terribile: In cold blood.
Scomparso pure il cinema in cui, due anni dopo l’uscita del romanzo e un anno dopo il Pulitzer, fu proiettato il film di Robert Mulligan, interpretato da Gregory Peck, un film che avrebbe vinto tre statuette agli Oscar. Venne distrutto da un incendio e non fu mai ricostruito. Un altro fantasma.

Nelle Harper Lee voleva scrivere da sempre, vi dicevo. Voleva scrivere del padre, che nel 1919 aveva difeso, perdendo la causa, due uomini di colore accusati di omicidio. Voleva scrivere di suo fratello Edwin, a cui era legatissima, scomparso a soli trentun anni, e della madre, fragile, amata nell’assenza. Voleva scrivere del ragazzetto strambo dalla vocina stridula che a un certo punto si era trasferito a New York e aveva preso il nome con cui lo conosciamo. Voleva scrivere di Monroeville, delle sue strade alberate e polverose (fanghiglia rossa, nei rari giorni di pioggia), delle sue case in legno, del tribunale in cui il padre esercitava, delle zone abitate dalle persone di colore, della capanna sull’albero, di quelle lunghe estati. Voleva scrivere di un vicino di casa che aveva l’abitudine (come raccontò Truman Capote) di lasciare oggetti nel tronco cavo di un albero, e di un altro vicino, che aveva avuto problemi con la legge ed era stato segregato per vergogna tra le mura domestiche.
Voleva scrivere della propria infanzia, Nelle – il mondo perduto, guardato dagli occhi dei bambini – dell’innocenza, della segregazione e del pregiudizio cieco, del buio oltre le nostre siepi, della paura e del coraggio, dell’inoltrarsi in quell’oscurità. Voleva scrivere degli altri: come crediamo di conoscerli e quello che ignoriamo, come dovremmo cercare d’infilare i nostri piedi, almeno per un attimo, dentro le loro scarpe.
Così, nell’appartamentino di New York, Monroeville prese a un certo punto il nome di Maycomb, e Maycomb, nell’omonima contea, raccolse e diede un posto sicuro (le pagine di un libro) a tutti i fantasmi di Nelle, per quanto lei non considerasse affatto il suo romanzo autobiografico, quanto piuttosto un esempio – solo un esempio – di come un autore dovrebbe scrivere autenticamente di ciò che conosce. E lei li conosceva bene, quei fantasmi, li conosceva eccome. E conosceva Maycomb, che:
… era una vecchia città, e quando la conobbi io era una città vecchia e stanca… La gente si muoveva lentamente. Passeggiavano pian piano per la piazza, entravano e uscivano pigramente dai negozi strascicando i piedi, e facevano tutto con molta calma. La giornata era, sì, di ventiquattr’ore, ma pareva più lunga. La fretta era ignorata perché non c’era dove andare, nulla da comprare (a parte che mancava anche il denaro per comprarlo), e nulla da vedere fuori dei confini della contea di Maycomb. Eppure era un’epoca di confuso ottimismo per una parte della popolazione: qualcuno di recente aveva detto alla gente di Maycomb che non doveva temere nulla, tranne il timore.
Nulla da temere, tranne il timore: le frasi più importanti a volte arrivano così, a conclusione di un paragrafo, come se niente fosse. E dicono, molto semplicemente, quello che c’è da dire, dicono il necessario.
Mi fermo qui, per ora, pur avendo scalfito solo la superficie, me ne rendo conto. La settimana prossima vi porterò di nuovo a Maycomb, in Alabama, ma soprattutto nella vita di Nelle, la lunga vita che seguì a quel successo clamoroso, a quel racconto di fantasmi e pregiudizi, paura e coraggio.
Aggiungo soltanto un’ultima nota personale, che possa darvi conto del modo in cui ho cominciato questa tappa del mio viaggio nella letteratura americana: in qualche modo la me dietro quella finestra, qui in Italia, continua ancora oggi a scrutare quel bosco scomparso, a chiedersi che cosa o chi si nasconda nel buio, a dirsi: su, coraggio. È lei, quella bambina, uno dei miei fantasmi – ne abbiamo tutti così tanti, dovunque ci troviamo, vero Nelle? – ed è di lei e di quel tempo perduto che in fondo scrivo anch’io. Di quella mia versione di Scout Finch, l’indimenticabile protagonista bambina de Il buio oltre la siepe, figlia di Atticus, sorella di Jem, amica di Dill.
Quel che accadeva poi, in quel tempo lontano, era che ovviamente tornava la luce, nasceva un nuovo giorno. Il buio se ne andava, almeno per un po’. La banda di ragazzini sgusciava di nuovo nel bosco, saliva di nuovo sopra la piattaforma.
Non c’era nulla da temere, a parte il timore.
Elena Varvello


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?