In questa storia le parole vengono in qualche modo prima di tutto. E allora comincio proprio dalle parole che riempiono gli spazi, le distanze tra le mots et les choses, tra Luca Ragagnin, l’autore, e le cose, tra sé e il mondo. Tra i mobili della stanzetta in cui era bambino, la sua scrivania, il suo lettino, e i muri perché da bambino il narratore non sopportava che il suo letto fosse stretto alla parete. Quello spazio è l’insostenibile vertigine del vuoto. E le parole che devono riempirlo, “mettersi tra” (intermettersi), diventano infinite, quasi quanti sono gli atomi che ci separano, sempre più lontane dalle cose, che finiscono per perdersi in descrizioni e sovradescrizioni, voragini e burroni. Per avvicinarsi però all’autore, alla sua psiche e nevrosi. Berg, così si chiama il narratore, in fondo sta lì, in quello scarto, in questa distanza. Dove appunto la digressione e i suoi flussi sono uno stato d’animo, un modo di stare al mondo. L’opposto della digressione è la mancanza di immaginazione, la pigrizia, così ci dice. L’immaginazione invece per Berg è quello che separa la parola dall’azione, il reale dalla realtà, tutto quello che sta lì in mezzo. Lì senza argini, il bambino che contava numeri si allunga nell’adulto che conta parola per allungare il tempo.
Le parole hanno un’origine materna o paterna. Quelle del padre sono tassonomie, quelle della madre aspettative. Tra parentesi mamma o papà perché i genitori sono separati e quindi non solo doppie vacanze ma anche cose separate, quelle di mamma e quelle di papà, parole separate, e in qualche modo due universi separati, gli uomini da un lato e le donne dall’altro. Ad un certo punto della storia la madre di Berg, una maestra, compra una casupola in campagna che il narratore descrive nei minimi particolari con la solita autoironia che è un modo per nascondere a se stesso quei sentimenti scomodi che si nutrono nei confronti dei nostri genitori e che non sempre siamo disposti a vedere ed accettare. Questa casina dove tutto batte contro tutto, dove ogni spazio si scontra con quelli contigui, avviluppata da erbe e cose ed insetti minuscoli, una casa giocattolo, una casina delle bambole, un fortino è, allo stesso modo del romanzo, una rappresentazione perfetta dello scrittore, almeno di quello che si nasconde dietro Berg, e delle sue fobie. Ma è anche la forma del ricordo. Cos’è in fondo quella casa in cui siamo vissuti quando cresciamo e tutto cambia, e siamo nelle nostre case e ci mancano tante cose, se non uno spazio minuscolo, un nocciolo, chiuso e perfetto nelle sue imperfezioni come un carillon, come una casa giocattolo, appunto?
Ma anche la casa o stanza che il narratore va costruendosi è un piccolo cerchio forse ancora più angusto della casetta della madre. Un cerchio che allontana tutti gli altri, per snobismo, le ragazze stupide, i figli di papà, e tutti quei nemici, reali o immaginari, che ci costruiamo, forse solo per paura, prima che quegli altri ci facciano del male o ci feriscano di nuovo. “Non sarà un cerchio perfetto, probabilmente non sarà nemmeno un cerchio; sarà una forma chiusa, irregolare, spezzettata, ma avrà una porta, per lasciare fuori”.
Nella stanza, tra i muri e sipari del cerchio, le parole devono assolutamente sostituirsi agli oggetti, coprirli, nasconderli. Soprattutto alcuni: quelli che hanno occhi e ingranaggi, quelli da cui il narratore anche adulto continua a distogliere lo sguardo. Le cose che lo fissano con occhi inanimati, come le bambole di pezza nella stanza della madre. Le bambole sono come tre bambine che odiano Berg. Così come la sveglia, che il bambino osserva mentre la madre riposa nella sua stanza, scatena la visione del cadavere di una donna nuda (di nuovo una figura femminile, di nuovo legata alla stanza intima della madre) e insidiosa. Oggetti che portano con sé quell’angoscia che nel romanzo di Saramago, Las intermitencias de la muerte, è per assurdo moltiplicata dall’assenza del tempo e della morte. Quegli oggetti sono il tempo che si prende beffa di te andando indietro per poi prendere quella rincorsa che si porta appresso tutte le illusioni.
Intorno alle parole ci sono le parentesi anche loro oggetto di infinite moltiplicazioni. Poi ci sono le forme che non si adattano alle cose e alle parole che le descrivono, ma hanno una consistenza propria, un’idea, forse l’immaginazione propria dell’infanzia, che si interpone tra la cosa e la parola, trasformandola e creando un lessico molto intimo.
Le parole-talismano o piuttosto parole-leggendarie attorno a cui si materializzano i passaggi da un età ad un’altra, che sono sempre piccoli salti o piuttosto passi attorno a un punto, sempre lo stesso, in sfere che da quel punto si allontanano sempre di più. Fino a quando quel punto resterà dentro pulsante o soffocato. Catavoletto è una di queste: il tavolo posato su due cavalletti che gli regala il padre e che in qualche modo rappresenta il luogo della scrittura che per Ragagnin è un tavolo-sorella. Una sorellina immaginaria, Kyoko, (ancora una versione della femminilità della madre) della cui mancanza il bambino in qualche modo si è fatto una specie di colpa. Un cappello che è un po’ come un orsetto. C’è la panchina. Nel mio immaginario la panchina è un posto romantico, lo spazio stretto di un appuntamento, un bacio svolazzante come quelli di Doisneau sulle piazze e i banc public di una Parigi che sopravvive ancora, fedele a se stessa. Niente di più lontano dalla panchina di Ragagnin: luogo della comitiva ristretta di pochi ragazzi, sicuramente appassionati di musica cult, non il pop dei comuni mortali. Solo ragazzi, magari un po’ misogini ma per timidezza. Queste parole sono soprattutto oggetti su cui ancora scorre il tempo. Ma questa volta non minacciano Berg, piuttosto lo difendono come bastioni.
Ragagnin si mette sotto torchio. E quando ci si mette sotto torchio le parole diventano labirintiche e hanno ganci che trascinano con sé tutto, pieni e vuoti. Ganci ancora sono quelle parole tra parentesi a fine capitolo che visivamente devono anticipare ed afferrare l’inizio del capitolo successivo. Il suo bambino intermittente è un bambino distratto, un adulto con la testa tra le nuvole, incapace di portare a termine qualsiasi progetto, uno che inciampa, si scontra continuamente nelle cose che sporgono e quando resti impigliato anche le parole e i ricordi fanno cadute rocambolesche, giri vorticosi. E allora possono far male. È un bambino che probabilmente la madre ha sempre cercato di incasellare. Il biglietto da visita che la madre gli regala in una risma e che il bambino riscrive continuamente è una metafora di questa necessità di inquadrarlo. Che poi diventa una necessità quasi maniacale del ragazzino e dell’adulto di nascondersi, e di coprire sotto tutto il suo vero me. E su quel biglietto ci sono alcune delle definizioni che sentiamo dire distrattamente o con grande apprensione ai nostri genitori: bambino iperattivo, bambino problematico, Ragagnin aggiunge, bambino tra parentesi, bambino maltagliato, bambino indeciso… Tutte tristi testimonianza della difficoltà dell’adulto di accogliere un bambino. Lui quei biglietti racconta di averli inceneriti ma nel romanzo ritornano. Il romanzo stesso è l’ennesimo biglietto da visita, un’altra identità.
Berg è un collezionista, di libri, di musica e vinili, di erudizione musicale. Ma soprattutto di parole e ricordi e di immaginazioni, che hanno una consistenza diversa dalla sabbia della famosa collezione che Calvino sceglie come metafora della sua raccolta. Eppure anche tutti quegli oggetti e fantasie ancora così corporee, accumulate, a volte affastellate in queste pagine finiranno per diventare granelli di sabbia, edifici che crollano.
Come raccontare la propria infanzia? Forse meglio nello spazio incompiuto del frammento, di quelle poche scene che sopravvivono di un tempo del prima. Difficile farlo in una narrazione classica, dove a una pagina segue un’altra, ad un anno segue quello successivo. Difficile farlo quando si pretende di raccontare invece di mostrare. In questa narrazione l’adulto Ragagnin è sempre presente anche troppo, accompagna sempre per mano quel bambino ne completa il gesto, lo interpreta, lo racconta con parole troppo adulte. Eppure, nonostante il narratore si intrometta continuamente, provi a rientrare negli spazi vuoti, quel bambino impacciato, che pende dalle labbra degli adulti sta lì, eccolo. E quanto più l’io narrante non si ridimensiona, non si rimpicciolisce, dà libero corso alle sue fantasie gotiche e non, tanto meglio vedo quel bambino protetto ma sempre vigile, che ha paura di dormire, paura di mangiare, paura che accada qualcosa alla madre mentre dorme. Il bambino che guarda gli enormi vagoni merce dal terrazzo della nonna.
Il bambino intermittente è un bambino che avanza e si ferma, si accende e si spegne. Ma è anche quel bambino che ritorna continuamente e involontariamente nell’adulto, nella scrittura. Evoca le “intermittenze del cuore” di Proust. La memoria involontaria che sola può farci sperimentare il vero dolore, e restituirci la persona che si ricorda assieme a un sé più vero e autentico. Un sentimento intermittente è incompleto, anacronistico, non freudiano. Una rivelazione in cui si inciampa senza volere.
All’intermittenza del cuore si addice forse uno stile frammentario (Roland Barthes nel Journal de deuil, e in La chambre claire), invece qui il ricordo è sostenuto da una narrazione fitta, lunga, più o meno cronologica, stilisticamente agli antipodi di qualsiasi frammentarietà. Eppure a ben guardare la scrittura non è un ponte che conduce dal passato al presente. Ragagnin si muove piuttosto nell’indeterminatezza, una specie di confusione che forse è il suo modo di sopravvivere. Così la scrittura confonde e trasforma un imbarcadero nel punto romantico in cui Berg immagina che i suoi genitori si siano scambiati quella lontana promessa, nel punto dannato in cui si ritrova con un gruppo di musicisti, l’infelicità dei bicchieri vuoti sul tavolo, dei travestimenti ben stirati, delle parole acide, fino a dissolversi in un luogo di occasioni mancate avvolte in una nebbia che morde le parole.
Nella nebbia dove la realtà compare a blocchi intermittenti, nonostante tutte le parole e tutti gli appigli, il ricordo è ancora più rotto di un frammento, più frammentario di una scaglia, è un punto statico, desolatamente irraggiungibile, amplificato all’infinito. Sul quel punto Ragagnin-Berg si ferma e cerca di imbalsamarlo, “non dimentico più nulla”, applica gli unguenti, l’impronta morbida del silenzio delle nonne “su tutti quei bambini che sono stato” e sull’unico bambino che è stato, sulle sue paure e solitudini che sono forse il biglietto da visita più vero.
Silvia Acierno

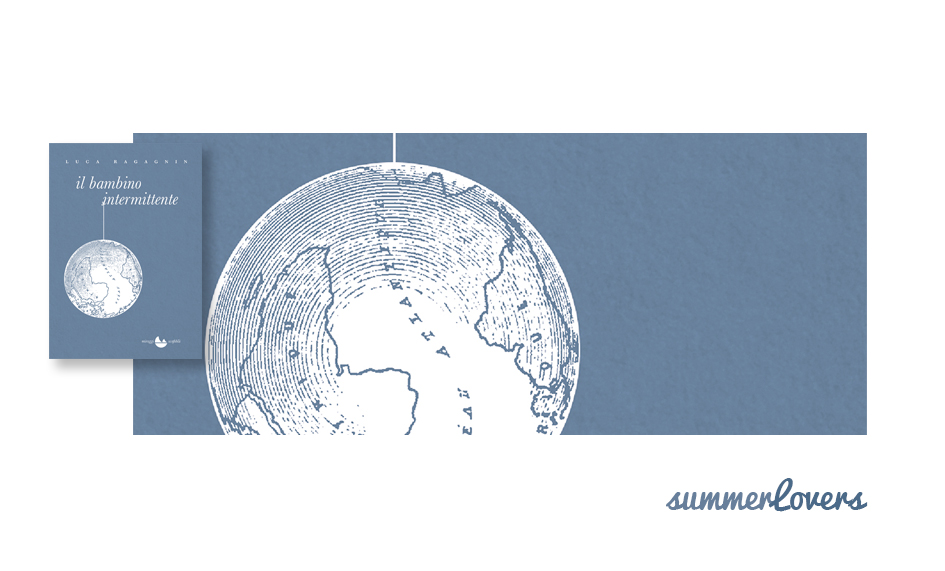
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?