
Numero 18 | Marzo 1999
Ho amato I Malavoglia quando tutti al liceo sbuffavano e alzavano gli occhi al cielo mentre la prof ci dava da leggere a casa uno se non due capitoli del capolavoro di Giovanni Verga.
L’albero di Giuda nonostante sia stato scritto più di cento anni dopo il romanzo del Verga, mette in scena una realtà corale che non poco ricorda quella che animava il paese di Acitrezza. Lo stato sociale dei personaggi è cambiato: là una povera famiglia di pescatori, qui la famiglia benestante di Cornelio Azzarello, Direttore Didattico a Bulàla e naturalmente la sempre presente corte di personaggi minori che ruota loro intorno. Qui come là un linguaggio vivo, originale, ricco nel romanzo di Silvana Grasso di termini dialettali italianizzati, a volte neologismi a forte valenza onomatopeica, che richiedono spesso il ricorso al proprio di dialetto per scovare significati inaspettatamente comuni; frequenti parole in neretto quasi da ricordare come parole chiave, o da distinguere perché più pesanti di altre. Parole nuove. E dove il contesto non riesce ad assegnare un significato al termine intraducibile subentra la fantasia del lettore, il suo sforzo a interpretare l’esatto significato, magari da affinare nelle successive riletture. Riletture da dedicare alla descrizioni che la Grasso sparge nel romanzo soffermandosi sia sui paesaggi che sui singoli personaggi, ritratti con una maestria pittorica non comune e a tutto tondo come: «Su due gambette da cicogna poggiava in un unico pezzo il corpo della Pèttica Borzì perché petto vita fianchi bacino culo costituivano un’unica bolla, cucita assieme dalla pelle».
Le «radici culturali arcaiche della propria terra» stabiliscono i rapporti tra i sessi e guai a non rispettarli perché direttamente da questi discendono tutti i rapporti sociali. Come sfuggire al proprio destino? La cultura eleva, ma se le regole non scritte provengono da un’altra cultura, più antica e più forte perché basata sul potere e l’onore del capo famiglia («Cosa non fa un padre per un figlio!»), come staccarsene senza patire il trauma della non appartenenza e quindi del non riconoscimento, dell’identità negata? Come rigettare i dettami stabiliti senza una concreta e sofferta opposizione al potere paterno? Sasà non se l’è sentita di rischiare.
L’orgoglio del maschio ferito, nonostante la laurea in filosofia conseguita in una città evoluta come Padova, ha prevalso. La sua vita è alla completa mercé prima del padre Cornelio e poi della moglie Maddalenina, ma rimpiangendo l’Ada, il suo unico amore, la friulana per lui forse troppo disinibita («guasta») conosciuta ai tempi dell’università. Non gli resta a fargli compagnia che il solo pensiero del suicidio (impiccato all’albero di Giuda nei giardini della Villa Comunale Regina Margherita), nonché l’abnegazione per il cugino Rorò, costretto all’immobilità da una sequela di ictus e sul quale, perché inerte, può riversare le sue perle di saggezza, perché solo così l’ormai prossimo alla «babberìa» (vecchiaia) Sasà, il filosofo, riesce a guardare al suo passato e al suo presente entrambi frutto amaro della sua rinuncia e della sua vigliaccheria: «Io asino ero, Rorò, io che pensavo alla felicità e all’infelicità come due cose distinte e separate. Due mondi a parte che non spartiscono niente. Invece non era così… nella felicità c’è spesso l’infelicità e viceversa… ecco per esempio il mio amore per l’Ada è stato la più grande felicità della mia vita, ma anche la più grande infelicità… […]. Quando uno è giovane Rorò ha un occhio solo. E con quello vede una volta il bene, una volta il male. A turno separatamente. Quando uno è vecchio Rorò mio ci vede con tutti e due gli occhi… Il bene e il male insieme.». Sasà così si consola: non può contare infatti sull’affetto e il rispetto dei suoi tre figli, per non parlare della moglie che morendo ha coronato degnamente la catena di dispiaceri e di offese arrecategli in vita. Infatti Maddalenina muore egoisticamente prima di lui fregandogli pure la bara, quella bara pronta da tempo ad accogliere il suo di corpo e che custodiva gelosamente sotto il letto dove di tanto in tanto si calava. Una tragedia? Neanche per sogno. Una commedia? Non direi. Una presa in giro? Di cosa e di chi? Di chi crede che sia sufficiente acquisire uno stile di vita evoluto e comune per poter dire di essere moderno, per esempio. E di chi azzerando le differenze culturali sociali religiose sessuali spera di poterci far convivere felicemente in una futura società multietnica. Siamo sul serio così moderni come crediamo di essere? Quali sono le nostre radici culturali? Perché io distante anni luce dalla realtà descritta dal Verga nei suoi romanzi e nei suoi racconti, riesco a leggerli senza avvertire il divario, l’abisso che mi dovrebbe dividere da quel tipo di organizzazione sociale, da quei valori (sono cambiati?). Perché altrettanto ugualmente riesco a partecipare al dramma di Sasà, io così diversa e così moderna? Ma è cambiato davvero qualcosa? Le nostre «radici culturali arcaiche» sono davvero così obsolete? E cosa di nuovo allora le ha sostituite? Non me la sento di dire di sentirmi così lontana da Sasà o da Cornelio Azzarello e dai personaggi che secondo me tuttora popolano la nostra vita, tecnologicamente avanzata ma culturalmente ancorata al passato.
Laura Ivani
Il libro nel 1999
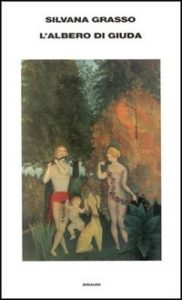 Silvana Grasso
Silvana Grasso
L’albero di Giuda
Einaudi, 1997
264 p., L. 28.000
Oggi in libreria
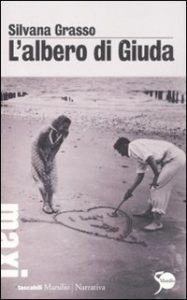 Silvana Grasso
Silvana Grasso
L’albero di Giuda
Marsilio, 2011
Collana: Tascabili Maxi
297 p., brossura
€ 12,00


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?