“a mezzagosto, se potessimo andare sul monte, potremmo assistere al portento delle cento braccia: il cielo ha cento braccia e a mezzagosto, a mezzanotte, le tira fuori dallo scialle di seta nera, e si abbassa ad abbracciare la terra: da questo abbraccio incestuoso, perché il cielo e la terra sono fratello e sorella, nascono vipere, serpenti viziosi e tutti gli esseri molli e traditori che strisciano sulla terra e in fondo al mare” (Lettera aperta, Goliarda Sapienza)
Difficile scrivere su un romanzo di cui hanno già detto tutto. In epigrafe, un verso emblematico di Gabriela Mistral che mi trascina nella lettura con tutta la forza degli abbandoni, degli amori andati in frantumi e dei bambini non nati di cui è capace la poetessa cilena. “Ibamos todas a ser reinas”, promessa infinitamente disillusa, perché il sogno di una vita diversa resterà incastonato negli occhi neri delle regine che non attraverseranno mai alcun mare e non raggiungeranno mai il regno promesso. Perché è un sogno che non dovevamo sognare, è un inganno, e una “desdicha” (quel concetto di sventura e infelicità quasi intraducibile). Lanciata dalla triste autoprofezia arrivo alla fine del romanzo. Camila, l’io narrante torna per l’ultima volta alla casa della Tia Encarna, la “travestí” centenaria che le ha fatto da madre putativa, insegnandole a resistere agli insulti e ai colpi sul viso e nello stomaco, e a fingere, fingere sempre. Blindarsi, anche: “no es posible ser esa prostituta sin antes proceder a una anestesia total”. Encarna che si sarebbe messa sempre davanti a parare tutti i colpi.
Comincio da qui, dai cani, da quell’orda di cagne, tante, una trentina, che impediscono a poliziotti e curiosi di entrare nella casa di Tia Encarna dove da giorni si è compiuto l’ultimo atto di Las malas e l’ultimo della storia clandestina di Encarna e suo figlio El Brillo en los Ojos, che si sono scelti nella vita e nella morte. Quei cani che sono come i travestiti, o i travestiti che rizzano il pelo come cagne, che respingono tutti quelli che fino alla fine hanno sfruttato di notte e umiliato di giorno, reso impossibile la vita di Encarna e che ora vogliono entrare per vedere da vicino, per frugare, cercare, per cancellare le impronte del loro passaggio e delle loro colpe. Le cagne come Bella che protegge la stanza di Irma e Useppe. Dagli animali di Elsa Morante a quelli di Doris Lessing, passando per i frammenti celesti di Ortese, portatori di una sensibilità superiore, schegge in cui si riflette la saggezza dell’appartenenza a un mondo più grande. Quello su cui Camila Sosa Villada, accende un faro violento e magico, tra il buio del Parco, necessario alla prostituzione, e la luce del giorno in cui si vedono le crepe sui muri, l’ombra della barba e le aberrazioni di un corpo di silicone.
Ognuno ha il suo paradiso qui in Terra e spesso quel paradiso è il sogno che gli altri, proprio quelli che dovrebbero esserti più vicino, più cari, avversano. Loro che nel bene e nel male hanno gettato il seme di quel sogno e poi ti hanno detto di non sognarlo. “Todo lo que mediera vida, cada deseo, cada amor, cada decisión tomada, él la amenazaría de muerte”. Ma lei Camila l’ha continuato a sognare mentre nascondeva i trucchi consumati delle cugine, le calze rubate alla nonna, il vestitino ricavato da una tenda di casa per travestirsi prima di uscire e prostituirsi.
Per Camila, trans, scrittrice, attrice, il paradiso è quel perimetro che va dal Parque Sarmientos con “sus zancas”, alla casa della Tia Encarna, il “caseron” rosa, “rosa marica”, rosa frocio, con la vegetazione carnosa che dalle finestre avvolge la casa: un bosco da cui le prostitute ogni giorno “trepan” si arrampicano dall’inferno per regalare la primavera. Qui si dispiega la trama; la fauna che divora sta fuori. In questo bosco incontaminato ci sono sesso e disillusioni d’amore, solitudini e sorellanze, carità e brutalità, vita e morte. Al crocevia tra umano e disumano, dove miracoli e tradimenti sono necessari. Per amore, una supplica d’amore, la più falsa e la più vera.
Il paradiso è il posto in cui il padre, alcolizzato, violento e autoritario, le ha augurato di morire, perché “los putos”, i travestiti (Sosa Villada ha scelto di usare tutte le parole, quelle vere con cui ci prendiamo gioco di quelli come lei, senza politicamente corretto, senza linguaggio inclusivo, perché sa che la partita non si gioca lì) finiscono tutti lì in una zanca, cadaveri sconci in un fossato a lato della strada. Sono condannati a morte. Perché Camila è come Ben, il quinto figlio dell’omonimo racconto di Doris Lessing (The Fifth Child), ferale, diverso, aggressivo, quello che distrugge l’idillio che in fondo non c’è mai stato. Lessing aveva voluto indagare cosa sarebbe successo se nel ventesimo secolo fosse venuto al mondo un elfo, una creatura di un’altra epoca. E aveva concluso che nella nostra società sarebbe stato considerato “cattivo”, “portatore di male”. Il padre di Ben prova repulsione; Harriett, la madre, sperimenta l’unica cosa possibile l’impossibilità di essere una buona madre nella cultura patriarcale. “Yo no pertenecía a aquella familia, estaba desterrada por ser quien era, yo no pertenecía al núcleo que formaban ellos dos”, scrive Sosa Villada.
Il paradiso è il posto in cui scontare la colpa senza redenzione, perché la vergine e il suo bambino moriranno ancora e ancora, perché in fondo una vergine di silicone e un bambino gettato e abbandonato in un fosso sono sempre stati un peccato. “Por eso se hace tan necesario, urgente, positivo y bello que escribamos y soñemos. Porque todas tenemos distintos sueños”. Le travestì sono sogni ambulanti, incarnazioni di disagi e desideri, su dei tacchi acrilici impossibili. Altri sogni, pericolosi, perversioni da cui hanno ritirato ogni incanto. Quell’incanto che Sosa Villada ci vuole restituire più di ogni altra cosa, più della violenza e della speranza d’amore che accompagna tutti quegli incontri occasionali. L’incanto che non c’era eppure l’unico che è rimasto nella memoria di quei giorni. “En momentos así, una desea ser capaz de recordar. En momentos así, una se encomienda a la memoria”.
Sosa Villada scrive la sua vita, gli anni di prostituzione quando non era neppure diciottenne, la sua, senza rubare niente a nessuno, niente al mondo. Eppure, questa storia è finzione pura, tanto da liberarsi dalla realtà e arrivare naturalmente a quel realismo magico di cui Sosa Villada si è nutrita (da Marquez a Allende), e che in America Latina, più che essere una questione di genere letterario, sta all’angolo delle strade, in ogni lacrima azzurra, nelle storie di tutte le sue vergini con i loro miracoli senza misura, tutti terreni e soprannaturali. Come la Difunta Correa, donna leggendaria trovata morta nel deserto con il figlioletto neonato attaccato alle sue vesti, succhiando il seno e sopravvivendo. Come la vergine di Guadalupe che a furia di piangere ha sciolto lo smalto sgargiante e raccapricciante che la ricopre senza che siano successi miracoli.
E allora la realtà, nelle varie cappe della scrittura, si intreccia alla fantasia, il diario degli incontri con i clienti con le pagine della storia della Tia Encarna, incunabolo di un altro romanzo; la fantasia esaspera la realtà, rendendola ancora più terribile e reale. Il surreale in fondo è solo la quantità di realtà di una storia. Queste sono forse le pagine più belle del romanzo, dagli Hombres sin cabeza, veterani di guerra, che sanno amare i travestiti proprio perché sono decapitati, perché la testa è solo una sovrastruttura, un artificio: “qué hermosa estás mi amor”. Dalla fossa, dalla bara, tra sterpi di spine, nasce l’umanità assieme al Brillo en los ojos. Maria la muta che emette suoni di un capretto pieno di ira e di amore, prima di trasformarsi in un uccello, il patio della casa della Tia Encarna che è una selva sempre più fitta e impenetrabile, Natalia, la lobizona che nelle notti di luna piena deve rimanere rinchiusa a forza nella sua stanza. La Machi, un travestito paraguayano, che le salva e le benedice, le battezza, le sposa e le seppellisce come una santona, l’unica a cui hanno diritto.
Ma la cosa più magica è il vincolo quasi sacro, che si stabilisce tra i personaggi di questa comunità che non lo è perché vive ai margini dell’umanità e della comunità (quella marcata dalla rispettabilità più che dal rispetto). Quel vincolo che più di ogni altra cosa Sosa Villada vuole restituire a sé stessa e alle sue compagne di sventura. Quello che stava in una risata, mentre andavano tutte assieme a finire l’alba davanti a un furgoncino che vende qualcosa. Tutto quel consolarsi a vicenda per le malattie e le disgrazie proprie e altrui. Tutto quello che le univa sotto l’unico cielo che sa perdonare, quello dei travestí. Assieme alla possibilità di salvarsi, anche per un travestito come Nadine e una prostituta come Laura (la prostituta embarazada), perché la felicità esiste.
Ne La vita immaginaria, Ginzburg parla della scrittura come della “maniera insieme imperiosa e devota di muovere dentro di noi i fatti reali”. Nella scrittura di Ginzburg non c’è esuberanza di fantasia, anche l’atto creativo resta in qualche modo allineato ai fatti. Per molto tempo”, diceva Ginzburg “noi pensiamo di essere le sole persone al mondo ad avere una vita immaginaria. Tardi arriviamo a capire che è una cosa di molti, forse di tutti”. La capacità di immaginare che ci appartiene è quello che permette ai travestiti del Parque Sarmientos di andare avanti, quel breve sortilegio necessario. Ed è quello che Sosa Villada vuole salvare.
La scrittura diventa un terreno instabile, luogo di un ulteriore trasformazione (per tutti le favole sono state un atto unico assieme ai travestimenti): è il morso che contagia di animalismo, sono i denti del vampiro. Questo romanzo è una cronaca dei suoi giorni da prostituta o un romanzo a tutti gli effetti, è un libro e basta (dice con un certo imbarazzo Sosa Villada), non è letteratura se la letteratura è lo spazio in cui si è perpetrato il patriarcato, una immagine della donna ridimensionata e sessualizzata. È poesia, teatro e fantascienza (quel filone di letteratura fantasy scritta da donne come luogo per denunciare le diseguaglianze e creare nuovi mondi possibili fuori dei codici patriarcali).
Mentre tutto si trasforma con urgenza e prepotenza, nel corpo e sulla pagina, resta una specie di nocciolo, che si può solo limare, una specie di simulacro di identità, ridotto, quasi annullato, ma mai del tutto. Questo nocciolo non è femminile. Il femminile scappa da tutte le parti, nella voce, nei gesti, poi, nei vestiti strizzati, nei tacchi impossibili, nel desiderio così femminile di scrivere. Nel desiderio infertile di maternità. Il femminile è necessario, sta lì da quando Camila si è identificata con la madre per darle una nuova vita, per salvarla da quella vita vissuta come un’appendice di suo marito, pronta ad essere abbandonata per un’altra donna, a subire la cintura, i castighi, le colpe, qualsiasi cosa pur di non vedere. “Yo digo que fui convirtiéndome en esta mujer que soy ahora por pura necesidad”.
Quel simulacro di identità è assolutamente maschile. E Sosa Villada non lo vuole nascondere “Tengo un cuchillo entre las piernas”. “Era un cuero seco, viejo y duro, dentro del cuerpo de una criatura de dieciocho años”. Sosa Villada riesce a restituirci lo scontro violento con l’uomo dentro che vuole essere espulso: con l’uomo patriarcale più primordiale, con quell’uomo che sta prima dei divieti e delle discriminazioni, in cui ha cercato di domare e nascondere tutti i suoi desideri e istinti inconfessabili. “Lo aprendo muy pronto, somos necesarias en el deseo, en el deseo prohibido de los habitantes de la tierra por nosotras”. Fino alla fine: il cuore batte, s’arresta, scrive Teresa Ciabatti.
Silvia Acierno

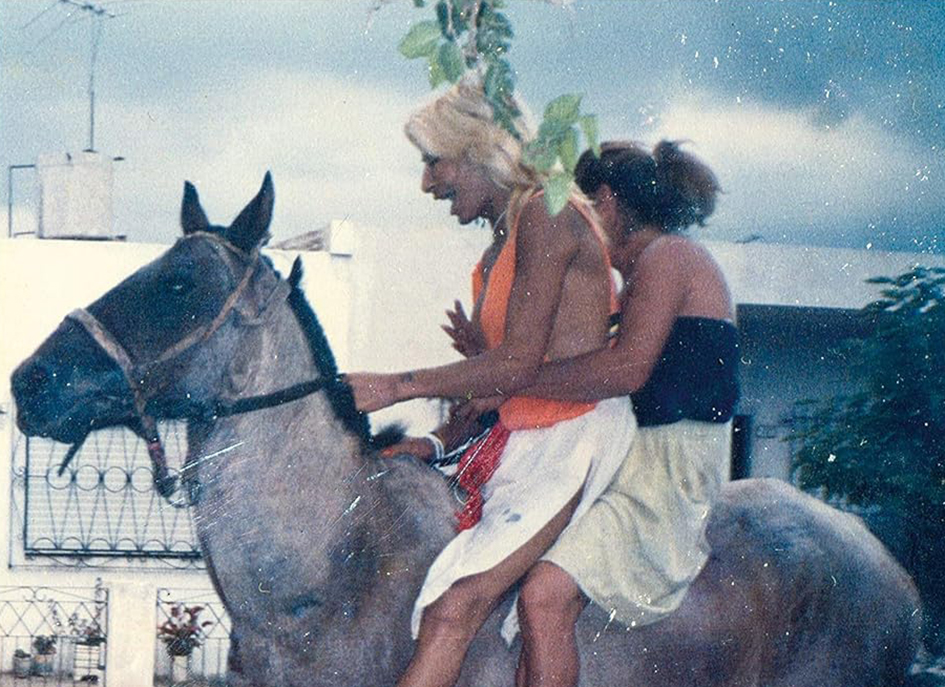
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?