La mia vita è vuota, stentata, ogni giorno che passa mi sembra uguale all’altro, a tutti gli altri, come il tran tran di un treno nella notte
(A M Ortese, Corpo celeste)
Giulia e Nino, la narratrice e un bambino rimasto orfano di madre che vive sullo stesso pianerottolo di una palazzina romana, e di cui lei sceglie di diventare la madre prima ancora di aver deciso di sposarne il padre. Perché le ragioni che determinano le nostre scelte sono spesso curiose forme di immedesimazione: anche Giulia ha perso la madre da bambina. Del resto Laudomia Bonanni intitola “Infanzia della bambina” la prima delle quattro parti in cui il romanzo avanza, speculare all’infanzia del bambino, titolo della seconda parte, perché quelle due infanzie a metà non smettono di chiamarsi. Poi seguono le fughe e la droga. Si perché Nino, quel bambino insicuro, che stringe forte la mano di Giulia e si arrampica sulla schiena della sua nuova mamma, scomparirà un pezzetto alla volta nel buco dell’eroina. Quel dente che va ingiallendo poi si macchia prima di lasciare uno squallido buco, -mentre Giulia lo osserva bloccata senza essere capace di dirgli di farselo curare-, era un segno, nefasto come un altro punto di stelle.
Qualche anno prima era uscito Noi i ragazzi dello zoo di Berlino (lettura lontanissima eppure così vicina, tutta d’un fiato, in un punto di una notte), da cui nel 1981 era poi stato tratto il film. Nel 1982, quando esce questo libro, l’ultima pubblicazione di Bonanni (che possiamo leggere grazie alle edizioni Cliquot), nessuno scrittore italiano aveva ancora raccontato così quella piaga, “il massacro quotidiano dei nostri figli”. E invece Bonanni, che per vent’anni aveva lavorato nel Tribunale minorile, in poche pagine racconta tutto quello che non si può tralasciare, tutto quello che l’istinto materno di Giulia non ha visto o non ha voluto vedere, tutto quello che fa troppo male e che ritorna all’improvviso d’un colpo, come un pugno in pieno viso: l’odore dolciastro, la cinghia dei pantaloni del padre, il grumo di stagnola, il cucchiaino scomparso, ovunque, anche nel bagno di casa, dappertutto, anche al piede anche nel buco del culo, “la spada contro sé stessi”. E poi la vergogna, soprattutto quella di Nino, i ricatti emotivi, dubbi, panico speranza. Tutto calibrato su quell’asse madre-figlio in cui più lei cerca più lui fugge, in cui in fondo le fughe dell’uno sono state anche le fughe dell’altra. Quell’asse che resta piantato e avvitato comunque, anche dopo, anche quando tutto è oramai franato. In trappola eppure ancora in fuga.
E poi c’è il mare, il polmone della storia, con il suo respiro libero e pulito; il mare verso cui tutto rotola senza disciplina, come una calamita, con la sua estate che è sempre quella che viene dopo un’altra estate, con l’ultimo scoglio, con l’ultimo rastrellatore di telline, “l’ultimo trabocco col pescatore funambolo in aria”…
In un paesino sul colle con il mare ai piedi, la narratrice è cresciuta libera in casa di una prozia invalida, tra le mani delle vicine che badavano a lei e all’anziana zia, e le spaselle di pesce a pranzo (che cito per il gusto di scrivere una parola che per me è piena di sapori). Questo è il posto dell’identificazione con il figlio che è un figliastro perché Giulia non l’ha partorito. È il posto delle promesse, che si rispettano sempre a metà; è l’unica fine possibile di una storia che non ci vuole intrattenere. Ma soprattutto è il luogo della riconciliazione. Cosa vuol dire riconciliarsi, poi? Sullo scoglio, nella vista da lassù, tra l’odore di liquirizie da succhiare e quello delle arance selvatiche, dalla stradina lontana dai lidi, dove l’ordine naturale delle cose è immutato, ed è sempre più amichevole di qualsiasi altro paesaggio urbano. Nel luogo in cui si arriva dopo che ci sono stati già il dolore e la rabbia che è sempre contenuta perché in fondo Nino non è suo figlio. Riconciliarsi non vuol dire trovare la pace, la serenità, (le storie di Bonanni non hanno niente di idilliaco, piuttosto il contrario): la riconciliazione segna semplicemente la scomparsa di qualcosa. Per la narratrice è la scomparsa di quei sentimenti troppo intimi per raccontarsi, seguiti alla morte misteriosa della madre. È l’abbandono che prende forma di abbandono (il padre, un giudice di tutto punto, la lascia alle cure della prozia che però non esce di casa). Per Nino è la breve scomparsa della paura di essere abbandonato. Quel passato che è un mostro che ti porti appresso.
Il passato di Laudomia Bonanni è fatto di cose semplici, portate avanti con una certa dedizione ed ostinazione: la lettura sin da bambina (la madre maestra elementare le insegna presto a leggere e a scrivere), ovunque (mentre è a tavola tra i rimproveri del padre), la scrittura (anche questa ovunque, sui banchi di scuola, nei quaderni di scuola, tra una lezione ed un’altra), e l’insegnamento, che poi la porterà ad una lunga esperienza come consulente del tribunale minorile. Questa vita dedicata alla scrittura si è presa tutta, anche la possibilità di una relazione stabile e soprattutto il desiderio di avere un figlio, desiderio che si convertirà in rimpianto, forse l’unico o il più acuto (lo racconta in un’intervista a Sandra Petrignani). Ostinazione e qualcosa di estremo: diventa subito maestra elementare, ha appena diciassette anni, e se ne va ad insegnare in paesini di montagna sperduti ed isolati, nella provincia abruzzese (era nata a L’Aquila). Eppure in questa donna giovane, ostinata, solitaria, c’è una parte di sé più mondana che aspira a qualcosa di più di quella vita di provincia, che vede l’opacità di quella vita da maestra elementare. Cerca di trasferirsi a Roma, manda i racconti del Fosso al Premio Bellonci e vince (vincerà poi il Premio Viareggio con L’imputata, e il Premio Campiello con L’adultera). Con il successo, negli anni cinquanta e sessanta, Bonanni si ritrova sostenuta ed ammirata dai grandi della letteratura italiana del novecento da Morante, a Moravia, a Banti, ecc. ma poi quando quella folata passa, e la critica e persino il suo editore (Bompiani) la ignorano, è capace con la stessa amarezza di una Ortese di affermare quanto il Premio Strega sia “un servizio editoriale, un gioco di squadre”, in cui tanto, si sa da prima chi riceverà il premio; e di quanto quel gioco di squadre, e la società letteraria sia capace di divorare le opere migliori e promuovere sottoprodotti letterari. E come Ortese anche Bonanni (che Montale aveva paragonato a Joyce) scelse per forza l’anonimato e la solitudine. Una solitudine fatta di depressioni e nevrosi, del rifiuto di Bompiani di pubblicare La rappresaglia (per Giulia Caminito, quel romanzo scritto da una donna che era stata iscritta al Fascio, un romanzo sulla ferocia dei partigiani e dei fascisti, fu silenziato), la costatazione di un fallimento e la decisione amara di smettere di scrivere. A Roma “lontana dalle sue montagne e non c’è ragione per tornare e non c’è ragione per restare” (Caminito, Amatissime).
I libri per Bonanni dovevano essere pietre che colpiscono, lo racconta nella sua intervista a Sandra Petrignani (Le signore della scrittura). Eppure Le droghe uscì senza pena né gloria, non perché non avesse centrato il bersaglio ma per quelle ragioni arbitrarie che decretano il successo di un autore e l’insuccesso di un altro, chi pubblica e chi no. Non è solo l’opera che deve colpire come una pietra, ma è proprio la scrittura che nel suo sforzo estremo di concisione si fa pietra, quelle poche parole della gente di provincia, isolata, su tra le colline. Una parola che rintuzza sempre contro le quattro pareti della pagina e della vita. Una parola conchiusa che porta in sé tutto quello che non si può dimenticare di una storia. “Una bomba inesplosa” su una spiaggia che è un paradiso verdeazzurro, come l’infanzia della narratrice, di Nino, di tutti noi.
Ma soprattutto la scrittura sta lì per raccontare (senza raccontarlo mai esplicitamente, perché appunto l’originalità di Bonanni è proprio questo silenzio, l’audacia di questo silenzio, stupidamente apostrofato come “bozzettismo”) tutto il rimosso, quello che è celato, tutto ciò che stava all’inizio e che forse ha spinto il corso degli eventi -e la vita dei protagonisti- in una direzione piuttosto che in un’altra. Bonanni lo racconta indirettamente, avvicinandosi e discostandosene, attraverso la storia che scorriamo tra le mani. E così Le droghe si costruisce attorno all’immagine fulminea (quasi surreale, lontana dal realismo o verismo, a cui si associa la scrittura di Bonanni) di uno schizzo di sangue sulla parete, su cui rimane impresso per sempre il corpo della giovane madre (come una crocifissione); e quell’immagine ancora più imprendibile che vaga dal letto in cui si spegne lentamente la madre naturale di Nino al divano dove ritroviamo il bambino succhiando la pezzolina. E poi ancora quella del corpicino di un neonato (Giulia resta incinta ma il bambino non sopravvive perché lei è nata sotto il segno della luna infranta) “estratto a forza col ferro e brutalizzato clinicamente”. E quest’immagine che è una macchia (più astratta che figurativa) è sempre la perdita della madre o della maternità. E Bonanni la fa arrivare fino a noi che credevamo di essere andati molto lontano e di avere aggiunto molto altro.
Bonanni possiede poi una capacità assolutamente contemporanea di raccontare il rovescio delle storie e dei sentimenti: della maternità racconta le strade della non-maternità, dell’infanzia l’abbandono (lo farà anche ne La rappresaglia), o l’affidamento che continuiamo a chiamare abbandono (la cronaca della storia del bambino affidato a Milano alla culla per la vita) e ci dice già che “forse sarebbe meglio non avere una sola madre né una vice, ma tante madri in scambio di comunità”; della crescita di un figlio tutte le volte in cui (come nella Pietà di Michelangelo, che Nino e Giulia osservano assieme come l’ennesimo presagio) un figlio ti sfugge dalla presa, tutti i vicoli in cui un figlio sfugge alla vita.
Della brutalità dell’amore. Del cammino di questa madre e di questo figlio che non è dove va ma quel pezzetto che abbiamo fatto assieme. Della conclusione di un romanzo (e di una vita, quella di Bonanni) che non è, non può essere consolatoria.
Silvia Acierno

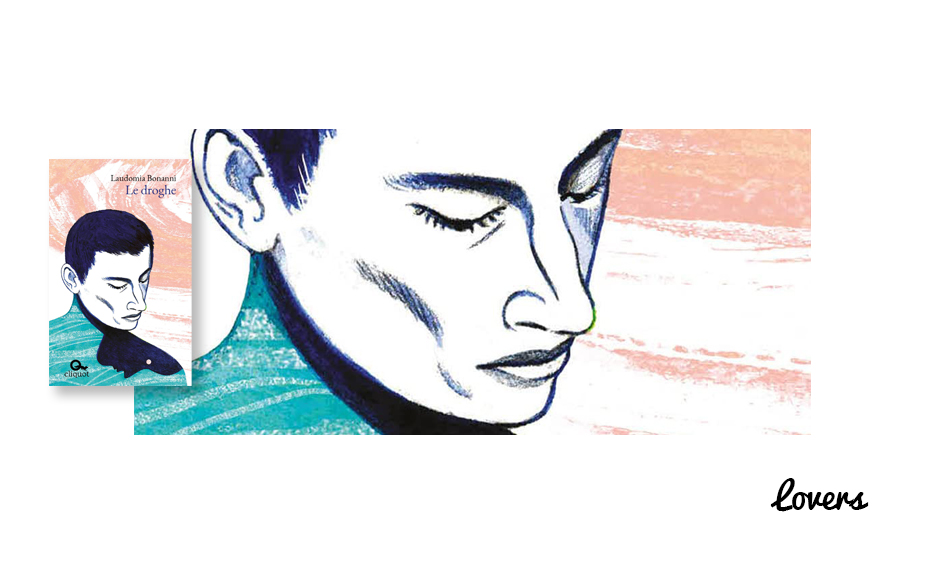
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?