Pubblicata nella collana Portosepolto di Luca Pizzolitto per i tipi di peQuod, Feriti dall’acqua mette in campo un linguaggio minuto e indagatore, dal taglio altamente speculativo nonché esistenziale. Pietro Romano ha portato a compimento un’opera matura, asciutta ed efficace, ma anche altamente espressionista, capace di fondere i piani percettivi a partire da un sentire profondamente interno, ma non per questo estraneo al reale. Nello specifico i piani su cui agisce la scrittura potrebbero essere così suddivisi: l’Io poetico, l’ambiente intessuto, la rielaborazione delle percezioni. Questa stratificazione, a parere di chi scrive, non va sottovalutata. Lo sguardo di Pietro Romano si struttura in un moto ciclico: muovendo dal soggetto si riflette su un soggetto-oggettivato (spesso l’autore stesso il quale coincide con il lettore a volte), (in)filtrando il vissuto sia personale sia globale all’interno di un procedimento di lucida trasfigurazione.
Sonno di cosa, la pioggia sui vetri.
Case nel dormiveglia dello stare.
Da vuoto a vuoto lo spazio di strade,
a ogni passo non so dove l’affanno.
Io da bambino, voce di confine,
smembrato nella vita di ogni giorno.
La musica senza tempo degli endecasillabi, in cui si assiste al crescendo dell’Io, dispiega tre distici privi di rime. Nel primo il soggetto umano appare del tutto assente, lo si intravede negli occhi del poeta, ma resta per lo più nascosto dall’umore generale. Nel secondo comincia a farsi largo in quel non so dove, presagio del dubbio ineludibile. Nell’ultimo si manifesta in un flashback, nel caso di Pietro Romano un vero e proprio gioco retorico volto a rivelare, seppure in minima parte, l’altrove lambito dai distici precedenti.
Colpisce la peculiarità dell’incedere: la semantica franta dell’incipit conferisce un corpo testuale immediato e definito sebbene esteso nella patina del vuoto che il poeta riesce ad armonizzare attraverso una precisa disposizione di accenti. Qui si sprigiona la musica segreta del componimento, laddove, anche nei versi successivi il temine stare scolora in strade e confine si perde in giorno. Se prendessimo i primi quinari di ogni distico (Sonno di cósa, Da vuoto a vuóto, Io da bambíno) potremmo formare quasi una poesia nella poesia, eppure si noti quale potenza e sommessa propulsione riesce a imprimere un piccolo corso confluendo nel mare della ricerca del senso.
Che sia proprio il senso a costituire l’indagine della scrittura di Pietro Romano? L’autore si pone sulle tracce del reale (ossia tutte le componenti che impattano sul dato percettivo, dunque anche quelle che i più bollerebbero come fantasiose) attraverso gli strumenti espressivi offerti dalla scrittura. Depuratosi da un’espressione puramente tecnica, riporta il dato su carta (o foglio elettronico, se preferite) e rende l’atto dello scrivere parte di questa enorme realtà rappresentata. Proviamo a fare un esempio:
La lingua estrae le sue vene dall’acqua,
da una casa all’altra la voce si attarda.
L’argine erode il labbro: predice
il bicchiere vuoto su un angolo del tavolo.
Dietro di noi assenze ramificate.
Qui la scrittura si fa testimonianza di lingua e voce che passa dalla bocca (labbro). Scrivere è il tentativo di riempire lo spazio, ma a differenza dell’oralità permane: gli esercizi di convivenza con il nulla possiedono un’ostinata voglia di resistere. Pietro Romano ce lo mostra con malinconico e arreso garbo, tramite uno stile riflessivo, allusivo e penetrante.
L’acqua, in qualità di elemento naturale tangibile, ma inafferrabile, viene eletta quale figura prediletta all’interno di quest’opera. Si ha la sensazione di essere alle prese con una enorme metafora: l’acqua è la vita stessa e nelle proprietà che la contraddistingue si intravedono tutte le caratteristiche relazionali tipiche degli avvicendamenti odierni. Senza scomodare la società liquida di Bauman, la poesia essendo dotata di un proprio linguaggio non ha bisogno di spiegare, ma solo di mostrare. Pertanto questo fluire, incunearsi, attraversare, cambiare forma, essere inafferrabile vale il moto per sé. La vita è tale nel proprio svolgersi. Come mai, ci sarebbe da domandarsi, l’acqua ferisce? Non si vive senza dolore, l’atto stesso della nascita contiene in sé un dolore enorme, ma il poeta ci parla per immagini, dunque con maggiore efficacia. La scomposizione dell’io e dell’ambiente circostante risultano tentativi indagatori ed emulazioni di ciò che si identifica nell’essere attraversabile eppure mai pienamente definibile. Arbitro e giudice della limitatezza appare il silenzio la cui scomposizione di pensieri e figure umane indaga un mistero: se la vita si svolge nel corpo, quest’ultimo presenta chiari limiti di comprensione, dunque diventa coscienza che si addentra nelle ambientazioni restituendoci un paesaggio inquieto. Uscire dal proprio corpo non è rassicurante, né semplice, ma restare sempre confinati in noi stessi suona come una preclusione inattuabile. Di tanto in tanto si affaccia qualche figura umana, quella del padre, per esempio, in una delle liriche più personali dell’autore siciliano.
Padre dentro di me precipitato,
serrato nella pelle delle cose
inabitate: per non smarrirmi ora
che dietro la schiena
non più resiste
il calco dell’ombra al tuo passo,
le ferite ugualmente distanti,
riconoscimi almeno il tepore
dell’addio, chê a rimanere qui
affamati d’amore non si vive.
Feriti dall’acqua ad ogni moto sottende un trauma collettivo, ma non si sottrae a una dolente continuazione («riconoscimi almeno il tepore dell’addio»). Non vi si scorge il senso ineludibile della morte: ciò che non uccide, fortifica e la forza non può che venire dal lascito e dall’immaginazione, dalle origini, dalla ricostruzione di uno spazio chiamato casa. Una visione vagamente pascoliana, che tuttavia resta sullo sfondo col suo persistere sfuocato. Le dimore sono pur sempre luoghi in cui ritrovarsi, a patto che si abbia la capacità e la possibilità di restarvi sentendole proprie.
Federico Preziosi
Potresti leggere anche:
L’oltranza
Loriana d’Ari – silenzio, soglia d’acqua
Ida Travi – Muscèt parla col cane

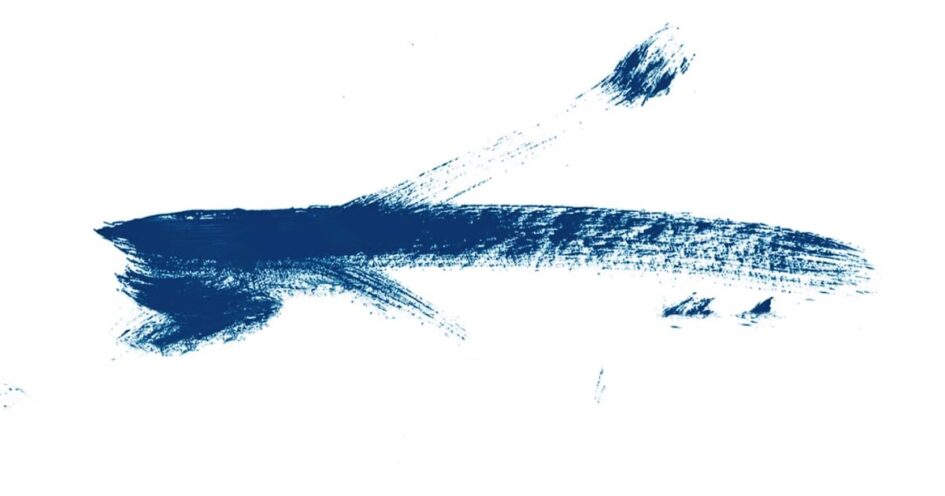
 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?