Piera Ventre ha scritto un romanzo molto bello, una storia che come tutte le storie non è ancora stata scritta, anche se le esperienze umane sono spesso così simili quando le denudiamo da sembrare le stesse, eppure sono sempre solo quasi le stesse. Leggendo le Sette opere di misericordia, secondo romanzo della scrittrice, non si può non pensare ad Elena Ferrante e appena un po’ più lontano ad Anna Maria Ortese e a Elsa Morante. Quello che l’avvicina profondamente a queste scrittrici è qualcosa che non sta nell’arco del romanzo, non si compone di analogie narrative o stilistiche, che non importano poi tanto, né di influenze o filiazioni che non aggiungono né tolgono merito ad un romanziere. Non ha a che vedere con il carattere classico o meno dell’impianto narrativo, aggettivo caduto in disgrazia, in un epoca in cui il presente è già postumo. Ma è qualcosa che ritrovo prima del romanzo, e che poi nei tornanti della scrittura prende forme e soluzioni originali. Ed è di questo che voglio parlare in queste pagine, di ciò che sta prima e di cui sentiamo l’eco. Voglio parlare del buio dove si formano le parole di alcuni romanzieri; del suono che le parole fanno perché quelle di Ventre crollano a terra dove si frantumano, sono parole “di frantumaglia”, avrebbe detto Ferrante. Degli strappi da cui si intravede la realtà, piccoli disvelamenti. Della matrice materna attorno a cui in qualche modo si addensano le parole di queste romanziere; della scrittura che si prolunga nelle cose che la circondano ed infine della tenerezza, che forse tiene assieme tutto ciò.
Il buio. La storia dei membri della famiglia Imparato, protagonista di Sette opere di Misericordia, si intreccia a un fatto di cronaca lontano che Piera Ventre ripesca per tutti noi. Verso la fine degli anni settanta, un bambino in visita ai nonni nella campagna romana si perde per i campi. In realtà è precipitato in un pozzo artesiano da cui non riusciranno più a tirarlo fuori. La fine straziante di Alfredino, così si chiamava il piccolo, fu seguita in diretta a reti unificate (una prima cronaca-reality a cui oramai siamo abituati), in tutti i tentativi concitati, assurdi, disperati di cavarlo fuori di lì. Di riportarlo in superficie. Il buio di quel pozzo verso cui converge il racconto ma da cui in realtà proviene, incombe sulle storie dei protagonisti, svelandosi pezzo a pezzo, ma vorticoso sin dalla prima insinuazione nelle pagine del diario che il piccolo Nicola nasconde nella sua stanzetta. Il buio del pozzo è la cecità che accomuna tutti i protagonisti. Questa cecità, come la sordità di cui parla Claudia Durastanti ne La straniera, non è solo una disabilità, una eccezione o una destinazione comune a tutti noi. Qui, come per Durastanti la condizione di straniera, è anche un origine, il posto da cui proveniamo. La cecità in qualche modo aiuta i personaggi di Ventre a proteggersi, a tirare avanti tutti i giorni nonostante la miseria e tutto quello di cui la povertà è fatta. Poi il buio, come il pozzo da cui arrivavano i lamenti di Alfredino, ingoia ed amplifica le loro angosce. E finalmente li porta anche ad una specie di svolta, forse modesta, forse banale, forse trascurabile.
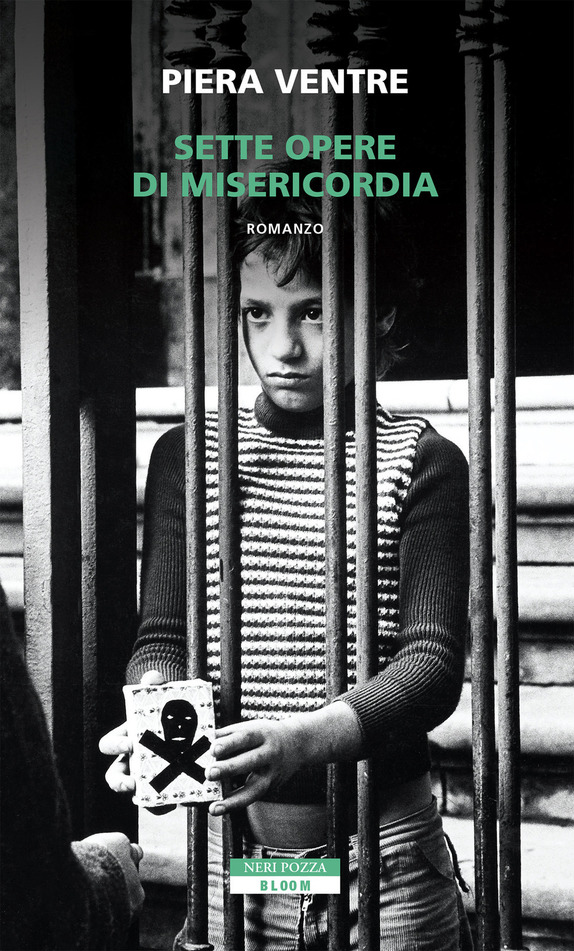
Nicola, il figlio più piccolo, gioca a fare il cieco, come abbiamo magari provato a fare tutti noi qualche volta da bambini, per vedere come ci si sente ad essere cieco, avanza a tentoni, tasta maldestramente le cose al buio, per provare a dargli una nuova forma, più sopportabile, meno molesta. Rosaria, la ragazza-madre che gli Imparato ospitano in casa perché è stata cacciata di casa sua per la vergogna, con la vista appannata per gli sbalzi di pressione dovuti alla gravidanza, vede nel mercato rionale una specie di eden. Cancellando le brutture, riesce a riconoscere più facilmente le vere storpiature, a vedere meglio i gesti e le espressioni senza senso che nella loro imperfezione, distaccata dalla sovrapposizione dell’immagine dell’eden, sono ancora più reali. Rita, sorella di Nicola e compagna di classe di Rosaria, quando penetra nei cunicoli neri, putridi e abbandonati dell’Ospizio della Misericordia, nel buio, anche lei avanzando a tentoni, entra in contatto con la realtà, un’umanità che non vede chiaramente ma di cui sente come uno schiaffo l’olezzo. Luisa, la madre, quando si sfila la vestaglietta e si immerge nella vasca, chiude gli occhi e la città tutta, gocciola, si scompone goccia a goccia, e le mattonelle del bagno cadono una a una. E il cardellino vola fuori della gabbia. Cieco è il marito, guardiano del cimitero, quando perde anche l’altro occhio. E al buio scende, accompagnato dalla voce dei cronisti, e dai racconti dei figli, nel buio del pozzo di Alfredino. In quel buio che si somma al buio, tocca il bambino, lo accarezza, lo vede.
Ma il buio-pozzo è soprattutto il posto da cui provengono le parole di Ventre. Così come dal buio angusto proviene la storia di L’amica geniale, dal buio dello scantinato del casarmone napoletano dove vivono Lena e Lila, che ingoia le loro bambole, Tina e Nu. Questo episodio rappresenta il punto che permette il salto verso le fantasticherie intorno al destino di quelle bambole. Le avrà prese don Achille, che è il lupo, l’orco? E chiude circolarmente il racconto quando, alla fine della storia, liberate dalla carta di giornale, le bambole “schizzano fuori dalla memoria” e così il futuro di romanziera di Lena. Un posto dunque in cui si perde l’infanzia e comincia la scrittura. Anche Delia, la protagonista di L’amore molesto, riscende nello scantinato umido per prendere l’abito della madre Amelia. Lo scantinato è allora anche il luogo dove è possibile la riconciliazione con la madre attraverso la scrittura. E ancora il buio che ingoia la bambina perduta di Lila (Storia della bambina perduta). In cui Lila scompare, com’era scomparsa Amalia. La scrittura in questi romanzi è dunque un volo basso, una discesa nel pozzo, nello scantinato, nel gorgo, nel labirinto del passato, dell’infanzia, nella frantumaglia, nel luogo delle intrusioni e delle influenze sotterranee. Ma da lì si risale. Perché poi si scrive in superficie.
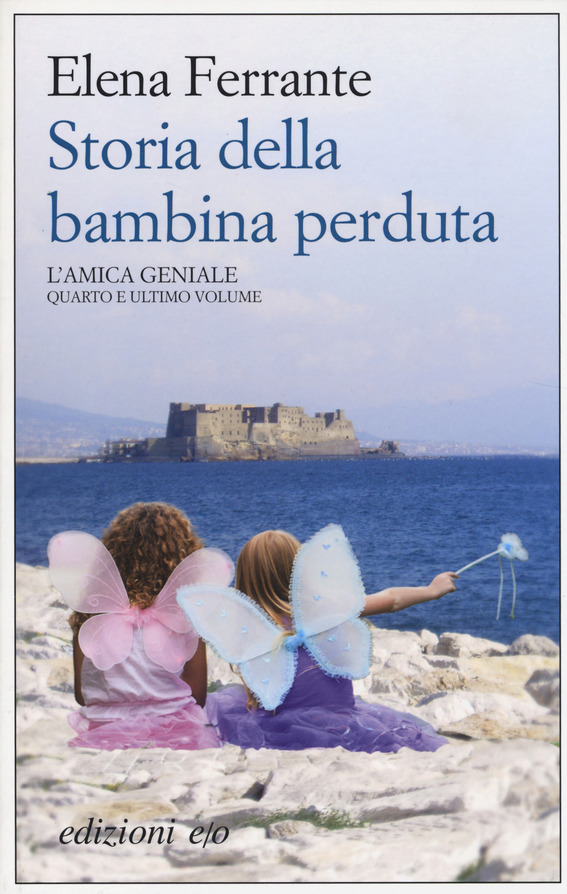
Le parole che provengono dal buio anche se quello spazio è una specie di cassa anecoica, fanno rumore. Si sente il risucchio quando entrano in quel posto e poi i suoni quando sono sbattute sulla pagina. Sono parole storpiate dal tempo, mangiate dall’ossido, sbeccate, azzannate dalla nostalgia. Parole di frantumaglia. Fuoriescono da scuciture, e si sparpagliano per terra come gocce d’inchiostro. Insomma sono parole piene, che pesano e in un certo senso esistono. E il dialetto napoletano che Ventre usa in modo ancora più disinibito rispetto a Ferrante (entrambe seguendo il lontano esempio di Elsa Morante), con le sue parole disarticolate e sguaiate amplifica la consistenza della voce narrante. Uocchiebelli, pazzèamm’, vavattenne. Ci sono scrittori che osservano fissamente il segreto, il buio, mantenendosi al margine, con parole che calmano le emozioni quando sono eccessive e le accelerano quando queste sembrano fermarsi ed è come se non stia accadendo niente. Per altri, quel buio è piuttosto un abisso popolato di apocalissi, lupi mannari e mostri, qualcosa da cui non possiamo separarci, uno strato di pelle in più, un ultrasuono, con cui si resta in un’intimità continua. Chi perlustra il buio, invece, come fanno queste scrittrici, cercando le parole pronunciate o sentite pronunciare, quelle storpiate dal dialetto, antiche, scende nel fondo, nella “materia prima”, dove la parola e la voce sono rimaste impigliate, in angoli stretti, nei cunicoli. Da lì quelle parole schizzano fuori implacabili.
Nel buio dove le parole si fanno di carne, l’origine della scrittura ha la forma di uno strappo, uno squarcio nella percezione della realtà, una “smarginatura” (altra parola cara a Ferrante). Ne L’amica geniale, Lila è sul balcone quando succede per la prima volta quell’esperienza da cui in qualche modo nasce il romanzo o che gli permette di avanzare con un ritmo narrativo che arresta e libera energie. È la vigila di Natale. Le famiglie sono affacciate ai balconi e alle finestre per vedere i botti. Napoli scoppia, salta in aria. È un allegria che non sa controllarsi. Che eccede sempre come tutte le manifestazioni di questa città. Fa saltare la cronologia e ogni ordine. E la voce narrante sprofonda in una sorta di anacronia. “Il 31 dicembre del 1958 Lila ebbe il suo primo episodio di smarginatura. Il termine non né mio, lo ha sempre utilizzato lei forzando il significato comune della parola. Diceva che in quelle occasioni si dissolvevano all’improvviso i margini delle persone e delle cose…la capacità di uscire fuori di sé, di trasferirsi dentro altri contorni, di violare i contorni stessi delle cose e delle persone”. Ma succede anche a Lena: “avevo l’impressione che … le superfici solide mi diventassero molli sotto le dita o si gonfiassero lasciando spazi vuoti tra la loro massa interna e la sfoglia di superficie.” Il senso di nausea, la repulsione, il ribrezzo.
La smarginatura è sinonimo di frantumaglia, di cui Ferrante parla in quel piccolo saggio meraviglioso cha raccoglie sotto questo titolo vari scritti. Frantumaglia era la parola che usava la madre per esprimere uno stato d’animo confuso, probabilmente di sconforto e depressione. Quando tutto sembra buio e così terribilmente chiaro allo stesso tempo. Quando all’improvviso nella catena monotona dei giorni qualcosa si spezza, si frantuma e tutto intorno la realtà stessa si frantuma perché in qualche modo tu stessa la stai frantumando. E allora, tutto anche le lacrime diventano di frantumaglia.
Dalle crepe escono fuori delle visioni che in qualche modo ci permettono di avvicinarci un po’ di più alla realtà, alle relazioni tra le cose e alle loro incongruenze. Di vedere meglio proprio mentre sembra che invece le immagini sbiadiscono e si confondano. Così, invece di percorrere lentamente la stradina che ci avvicina piano piano alle cose, è come se i personaggi fossino colpiti da un atto immediato di comprensione. Come se un soffio li avvicini all’improvviso a qualcosa di più profondo senza che ne siano pienamente consapevoli.
È quello che fa dire Ventre a Rita: “il reale era qualcosa fuori posto, l’alterazione”, il dettaglio slegato, una fessura, uno slabbro, una galleria che a volte è una via d’uscita. Un’ interferenza nello scorrere del tempo dove il tempo rallenta fino ad arrestarsi, ed anche il battito del cuore rallenta fino a perdersi. Per poi ricominciare a battere. Questa specie di sdoppiamento, di scollamento in cui gli oggetti sembrano sussurrarti qualcosa di incomprensibile, accomuna tutti i personaggi di Ventre. La sensazione di Rita di essere ingoiata dalla città porosa; risucchiata dalle pale d’altare, dalle opere di Caravaggio, le sette opere di misericordia, appunto; dai vicoli; dai sentimenti di misericordia e compassione che la legano al mondo. Ma succede anche a Luisa, la madre, quando apre la gabbia del cardellino, si immerge nell’acqua, nei sensi, in Nino, il ragazzino appena diciottenne che le ha riacceso i sensi. O quando è invasa dal presentimento, un presentimento che risveglia la carne, fa premere le lacrime, le ricaccia indietro assieme al dolore e all’odio, ma poi scivola sull’ammattonato in inafferrabili gocce di mercurio. Quando indugia sulle storpiature e i guasti del tempo: i bordi screpolati, i colori ammuffiti, lo smalto saltato, lo specchio ossidato, per rievocare quell’altra sé, quella faccia di prima, prima che l’erosione cominciasse. Una specie di schizofrenia o allucinazione. “Era di volta in volta, marmo caiola d’auciello, tufo, acciaio o percoca”.
La scrittura dello scollamento non ha a che vedere con la follia, né con la veggenza e tutte quelle categorie pericolose, compromesse da una certa cultura patriarcale che in passato ha associato la creatività femminile a questi spazi di scarto e di grazia. È una scrittura che nasce dall’attrito con la realtà, quella che sorge dal tempo e ne è ingoiata, quella che ti viene addosso senza scampo. Quella che in qualche modo queste scrittrici detestano con tutte se stesse, come scriveva Ortese, da cui la Eugenia del racconto “Un paio di occhiali” storce lo sguardo. Ma che sono capaci di raccontare magistralmente in tutta la sua brutalità, penetrandola e attraversandola. Lo stato confusionale in cui le protagoniste si trovano sfocia così in una scrittura che assorbe tutto, mette in circolo ricordi, desideri, emozioni, svelando del mondo i suoi risvolti, e i suoi crepuscoli.

Questa scrittura polimorfa che tasta nel buio e frusta le pagine, che sto cercando di ricostruire qui, si muove fino ai margini della figura materna. Frantumaglia, che è il titolo della poetica di Elena Ferrante, è semplicemente una parola onomatopeica che usava sbadatamente la madre. La scrittura nasce da una parola materna. Dal gesto della madre chinata sulla macchina da cucito, a mettere assieme brani di stoffa, nell’”ora della sua vera bellezza”. Dagli abiti vuoti che la madre cuciva e appoggiava sul letto matrimoniale in attesa della prova e che la fantasia della bambina gonfiava di corpi misteriosi. E dal suo corpo peccaminoso solo perché femminile di cui Elena bambina era furiosamente gelosa nello stesso modo selvatico in cui lo era il padre. E la figura della madre rivive in Amalia di L’amore molesto, è la donna che Olga non vuole essere ne I giorni dell’abbandono, è la femminilità maltrattata, che maltratta solo per paura ne L’amica geniale. Anche ne Le sette opere di misericordia il corpo di Luisa è una specie di calamita, attorno ai cui miseri segreti e peccati ruotano tutti gli altri. Come una nuova frattura da cui provengono delle onde disarmoniche. Al centro del romanzo c’è un corpo materno che ha avuto paura della sua maternità e che ha deciso di frustrarla, privando sé stessa e il piccolo Nicola di quell’amore necessario, e insegnando a Rosaria a punire il suo corpo, ingozzandosi di cibo e nascondendolo sotto tuniche informi che, anche lei sarta, gli cuce. Un corpo materno che si è abbandonato al piacere in modo inaspettato con un ragazzo, mentre Nicola senza essere né visto né sentito, ha visto tutto.
È una scrittura fatta di genealogie, di strati, di circoli fino ai margini della madre, per accoglierla in qualche modo, accettarne il richiamo. Come fa Delia quando indossa l’abito di Amelia. Nel romanzo di Ventre invece, è Luisa ad avvicinarsi al corpo di quel figlio che accudiva senza toccare troppo. In un abbraccio sghembo in cui il corpo del bambino avvinghiato alla madre si rilassa, lei non può fare a meno di mentire per calmare il dolore provocato da quello che il bambino ha visto senza volere, è solo una cattiveria di Rosaria, stai tranquillo, gli dice, mentre soffoca dentro quelle parole: figliuzzu scutuliato, figliuzzu amato.
Nei romanzi di Ventre e di Ferrante le parole non hanno confini netti quanto i corpi dei protagonisti che non si contengono ma si riversano nella realtà che li circonda. E così la città di Napoli diventa un ricettacolo di umori. E da lì esce ancora una volta una città senza mare e senza sole. Perché la miseria solo vede miseria intorno, una città che non può redimersi, angosciosa, miserabile, volgare, violenta, ossessionata dal controllo del corpo della donna. Gli Imparato vivono stretti tra il carcere di Poggioreale e il cimitero. I vicoli non conducono mai al mare ma solo su altri vicoli che ti incombono addosso senza lasciar vedere il cielo. Quello è per noi altri.
Questa Napoli terribile l’ho vista sempre solo di sguincio, mai frontalmente. Mi entrava nel naso quando respiravo un certo odore acquitrinoso. La vedevo voltando la testa quando mia madre mi trascinava altrove. Ma era in agguato, dentro, accanto al sole e al mare. Al di là di una certa Napoli, Ferrante e Ventre si muovono soprattutto in una città dal perimetro evanescente, che si dilata e si comprime. Una materia che cambia forma a seconda dei movimenti interni dei personaggi, in cui la città (Napoli ma qualsiasi altra) è un riverbero del nostro corpo che è a sua volta posseduto dalla città nera.
La corsa che faranno Lena e Lila fuori del rione sotto il temporale affonda le radici nella corsa dell’infanzia che Ferrante racconta in Frantumaglia. Un giorno lei e una delle sorelle, disobbedendo alla madre, si allontanano dal cortile. Sotto il peso della disobbedienza e di una sensazione di abbandono, il cielo si incupisce e la città comincia a “correrle” appresso. “Della città mi accorsi allora per la prima volta. Me la sentì sulle spalle e sotto le scarpe, scappava insieme a noi, ansimava col fiato sporco, lanciava urla pazze di clacson, era estranea e nota insieme, limitata e sconfinata, pericolosa ed eccitante, la riconoscevo, smarrendomi.” Una corsa in cui non sono gli occhi a disegnare la città ma piuttosto le angosce e i piaceri che la allargano o la strozzano. Sotto un temporale che si scaglia come una punizione.
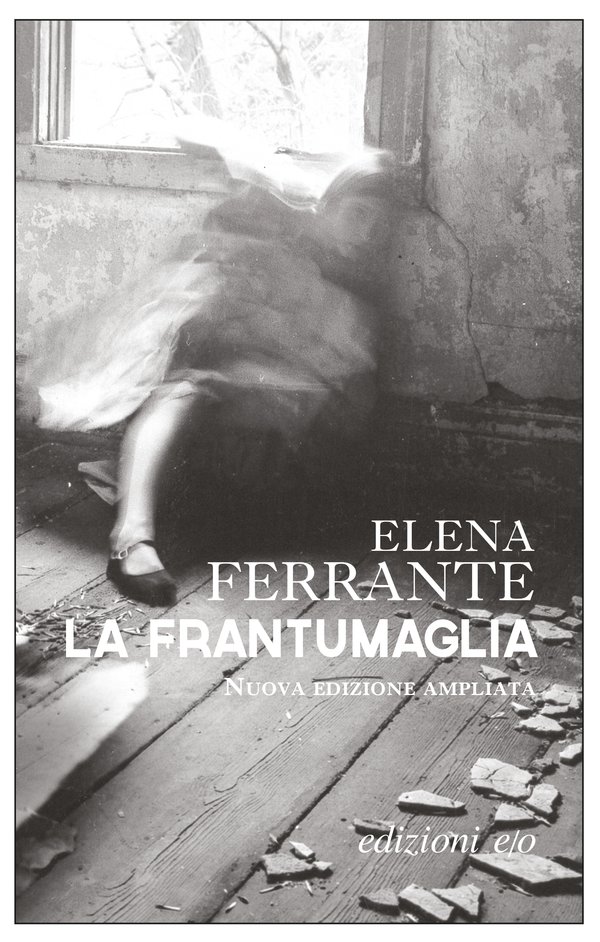
A tenere insieme i pezzi della storia, che poi sono i pezzi luminosi e miserabili di cui siamo fatti tutti noi, è il quadernetto a righe di scuola del piccolo Nicola. Questo diario che è una metafora del romanzo, in una mise en abime piena di richiami, tiene unite le storie dei membri della famiglia e li tiene assieme loro tutti proprio nel desiderio di scrivere tutto quello che nessuno di loro vuole vedere perché fa troppo male. Che poi è quello che ogni scrittore fa. Nicola è capace di legare allo stesso filo, la luna in cui si perde col cannocchiale, quel povero cagnolino che fu spedito a morire sulla Luna, quel suo pupazzo spellacchiato da cui non riesce a separarsi, Alfredino, quei corpi che si accoppiano come cani nel cimitero che è la stessa cosa che spia il padre all’alba dalla finestra dell’appartamento e i corpi della madre e del giovane Nino mentre si accoppiano sul divano, che è quell’unione in cui Luisa sprofonda ogni mattina, quando la casa è vuota, lei libera il cardellino che le ha regalato l’amante e si immerge nella vasca. E in Nicola, con le sue scapole ossute come ali solo abbozzate, rinasce di nuovo l’Useppe di Elsa Morante: la creatura infinita, capace di legare “teneramente” tutte le cose e di portare dentro di sé in modo ignaro tutta la gioia e tutto il dolore.
Nicola è anche il narratore che abbraccia il racconto e la vita vera, il dubbio che prova Lena, la voce narrante dell’Amica geniale, divisa tra il sospetto che Lila abbia nascosto le bambole, facendole credere che fosse stato don Achille a rubarle, manipolandola da sempre e scrivendo così lei la storia della narratrice, e la possibilità, invece, che quelle bambole, che dopo una vita, dopo tutto un romanzo, Lena ritrova nella buca della posta, siano solo un messaggio cifrato di Lila per dirle sono viva, sono qui, finalmente fuori del rione, Lena, la voce narrante e Lila, il suo alter ego. Che lega allo stesso filo invisibile, il buio e la superficie, “qui”, dove sono i dolori di Nicola e “là”, nel pozzo di Alfredino, le parole e le cose che sono entrambe estensioni dell’anima, fino ai margini di ciò che siamo, anche echi di appartenenze e vicinanze con cui dobbiamo fare i conti per stabilire la nostra distanza, che è forse quello in cui più di tutto siamo noi stessi. Ma in controluce, sempre.
Silvia Acierno


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?