“We must learn to see more, to hear more, to feel more”, scriveva Susan Sontag
I
L’opera critica di Susan Sontag nasce anche da una conoscenza profonda dei saggi di Roland Barthes, così profonda da essere una specie di immedesimazione con il gesto critico di Barthes, quello libero e colto dell’esteta, lontano dal critico come “batisseur des systemes”, figura ufficiale e tremendamente noiosa. Gesto che trapassa in quelle foto in bianco e nero, quelle scattate prima di Annie Leibovitz e poi da Annie Leibovitz con cui Sontag ebbe una lunga relazione fatta anche di distanze, ognuna nel suo appartamento, ritorni e maldicenze. Quelle foto in cui si accavallano e sospendono istanti, qui, là, Parigi, New York, l’appartamento spoglio di Riverside Drive e poi il super attico di Chelsea con il suo ordine borghese, le librerie, l’arte, le bluse di seta al posto dei jeans scuri, pose e sguardi divenuti iconici. Eppure quel gesto è allo stesso tempo diverso perché la Manhattan in cui Sontag si afferma e raggiunge “la celebrità”, che lì è la misura di tutte le cose, è una società ancora più agguerrita e senza scrupoli, selettiva con quel suo ma chi è questo? della Parigi di Roland Barthes. Poi quel gesto, a ben guardare, cambia ancora sotto la capigliatura nera e indomita di quella che nei corridoi dell’università chiamavano “il principe nero”, sotto la ciocca bianca di una donna che ha già vissuto molte vite, un marito e un figlio, che, per le malelingue, parcheggiava come un cappotto ad un party. Cambia ancora sotto i capelli bianchi cortissimi della donna che è stata e che continua a lottare contro la malattia rinnegando la parola “guerra” e tutte le altre bugie che raccontano ufficialmente la malattia, fino alla fine, all’ultima foto orizzontale, in cui c’è lei ancora, ancora per poco.
A sostenere quel gesto c’è una determinazione a vivere (proprio il contrario del sorriso “indefinissable” che il Barthes che si mette in posa per una foto dice di abbozzare sulle labbra in La Chambre claire) che brucia tutto il resto, che tiene nascosta l’insicurezza, che punge l’acutezza delle sue opinioni fino all’antipatia e alla cattiveria (che tanti nella biografia di Benjamin Moser, Her life, le restituiscono pareggiando i conti), quella che la spinge ad un certo conformismo benpensante, quella in nome della quale è disposta a sacrificare anche la sua omosessualità, o semplicemente a non esibirla troppo. Quella che in qualche modo trionfa nella Sontag del penthouse di Chelsea, figlia di due esistenze qualunque, e di una madre a cui non era mai piaciuto fare la madre o piuttosto che non aveva saputo fare la madre per quel maledetto dolore e quella maledetta solitudine (madre e marito morti giovanissimi, poco più che trentenni, e lei sola con due bambine) a cui a un certo punto aveva preferito le bugie che tengono lontano ciò che fa male, un glamour tutto superficiale e il perenne bicchiere di vodka. “I will be popular” aveva deciso a undici anni, mentre la madre la sballottava da uno stato ad un altro. La stessa determinazione che le fa affrontare un trapianto del midollo quando oramai tutto è già perduto e la morte è già arrivata.

Come Barthes anche Sontag è stata una solitaria, una specie di franco-tiratore (per utilizzare la sua stessa metafora) del mondo delle lettere, accogliendo infiniti spunti dal giornalismo culturale, dal dibattito socio-culturale, dalla teoria letteraria, dalla filosofia, dal teatro, dal cinema, dalla pittura.
La Sontag di Against interpretation comincia dall’inizio, ovvero dalla distinzione scolastica tra forma e contenuto. Ribaltando tutto , con quel gesto libero che è la cifra della critica moderna: la defamiliarizzazione. Così invece di far calare la bilancia dalla parte del contenuto, la riporta sulla forma. Dietro questo movimento c’è un’idea forte di Barthes, tutto l’impianto estetico dello scrittore francese contro la profondità, contro l’idea che tutto ciò di più vero o reale sia nascosto, latente, stia dietro al romanzo, che in fondo è una critica del pensiero antitetico.
Ma ovviamente niente è come sembra. La forma come la intende Sontag in realtà non è solo stile, una specie di pentagramma lineare o istoriato, la linea dell’elettrocardiogramma di una opera che avanza sostenuta dal ritmo o si spegne nelle sue aritmie. Così come il contenuto, non è soltanto il significato univoco o infinito di un romanzo. Come dire la forma di cui parla Sontag sta un po’ oltre quello che possiamo più o meno intendere per forma e cioè qualcosa di decorativo ed esteriore. Così come il contenuto sta un po’ oltre il testo, non sta solo stipato lì dentro. Lo stile non sta proprio in superficie così come il contenuto non sta solo in profondità. Ma piuttosto in una zona in cui in realtà, forma e contenuto si confondono, come deve essere, e lo stile “invecchia” assieme all’autore, come se fosse anch’esso fatto di materiale organico (direbbe Edward Said, On late style). E così anche il senso della critica letteraria sembra spostarsi in questa zona di mezzo, tra verticalità ed orizzontalità, tra profondità e superficie. In una zona di coinvolgimento e di arresto delle emozioni. In questa regione il contenuto di un romanzo con il plot e i suoi svelamenti (nel gergo attuale spoiler) diventano secondari, subiscono un arresto. La forma smette di essere il polo di un’antitesi sterile o troppo raffinata. In questa regione (della scrittura e della critica) le parole, quella ricercate senza casualità, la loro successione a declinare uno stile formano tutt’uno con il teso e il significato.
In questo luogo dove mi sembra che Sontag mi stia portando, il critico forse dovrebbe raccontare il suo tuffo, quello che è accaduto ai suoi sensi mentre leggeva e leggendo scendeva giù tra le linee, saltava da una parola a un’altra o ci cadeva dentro, staccando i pezzi del puzzle piuttosto che rimettendoli assieme. Trovando analogie e dissonanze ma senza legarle scolasticamente, piuttosto sciogliendole. “Un salto rapidissimo del cuore” ha scritto Ferrante a proposito di Dante. Restituire quella cortina di forma e contenuto senza spiegarla o interpretarla ma soprattutto “raccontandola” in un racconto che si somma al racconto, in un destino che si somma a destino (A Double destiny on Anna Banti’s Artemisia).
Più vedo accumularsi i romanzi in pile, distesi appunto, schiacciati, orizzontali, sulle tavole delle librerie o sulla superficie delle foto postate sui social tra altri elementi spuri destinati anch’essi al consumo, più sento la necessità di dire qualcosa, di ritrovare e sottolineare il gesto del critico. Se la letteratura si è convertita anche in un fenomeno visivo e fotografico, in un mondo saturo fino alla vacuità. Se la letteratura è entrata nel disordine di tutti gli oggetti, degli oggetti qualsiasi, cosa ci si aspetta da un critico, che sensibilità, che gesto, che sovversione?
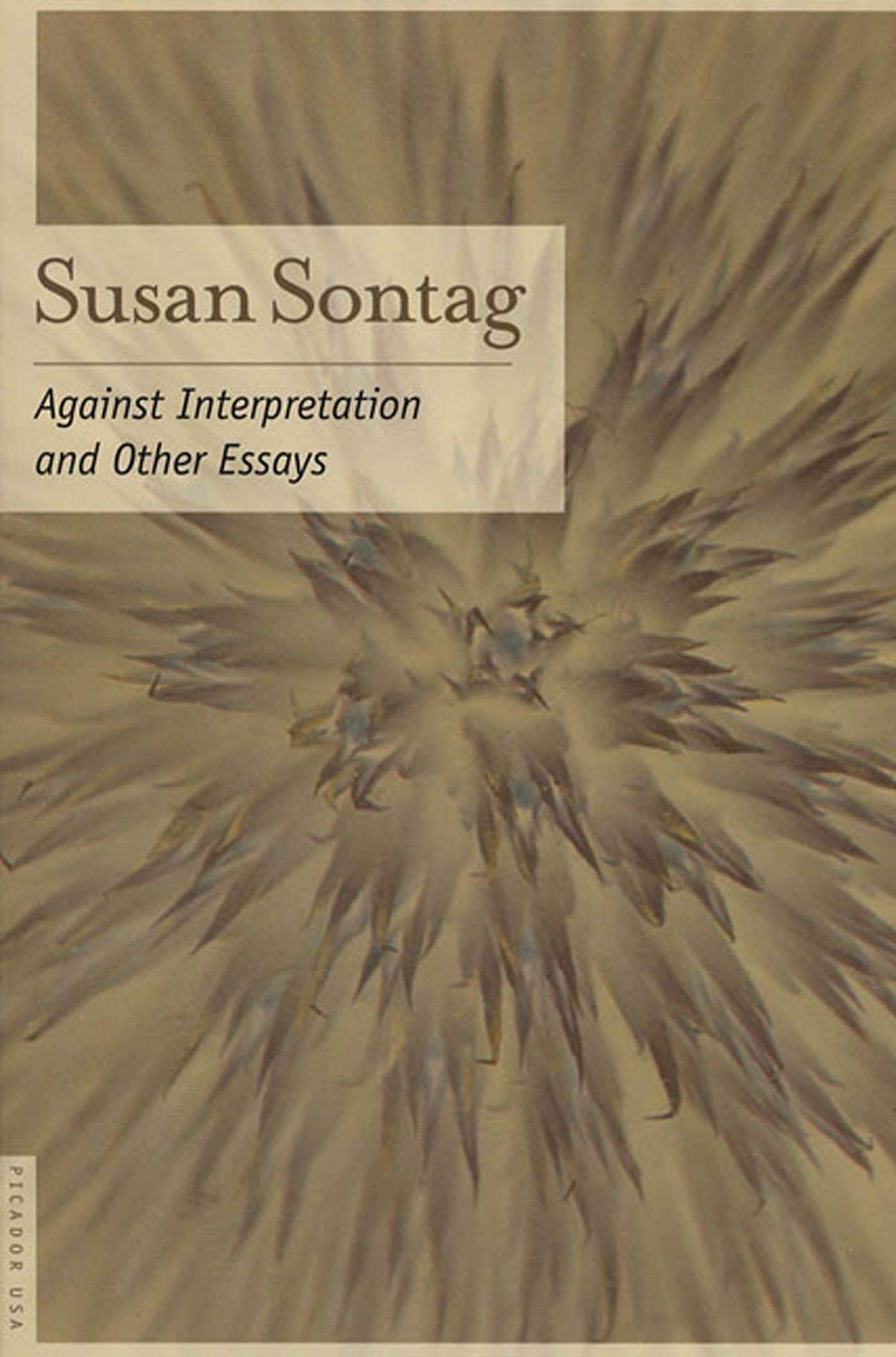
Ritornando a Sontag e al suo Against interpretation. Qui Sontag formula il paradosso di fare una critica non ermeneutica. In un periodo, la fine degli anni sessanta, in cui il dibattito della critica si muove ancora attorno alla possibilità di leggere un testo, il suo contenuto e ritrovare l’intenzione dell’autore, l’unica capace di legittimare o meno una determinata interpretazione e di fare di un critico un buon critico. Ovviamente tutto questo genera una situazione di confort per il lettore, sicuro che ci sia una spiegazione, una verità da raccontare. Lo stesso confort che anche i social e una controcultura che vuole cancellare e censurare contribuiscono oggi a generare. All’altro estremo Barthes, l’autore di un romanzo che non riuscì mai a completare, raccontava invece un’altra storia. Per lui il testo non esiste se non come uno spazio a dimensioni multiple, senza un senso univoco, che non avanza teleologicamente, da un origine verso la fine. Ma un luogo di misture, dove si mescolano scritture precedenti, dove l’autore concreto “è morto”, e con lui qualsiasi senso da spiegare.
Sontag si posiziona in questo dibattito puntando il dito contro il gesto interpretativo. Ancora una volta ispirandosi a Barthes, ci dice che la critica dovrebbe smettere di essere ermeneutica e sforzarsi di essere qualcosa che ha più a che vedere con l’eros, (“l’attrait” che ritorna nelle pagine di Barthes) i sensi e le emozioni. Ma si può sfuggire davvero all’interpretazione? Non del tutto. Certamente a quella che si limita ai quattro muri del testo, perché un testo non ha quattro muri, e perché spiegare il significato di un testo è un atto ridondante, quasi un atto di prevaricazione. Come dire il romanzo è già il significato o il sistema di significati datigli dal suo autore. Perché sostituirsi a lui, perché seppellire fino a cancellare quel significato che giace lì, sotto altri contenuti e significati? Perché citare e tornare a citare quello che è già scritto? Perché non dare il tempo a un romanzo di respirare, di invecchiare invece di centuplicarne il significato, sostituirlo con altri più giovani che saranno a loro volta sostituiti, consumarlo per perdersi nel non senso assoluto?
Allora cosa può fare il critico. Un passo indietro. Diversi passi indietro. Arrestarsi. Invece di spiegare, fermarsi sulla soglia del romanzo che non vuol dire sulla copertina mostrata fino allo sbafo. E su questa soglia aguzzare i sensi per vedere di più, sentire di più, ascoltare meglio. “Our task is not to find the maximum amount of content in a work of art …what is important now is to recover our senses. We must learn to see more, to hear more, to feel more”, scrive Sontag. Ritrovare e restare sulla forma vuol dire in qualche modo restare su quell’amalgama di emozioni, che affiorano dal romanzo e dall’animo del lettore, e provare a raccontarla con onestà.
Il contenuto di un romanzo, di un’opera d’arte, trascende il contenuto e si muove in una regione più astratta (e in questo senso “formale”) di emozioni. “Art is the objectifying of the will in a thing or perfomance, and the provoking and arousing of the will”. Lo stile, il linguaggio, le parole e la loro successione, la loro musicalità non sono solo elementi formali perché sono quei fiammiferi che illuminano il volto, che accendono, rischiarano e poi si spengono sulle emozioni che stanno nel cuore del romanzo. Forse il critico dovrebbe pescare queste emozioni che restano incastrate tra la scrittura e la lettura.
La critica letteraria ha un bisogno inconscio di rifondazioni, di estinzioni e rinascite clamorose (E. Said, Beginnings, per citarne uno). Allora quando Barthes scrive che il romanzo non ha un’origine, che si fa mentre si scrive, che l’autore del romanzo esiste nell’atto di scrivere, non prima al modo di un padre generatore, un origine a cui il critico deve tornare, ha certamente ragione. Ma è anche vero che prima del romanzo esiste uno scrittore a cui tornare, da spiegare e raccontare. Quando Sontag porta le idee di Barthes all’estremo e scrive che la critica non dovrebbe essere un atto interpretativo ha certamente ragione. La critica non può allungarsi in ridondanze, aggiungere significati non ha senso. Meglio stirare la comprensione dell’opera letteraria fino a un punto zero, vuoto eppure pieno. Ma è anche vero che in quello slittamento dal contenuto alla forma si continua ad interpretare, argomentare e filtrare.
Il “degré zero” della scrittura è un’utopia elegante, che ha il pregio di voler liberare la scrittura dal peso della letteratura, del linguaggio stesso con i suoi codici, dell’origine, di tutto quello che c’è stato prima, che può essere facilmente fraintesa. Forse meglio muoversi in uno spazio intermedio tra forma e contenuto, tra reticenza ed eleganza, tra troppo e niente, eccessi e simbolo, interpretazione e sovrainterpretazione. E lì, nello spazio della lettura, che è uno spazio che fluttua meravigliosamente, raccontare le emozioni, le fibre nervose che ci legano al testo, la corrente che è arrivata allo scrittore, attraversando le parole per riversarsi sul lettore. E lasciarla fluire, darle il tempo, tutto il tempo di fluire, senza bloccarla nella ripetizione o sostituirla incessantemente. Toccare l’autore che è vivo, che attraversa i corridoi di un’università, magari famoso o magari trascurato. Seguirlo in qualche modo. E con quel gesto libero da cui cominciano queste pagine raccontare anche le ragioni per cui quella corrente è minima o travolgente, inseguire i perché della sua bellezza.
Silvia Acierno
II
Toccare l’autore che è vivo… Seguirlo in qualche modo.
Come scrittrice, vivo da sempre in quello che sembra un paradosso: pur masticando tutti i giorni parole su parole – parole giuste, parole sbagliate – sperimento di continuo la quasi totale incapacità di interpretare lucidamente un testo – si tratti di un romanzo oppure di un racconto – l’incapacità di assumere, davanti a un testo, una postura analitica. È come se il pensiero si spegnesse, o perlomeno si smarrisse. La reazione per me più naturale, quindi, è un certo smarrimento, lunghi silenzi, una certa, improvvisa opacità – un balbettio insicuro, la difficoltà del guizzo, della risposta arguta alle molte domande che ciascun testo pone.
È un paradosso, dicevo, dato che trascorro la mia vita leggendo non solo per il piacere incomparabile della lettura, per il suo senso di pienezza, ma anche nel tentativo di apprendere dai testi nuovi strumenti da poter poi impiegare in quel processo di scoperta che chiamiamo scrittura. Una lettura “tecnica”, potremmo definirla. Di certo molto attenta – simile all’avventura di un cercatore d’oro, o a quella di un rabdomante che provi a individuare una vena d’acqua, un rivolo nascosto, sotterraneo. Eppure, per quanto attenta e tecnica, la mia lettura è sempre stata un’esperienza in buona parte incomunicabile. Alla domanda: “Allora, com’è quel romanzo? Com’è quel racconto? Che cosa vuole dire?”, la mia prima risposta è un silenzio sgomento, un brancolare, un balbettare. Già, com’è? Come posso spiegare cosa sia, o, meglio, che cosa sia per me?
Da quasi trent’anni, comincio ogni giornata, se possibile, leggendo e passeggiando. Le due cose accadono insieme, non una dopo l’altra o inframmezzata all’altra, per lo stupore di coloro ai quali lo racconto. Insomma: cammino leggendo, o leggo camminando. Com’è immaginabile, questo ha comportato, nel tempo, una serie di cadute più o meno dolorose – non che il dolore mi abbia impedito di continuare a farlo. E poi c’è un’altra cosa, altrettanto importante: leggo ad alta voce, come se ci fosse qualcuno accanto a me, qualcuno in ascolto. La lettura ha sempre avuto, per quanto mi riguarda, il ritmo e l’andamento di una camminata, il ritmo e l’andamento del respiro, a tratti più tranquillo, a tratti più affannato. E ha sempre avuto voce. È un gesto fisico, corporeo, dotato di suono e di cadenza. È un paesaggio, tutto da attraversare, non solo con la mente. Ciò non significa che io non legga anche in altre occasioni, seduta sul divano o sdraiata sul letto. Significa però che niente può eguagliare quella versione “fisica” del leggere, quel suo diventare passo e respiro e voce.
Più di recente, ho compreso quanto quest’abitudine – la mia lettura “fisica” – abbia a che fare con quel mio brancolare o balbettare dinnanzi alla domanda, diretta e senza scampo: “Com’è questo romanzo? Che cosa vuole dire?”. La mia prima risposta sarebbe nelle scarpe che indosso, nelle decine di chilometri percorsi, pagina dopo pagina, fermandomi ogni tanto per guardarmi intorno, nelle persone che mi passano accanto durante il cammino, nel sole e nella pioggia e nella neve, nel vento sulla faccia. In pagine piegate, inumidite o sporche – dato che a volte, carica come sono, con i giornali e coi sacchetti della spesa, il libro cade a terra. Ma è una risposta per cui non ho parole, solo gesti. È un’esperienza, insomma.
Come scrive Sontag, e come Silvia Acierno riporta nella prima parte: “What is important now is to recover our senses. We must learn to see more, to hear more, to feel more”. La relazione con un testo – quelli che amiamo ma non solo – è sempre fisica, corporea: accade giù, in profondità, laddove, da principio, non abbiamo parole – neppure servirebbero, comunque. Potremmo definirla viscerale. È quella vena d’acqua che ciascuno rintraccia a modo suo, nascosta allo sguardo degli altri. La relazione con un testo ci chiede d’imparare a vedere di più, a sentire di più, a percepire di più – non necessariamente a pensare di più, non necessariamente analizzare. Il mio modo di farlo è leggere camminando: un leggere nel mondo, per strada, sotto il cielo.
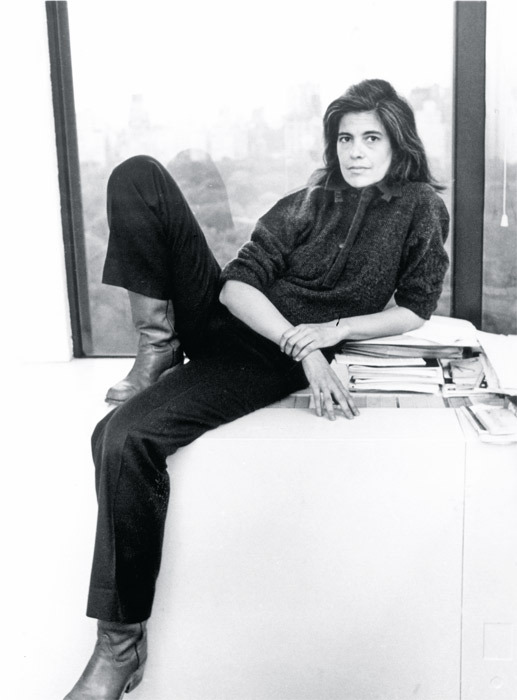
C’è una frase di Flannery O’Connor a cui sono particolarmente legata. La frase è questa, la riporto a memoria: “Il senso di un racconto è il racconto stesso”. Il che significa che, modificando anche soltanto una virgola – sostituendola con un punto e virgola, ad esempio, o con un punto – il senso di un testo cambierebbe. Ma c’è anche un’altra cosa: non è possibile, sostiene O’Connor, “ricavare” da un testo, una volta per tutte, definitivamente, il senso di quel testo, dato che esso è in ciascuna parola, persino nelle virgole, ma soprattutto è nella relazione coi lettori, con ciascuno di loro. Tentare di farlo sarebbe inutile, persino inopportuno. Per poter cogliere il senso di un testo, non c’è altro modo che non sia la lettura – esperienza complessa, dicevamo, sempre mutevole, sempre in movimento – così come il senso di ogni relazione – un’amicizia, un matrimonio – non si può ricavare una volta per tutte: è in ogni istante di quella relazione, in ogni dettaglio, dal più evidente al più sottile, accade nel tempo e nel tempo subisce, giorno dopo giorno, davanti al nostro sguardo, continue variazioni. Ed ecco perché il senso di un romanzo o di un racconto continua a cambiare, nel corso della nostra vita, decine di volte: ciò che non si era colto si coglie all’improvviso, in un’epifania; ciò che sembrava importantissimo smette di esserlo di colpo; ciò che sembrava marginale diventa centrale. Il che ci porta qui: i testi rimangono aperti, per quanto la scrittura sembri definitiva, marmorea, scolpita nella pietra. Uguali a loro stessi eppure diversi. Il senso è nella relazione con ciascuno di noi, ed è in un dialogo continuo. “La letteratura”, diceva Pavese, “è un dialogo tra uomo e uomo”. Non un monologo, non interpretazione: dialogo.
Ciò non significa che non si possa costruire, intorno a ciascun testo, un qualche tipo di discorso, un ponte fra un lettore e l’altro. Non vuole dire che non rimanga che il silenzio, o le infinite sfumature di letture individuali e dunque incomunicabili – una visione rigidamente protestante, insomma. Significa però che esistono diverse vie di approccio, diversi percorsi possibili di avvicinamento. Significa che la parola interpretazione andrebbe di continuo ripensata, sempre tenuta in movimento e sempre interrogata. Uno dei percorsi potrebbe consistere, ad esempio, non nell’interpretare quanto nel raccontare un testo, nel farne l’oggetto – no: il soggetto – di una storia. La storia di un’autrice o di un autore in un momento particolare della loro vita, la storia di una genesi, la storia di uno sguardo, di un lampo, una visione. La storia di un destino o una ricerca. La storia di un incontro. La storia di un rapporto. La storia di una storia, magari mescolata a quella di chi ha letto. Immaginare, dunque, nel suo senso più pieno – cioè, produrre immagini – e quindi raccontare. Portare in vita ciò che nel testo non compare, quello che gli sta intorno, accanto, prima o dopo. Non depredarlo per ricavarne un senso – senso che, comunque, continua a mutare – ma costruirvi intorno la storia della sua messa al mondo, la sua comparsa al mondo, la storia dei luoghi in cui è nato o quelli in cui è giunto. Il dove, il come, il quando. La storia di un testo, in fondo, non è nient’altro che la storia di un’avventura umana che incontra altre avventure umane.
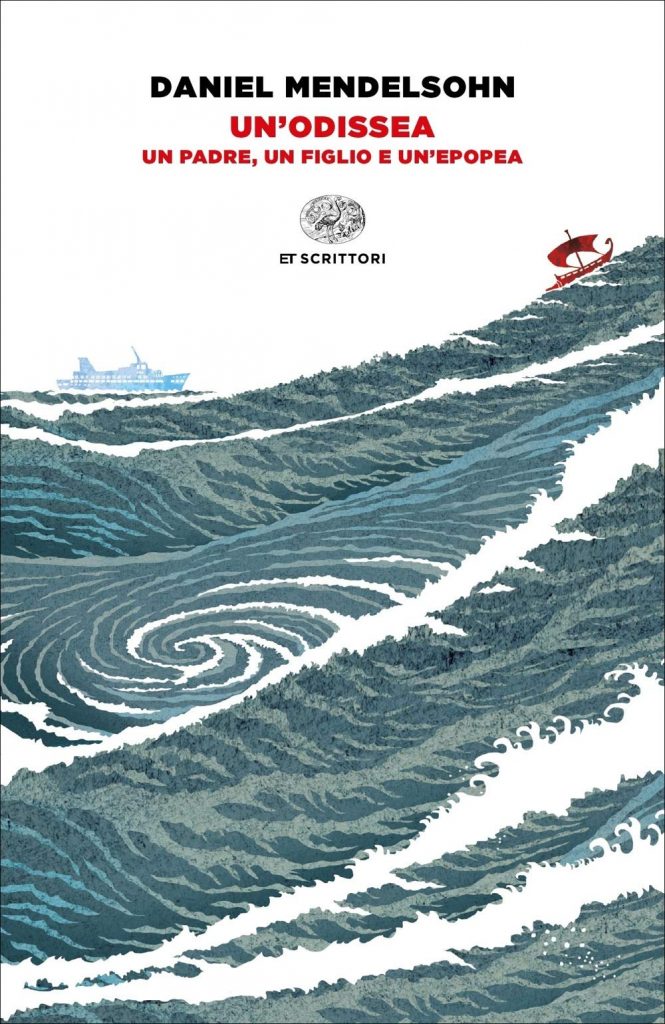
In Un’odissea: un padre, un figlio e un’epopea (Einaudi, 2018) di Daniel Mendelsohn, l’anziano padre dell’autore, Jay, impegnato con il figlio in una crociera di dieci giorni nel Mediterraneo sui luoghi dell’Odissea, o ciò che rimane di quei luoghi – dopo aver frequentato per un semestre il seminario sul quel poema tenuto da Daniel – prima di giungere a Itaca, dove comunque, per ragioni che non svelo, non arriveranno, lascia intendere al figlio che, per quanto piacevole e istruttivo sia stato visitare ciascuno di quei luoghi, per quanto interessante, “il poema è più vero del luogo”. Come direbbe lui, Ray Mendelsohn, in quella che solo all’apparenza è un’ovvietà, il poema è il poema, e nulla può eguagliarlo. Nessun luogo concreto, nessuna sua interpretazione. Non resta che rileggerlo da capo, ancora e ancora. Non resta che ritornare a lui. È questo ritorno – come un ritorno a casa – il viaggio più importante. Bisogna ritornare al testo, e cioè la creatura che muta di continuo, che continua a sfuggire ma permane, che ci richiama nuovamente a sé. Eppure non posso che sottolineare quanto il libro di Mendelsohn, memoir e insieme saggio critico, sia esso stesso un modo alternativo di raccontare un testo così tanto a lungo interpretato, un modo per riportarlo in vita, per riconnetterlo alla vita. Questo ritorno, questa riconnessione alla vita di chi legge adesso, ora – la nostra vita che si accosta alla vita, quindi, perché cos’è una storia, un testo, se non vita? – questo ritorno è il luogo dov’è possibile che il dialogo permanga. Così, per raccontare l’Odissea, si può raccontare di una crociera nel Mediterraneo, con tanto di serate danzanti e cocktails e pianobar, dell’ultimo viaggio di un vecchio padre e un figlio, la storia della loro storia, la storia della loro vita. Riporto qui un passaggio che mi pare importante: “Mio padre era caduto ed era chiaro che non ci sarebbero più stati viaggi d’istruzione. Ma la nostra odissea l’avevamo vissuta – per la durata di un semestre avevamo navigato insieme, per così dire, attraverso quel testo, un testo che a me, lì seduto a osservare la figura immobile di mio padre, sembrava sempre più relativo al presente e meno al passato. Dopotutto è una storia che parla di famiglie strane”.
“Il senso di un racconto è il racconto stesso”. Il senso di un racconto è il suo grande mistero – inesauribile, non inquadrabile, irrisolvibile, mai arginabile. E per fortuna, mi sento di aggiungere. Ma c’è una zona, in quel mio brancolare e balbettare di cui dicevo prima, c’è una zona in cui posso abitare, a cui faccio ritorno ogni mattina, camminando, lasciando che il mistero – il senso di una storia che è in ogni sua parola, in ogni punto o virgola, in ogni pausa o a capo – continui a respirare, a camminare appunto.
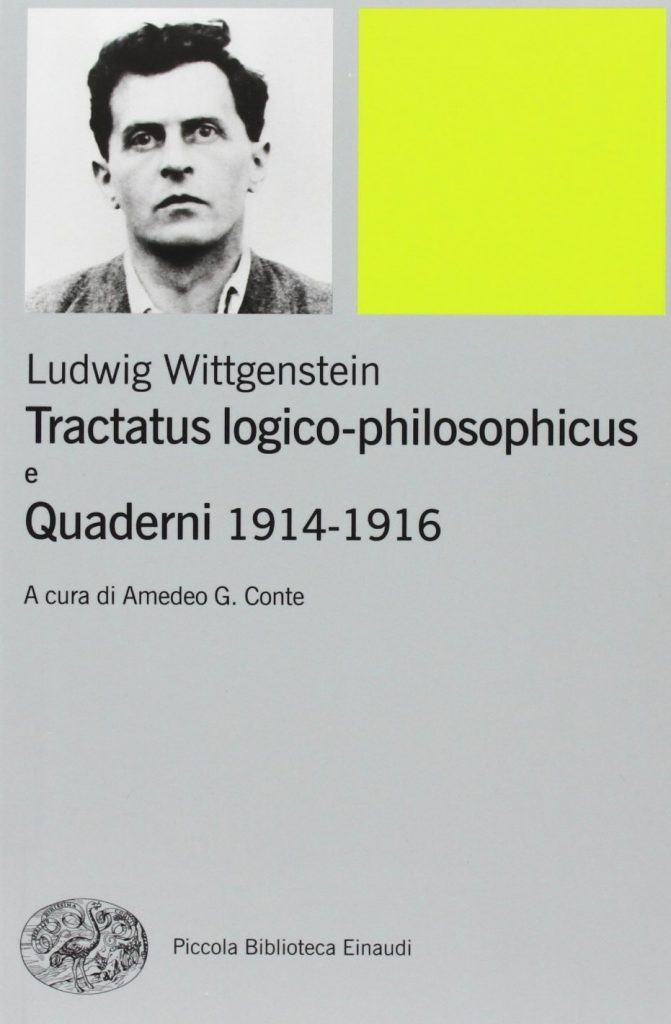
“Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere”, ha scritto Wittgenstein nel suo Tractatus logico-philosophicus – quanto l’ho amato, durante gli anni in cui studiavo filosofia all’università, prima di arrendermi del tutto, e molto felicemente, alla letteratura. Ma potremmo vederla anche così: di ciò di cui non si può parlare, si può comunque raccontare una storia. O ancora: di ciò di cui sarebbe meglio non parlare – laddove il rischio sarebbe il soffocamento della vitalità, un lento inaridirsi o la rigidità – possiamo narrare la storia. Cantami, o Musa, dei testi che amo, lascia che li racconti anche per immagini, con tutto ciò che vedo, che sento e percepisco, con tutta la mia vita. È un altro modo, questo, di avvicinarsi ai testi: andando loro a fianco, camminando. Non dentro, o non direttamente: a fianco. Lasciarli respirare senza cavarne fuori una risposta, dato che la risposta è in ogni parola o segno di punteggiatura e non si può cavare fuori. Ridare loro fiato, rimetterli in cammino, toccare ciò che è vivo con la vita, la nostra, seguirlo in qualche modo. Se la letteratura è un dialogo – lo è – non è mai detto, non è mai prevedibile, di che si parlerà né come: dipende da ciascuno di noi, da tutto ciò che siamo da capo a piedi, insomma, con i nostri pensieri e con le nostre scarpe consumate dal cammino.
Elena Varvello


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?