Dalla Repubblica Ceca ci trasferiamo in Ungheria, terra dalla storia importante e travagliata. Attraverseremo ampie pianure, scaleremo montagne, ci fermeremo in cittadine di provincia, soggiorneremo ai confini dell’impero, per poi affacciarci, brevemente, nella grande città.
Il mio primo approccio con la letteratura ungherese, come per molti, è stato da bambino, con Ferenc Molnár e il suo bellissimo I ragazzi della via Pal, uno dei romanzi per ragazzi di cui serbo il ricordo più nitido. L’esercito di ragazzini in cui tutti sono ufficiali, tranne il piccolo e fragile Nemecsek, è una metafora applicabile a molti contesti “adulti”.
Ma il Novecento ungherese è ricco di grandi scrittori, come il premio Nobel Imre Kertész, che in Essere senza destino racconta la propria esperienza di deportato con uno stile essenziale, ma efficace e un approccio lontano dalla rabbia, dalla paura, dal disgusto propri della vastissima letteratura sull’argomento e caratterizzato, piuttosto, da una sorte di amara rassegnazione, uno spirito di sopravvivenza che trasmette al lettore l’angosciante sensazione che ci si possa abituare a qualsiasi cosa, anche alle più atroci e disumane; o la bravissima Ágota Kristof, la cui Trilogia della città di K è sicuramente uno dei libri più originali e forti che abbia letto: una prosa asciutta, essenziale, priva di fronzoli. Un romanzo scorbutico, diretto e micidiale, come un pugno allo stomaco.
Il nostro viaggio, però, parte da quella che è, probabilmente, la più grande scrittrice ungherese e sicuramente una delle figure più rappresentative della letteratura europea del secolo scorso: Magda Szabó.

MAGDA SZABÓ
Autrice dotata di una prosa straordinaria, ammaliante, la Szabó rappresenta anche il prototipo dello scrittore “impegnato”, che sperimenta sulla propria pelle i rischi e le difficoltà del non essere allineati al regime. Dopo le prime opere in versi, infatti, non pubblicherà nulla per oltre dieci anni, perché messa al bando dal nuovo regime comunista, come molti altri scrittori della sua generazione.
Anzi, si meraviglierà di essere riuscita a pubblicare Affresco, sono rimasta stupita di non essere finita in galera, scriverà, infatti, nell’introduzione a una delle edizioni del suo primo romanzo.
Della sua scrittura si innamorerà Herman Hesse, che, ricevuta una copia clandestina del romanzo da un’amica comune, ne curerà la pubblicazione in Germania e contribuirà alla fortuna internazionale della scrittrice (“Con Magda Szabó avete pescato un pesce d’oro. Comprate tutta la sua opera, quello che ha scritto e quello che scriverà”, dirà il grande scrittore tedesco).
Molte delle opere della Szabó sono autobiografiche, e anche in quelle che non lo sono esplicitamente non possiamo non riconoscere, nelle protagoniste femminili, i tratti dell’autrice. Influenzata dall’educazione calvinista ricevuta in famiglia, non riesce mai ad abbandonare quella certa rigidità di fondo, pur restando insofferente a dogmi e regole. Dell’educazione religiosa le resta una visione escatologica della storia e la convinzione che la politica non possieda da sola gli strumenti per costruire una nuova società più giusta. E di questa visione e di una continua tensione verso la verità e la giustizia è permeata tutta la sua opera.

Ambientato nell’Ungheria del dopoguerra, Affresco è un romanzo corale, che pur svolgendosi interamente nell’arco di una giornata (mezza per l’esattezza, quella del funerale della mamma di Annuska, nomignolo con cui viene da tutti chiamata Corinna, la protagonista del romanzo), attraverso i racconti e i ricordi dei protagonisti dipinge un “affresco” appunto dell’Ungheria sotto il regime comunista e, soprattutto, della famiglia Máthé. Non è casuale l’uso del verbo dipingere: la scrittura della Szabó raffigura scene, tratteggia personaggi, apre squarci di luce in un mondo dipinto con colori foschi. È come se, sull’onda del suo passato di poetessa, sciogliesse in prosa i propri versi, con risultati sorprendenti.
È una scrittura che ti culla e ti sorprende, mai complessa, ma sicuramente mai banale. I suoi ritratti sono incisivi e non si limitano a mostrare i personaggi, ma ne scrutano l’anima fin negli anfratti più reconditi. Le scene che descrive ci sembra di viverle, sono quasi cinematografiche. Nessuno dei due si sedette di nuovo, stavano in piedi, uno di fronte all’altra. Lui cercò il cappello, lo tolse dall’attaccapanni. Janka allora gli si parò davanti, bloccandogli il passo verso la porta…
Sono scene in cui si può entrare (come dice dei quadri di Masaccio il protagonista di Il maestro dei santi pallidi di Santagata).
Annuska torna a casa dopo nove anni per il funerale della madre e per noi questo fin dall’inizio è un dato di fatto. Ma perché se ne sia andata, perché abbia rotto completamente i legami con la famiglia, come e perché sia venuta a conoscenza della morte della madre, chi siano gli altri protagonisti e quali rapporti ed equilibri li uniscano, lo scopriamo a poco a poco, non solo dai suoi racconti, ma, soprattutto, da quelli degli altri personaggi. Il padre, austero calvinista, di una rigidità estrema, scevro dal pur minimo cedimento alla frivolezza (e per frivolezza si intende, spesso, ciò che per gli altri è normalità, come gli addobbi di Natale o l’abito nuziale per la figlia) e alla debolezza (l’unica che si imputa è l’aver sposato la madre delle sue figlie), che ha tentato di educare le figlie a forza di botte e cinghiate, non solo la ribelle Annuska, ma anche la remissiva Janka.
La sorella Janka, appunto, almeno all’apparenza ottusa, terrorizzata da tutto e tutti, in primis dal padre, ma anche dall’ambizioso e iracondo marito, Laszló Kun, diventato ormai il padrone di casa e della canonica, spodestando il vecchio Isvat Máthé, che a causa della pazzia della moglie aveva rinunciato per sempre all’aspirazione di diventare vescovo.
E poi ci sono Arpád, l’orfano, ladro, bugiardo e irrequieto, eppure l’unico rispettato dal padre di Annuska, che lo ha accolto in casa quand’era un bambino (rimasto, appunto, orfano) e lo crede, a dispetto di ogni evidenza, un’anima candida. E via via tutti gli atri, come Zia Rozika e zia Kati (solo quest’ultima voce narrante), che compaiono a uno a uno sulla scena, e dei quali scopriamo un po’ alla volta anche la genesi del loro arrivo nella grande casa di famiglia, in cui è ambientato gran parte del racconto. Tra tutti spicca il gigante buono Mihaly Joó, detto Anzsu, nome affibbiatogli dall’Annuska bimbetta, a cui ha fatto, a suo modo, da vero padre (vai figlia mia, le dice nella scena finale. Anzsu. Papà mio! Pensa lei andando via), e che con le mani crea capolavori con qualsiasi materiale, quando vedeva un qualche materiale non poteva resistere.
Man mano che si scava nei ricordi, che si ascoltano nuove voci, si svelano segreti, si mettono assieme i diversi tasselli della storia, o meglio, delle storie che si intrecciano in questa Ungheria uscita a pezzi dalla guerra e soffocata dall’oppressione sovietica. Ognuno racconta la propria verità, pur narrando storie di altri, e solo il lettore è in grado di collegare e incastrare tutti i pezzi. Così, quelli che prima si insinuano come dubbi nella sua mente, divengono un po’ alla volta certezze, e si svelano verità inconfessabili, che i protagonisti ammettono a fatica solo a sé stessi. Ciascuno, come detto, ha la propria storia, la propria visione della realtà, deformata attraverso la lente dei pregiudizi, delle paure, convinzioni, presunzioni.
È un libro costituito prevalentemente da monologhi: la comunicazione tra i personaggi è scarna, stentata, ognuno conosce dell’altro solo la propria versione, nessuno sa di cosa l’altro sia a conoscenza anche riguardo ai propri segreti, ciascuno presume di saper interpretare i comportamenti altrui e ne deduce cause e fini. I sentimenti prevalenti sono odio, paura, indifferenza, rancore. L’amore è ai margini e limitato a pochissimi rapporti: Anzsu per Annuska, Janka per la figlia (e viceversa). Annuska e Adam.
Il quadro che dipinge la Szabó è nitido: netti i contorni dei personaggi, minuziosa l’ambientazione. L’autrice non si limita a riportare i fatti, ma racconta la verità: la verità storica della sua povera patria (in un periodo in cui bisognava rappresentare come felice e liberato un Paese infelice e sotto occupazione) e la verità sui rapporti tra i protagonisti, i cui sentimenti e la cui reale natura vengono messi a nudo, a dispetto delle apparenze. È la stessa Szabó a scrivere, nell’introduzione all’edizione ungherese del 1999, sapevo cosa stessi descrivendo e difatti non osai conservare in casa il manoscritto.
Il ritorno a casa di Annuska è una catarsi, una liberazione Devi rivederli – le aveva detto Adam prima di partire – allora non avrai più paura di loro.
E infatti è proprio quello che succede: tutti quelli che l’avevano ingabbiata e terrorizzata negli anni in cui aveva vissuto nella casa paterna le provocano solo pietà e compassione. Finalmente capisce che ora è libera: anche se il potere le ha strappato di mano il pennello (come all’autrice la penna) sa che un giorno avrà la sua meritata gloria (proprio come la Szabó).
E sul treno del ritorno riesce a voltarsi indietro e dare un ultimo sguardo alla città appiattita sull’orizzonte, senza rimpianti, consapevole di andare verso il proprio futuro e che il passato è passato e non tornerà a bussare alla sua porta.

MIKLÓS GYÖRGY SZÁRAZ
Facendo un balzo avanti nel tempo, ci imbattiamo in Miklós György Száraz, uno tra i più importanti autori contemporanei ungheresi, insignito di numerosi riconoscimenti. Erede della ricca tradizione del realismo magico dell’est Europa, è stato paragonato, tra gli altri, a Marquez e Hrabal. Il gatto d’argento, suo primo romanzo, è stato pubblicato in patria nel 1997 ed è arrivato per la prima volta in Italia nel 2006.
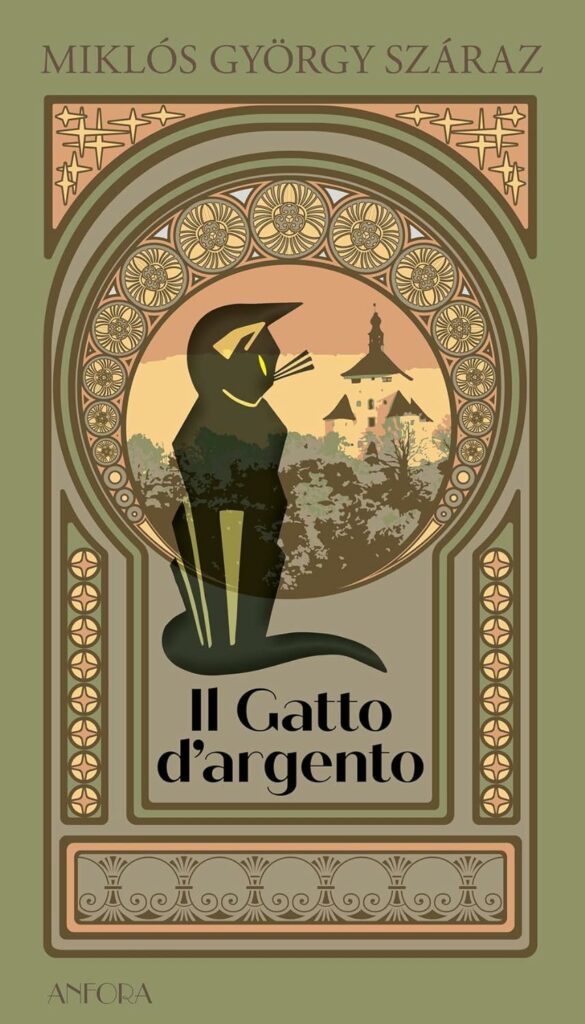
Chi è Jacobus Troll, arrivato all’improvviso col vento del nord, non si sa da dove, né perché, nella tranquilla cittadina dell’Alta Ungheria, tra i monti Frata? E com’è morto, a due anni esatti dalla sua prima apparizione, crollato a pochi metri dalla locanda del Gatto d’argento?
È quello che cerca di scoprire, più di trent’anni dopo gli eventi, il nostro viandante.
Quando egli arriva la città è ormai immobile e muta, sono rimasti solo i venti freddi e rigidi a spazzare le vie deserte. Eppure nel XIV secolo aveva vissuto momenti di gloria, grazie alla sue miniere. Ma l’oro era finito in gran parte in occidente e poi era finito pure l’argento. Le miniere si erano esaurite ed erano state abbandonate: niente più minatori, che spuntati in superficie a sera sciamavano verso la città, riempiendo le locande, niente più costruttori, né mercanti o passeggeri. Se già all’epoca di Troll era ormai un paese di vecchi (qui non nascono bambini ormai da dieci anni, dice il vecchio Gladiólusz), al momento in cui ha inizio il nostro racconto non era neanche più una città, o meglio, non era più affatto. E sebbene al primo impatto al nostro narratore sembra che lì da secoli nulla sia mutato, la sua principale interlocutrice, Erszók Kontyor Pintér, gli farà notare che in realtà niente è più uguale a prima, perché tutto si va sfaldando, sgretolando, solo la polvere, quella davvero non è mutata. E così comincia questo suo e nostro viaggio nella memoria, attraverso il racconto degli ultimi superstiti: oltre alla vedova Pintér, altra fondamentale fonte storica è András Kászonyi Kenyeres, figlio dell’ultimo orologiaio della città, che dal padre ha ereditato la lugubre casa, ma non il talento e che all’epoca dei fatti era un adolescente. Attraverso le loro narrazioni conosciamo una pletora di personaggi straordinari, cha affollano le pagine del romanzo e i tavoli della locanda del Gatto d’argento. Ci sono il vecchio Achilleusz, Salamon Bernáthegyi, commesso di tabaccheria e indomito cacciatore di tesori, il macellaio Béni Keresztély, un colosso forte come un toro, ma incline alla commozione; l’assessore Miklós Podhorszky, tuttologo e gran chiacchierone, il vecchio Gladiólusz, da ragazzino valente artigiano come il padre, fuggito dalla città ancora adolescente e tornato in vecchiaia dopo aver viaggiato a lungo, il professor Gáspár Haramia, bibliotecario talmente geloso dei libri della sua biblioteca da finire con l’inventare qualsiasi scusa per tenerne chiuse le porte e rendere irrintracciabili i testi che ritiene più importanti (praticamente tutti). Haramia che si immedesimerà a tal punto nelle storie che divora nei suoi libri, da chiudersi a chiave in biblioteca, attrezzato di tutto punto come un esploratore, e poi sparire (la moglie giurerebbe proprio dentro un libro). E poi il padrone della locanda, Péter Bárány, e la sua giovanissima e bellissima moglie, talmente bella da metterlo in soggezione, e l’archivista Pulyka, completamente perso nelle sue ricerche, che dalle carte ingiallite trasferisce nella realtà (senza avere né la tempra, né il fisico dell’avventuriero), nella speranza di avere il suo quarto d’ora di gloria alla locanda del Gatto d’argento. Così noi lettori passiamo di racconto in racconto, di seconda mano o in presa diretta, di voce in voce, finendo per non distinguerle. Ci ritroviamo nelle storie completamente dimentichi di chi le stia narrando, attraversiamo tempo e spazio, vivendo le grandi battaglie e le invasioni di una terra da sempre contesa, assistiamo a rivoluzioni e restaurazioni, vediamo passare regni, imperi, regimi, sentiamo cantare le gesta di martiri ed eroi, per ritrovarci tutti, a sera, sempre a un tavolo del Gatto d’argento, con un boccale di birra chiara, che la bella locandiera porta con leggiadria ai tavoli come due grandi mazzi gialli. Come scrive Morandini, nella prefazione a questa edizione, “le storie non sono la trascrizione in buone grammatica della vita, piuttosto sono esse stesse la vita”.
Così ci immergiamo nelle atmosfere magiche e irreali di questa meravigliosa città di matti, che brulica di personaggi pittoreschi, ciascuno col suo ruolo, le sue manie e i suoi piccoli grandi segreti, che così segreti non sono mai. E le storie precipitano dentro altre storie, come strada porta a strada, e nei viaggi reali o onirici risaliamo alle origini della città, vediamo costruire edifici e spianare montagne, osserviamo l’arrivo di stranieri che diventeranno parte integrante del luogo, attraversiamo boschi e vallate e scaliamo montagne, magari al seguito dei Cagnolinidigomma, tre piccoli gemelli sciocchi, di età indefinibile, ma pare ultra centenari, straordinari conoscitori dei poteri delle erbe e principali fornitori della vedova Pintér, considerata da molti una strega, che fa il sapone per tutti bollendo nel suo pentolone resti di animali e piante d’ogni sorta, e prevede il tempo osservando le oscillazioni del gallo metallico sulla torre della fortezza di fronte.
Oppure saliamo sulla torre assieme al vecchio Achilleusz, che vive sospeso al confine tra l’essere e il non essere, a omaggiare i suoi eroi rivoluzionari e le loro gloriose mitiche sconfitte.
Quella in cui arriva Jacobus Troll è una città decadente, in cui anche le strade e gli edifici sono il riflesso dei sogni infranti e degli incubi tormentati dei suoi abitanti. L’arrivo dello straniero misterioso dà in qualche modo una scossa alla comunità sonnecchiante, la rianima, e più questi è schivo e riservato, e meno rivela di sé, tanto più consente agli avventori della locanda di sbizzarrirsi in ipotesi fantasiose sul suo conto. Di lui si suppone che sia molto ricco, e altrettanto bizzarro, perché ha acquistato appena arrivato Ca’ Rubigallus, antica, enorme e decadente dimora “gentilizia”, ma vi si è trasferito senza neanche ripulirla dalle ragnatele. Ogni mattina, sul fare del giorno, esce di casa, sempre da solo, per esplorare i dintorni, con una predilezione per grotte, gallerie, cunicoli ed edifici abbandonati. Troll diviene così il principale argomento di conversazione tra i frequentatori della locanda, quello che riempie gli intervalli tra i racconti surreali di vecchi e nuovi clienti, che fa da corollario all’analisi degli avvenimenti della giornata, che accompagna il bicchiere della staffa. Sul suo conto si raccontano storie mirabolanti e si formulano ipotesi strampalate, tutte suffragate da solide prove: è un malato terminale, venuto a morire in questo remoto angolo di mondo, un ricercato sul cui animo gravano atroci delitti, un uomo di mondo stanco di lusso e lussuria, un cercatore d’oro o di diamanti, che ha scoperto una vena ancora viva in quelle miniere inaridite da tempo, un commerciante di reliquie o di rifiuti, un folle che ha scoperto che proprio nei boschi d’intorno giace sepolta l’arca dell’alleanza. Sarà l’archivista Pulyka a tentare di spezzare questo gioco, in una drammatica ultima serata al Gatto d’argento E a noi che ce ne frega? Dirà, in un raro impeto d’orgoglio, cercando, per una volta, di prendersi la scena A meno che l’invidia e la codardia non siano sufficienti a darci il diritto di ficcare il naso negli affari altrui. La morte improvvisa di Troll, di lì a qualche giorno, lascerà senza risposta tutti i quesiti e aperte tutte le ipotesi, contribuendo, anzi, a infittire il mistero.
Paradossi, fraintendimenti, visioni, allucinazioni, dissertazioni filosofiche tra ubriachi, riti magici costellano il racconto e gli conferiscono un fascino ammaliante. La scrittura di Száraz avvolge il lettore, lo immerge completamente nelle storie. Rapiscono, sopra tutto, le descrizioni dei luoghi, fitti boschi ricchi di vegetazione, che sanno essere ora accoglienti, rilassanti, ora inquietanti, montagne, colline e valli, ma anche edifici, che assorbono le vite dei propri abitanti, le assimilano e le “restituiscono” agli occhi esterrefatti di chi li osserva. Sempre le immagini si stagliano nitide davanti allo sguardo del lettore, che ha la sensazione di percepire i luoghi e gli eventi atmosferici (che sono una sorta di protagonisti occulti del romanzo) con tutti i propri sensi.
Come se giungesse per un funerale, alla fine di settembre l’autunno si presenta con fasto silenzioso. Come dopo i grandi temporali estivi, l’aria diventa limpida, e le foglie della vite selvatica, inerpicatesi sulle rocce, e sui muri delle case che si stanno sgretolando, prima si colorano di un rosso acceso e poi anneriscono, come il sangue che coagula.
E a noi resta la sensazione che ogni cosa che esiste sia solo il resto di qualcosa (o forse, il resto di niente).
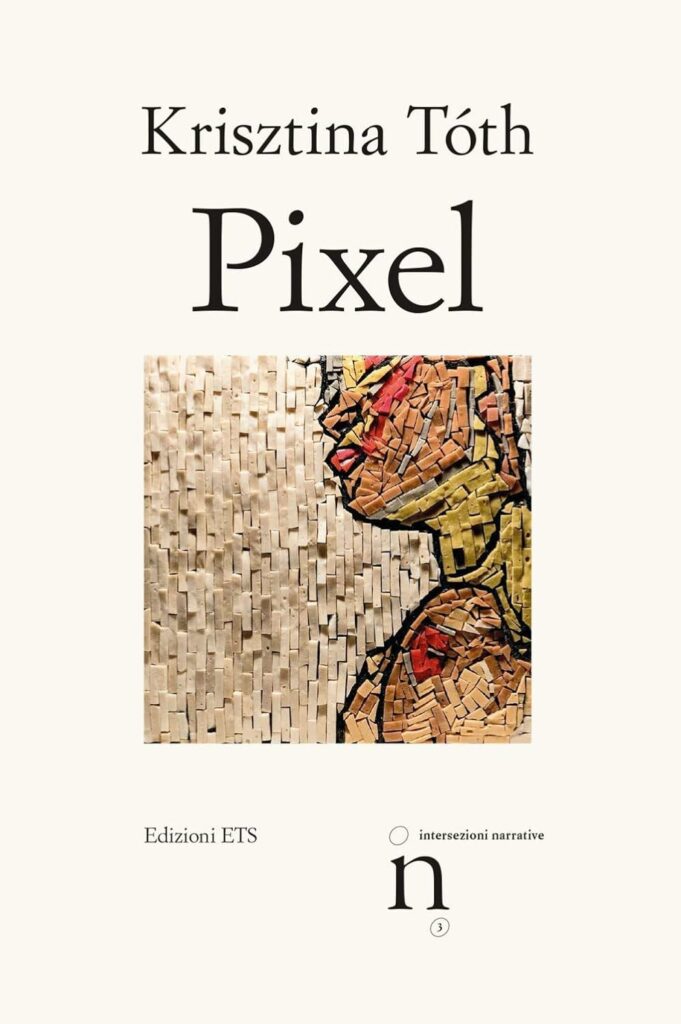
Più recente è la pubblicazione di Pixel, di Krisztina Tóth, ultima breve tappa di questo viaggio in terra magiara. Pubblicato nel 2020, è il primo libro dell’autrice a essere tradotto in italiano (nonostante una già ampia produzione letteraria, che comprende oltre venti libri, tra raccolte di racconti, poesie e romanzi brevi, tradotti in una dozzina di lingue).
Pixel è un libro che si fa fatica a inquadrare in un genere. Breve romanzo polifonico o raccolta di racconti. Racconti apparentemente slegati che a volte si ritrovano. Storie che si intrecciano, anche in altri luoghi e in altri tempi. Storie di vita quotidiana, di amore, di sofferenza, di tradimenti, di dolore di morte.
Francia, Romania, Ungheria, Grecia. Un viaggio attraverso l’Europa di personaggi che si cercano, si trovano, si perdono, si rincontrano, a volte anche senza riconoscersi. Oppure si conoscono senza saperlo. Storie sempre narrate in terza persona, con una narratrice ora partecipe, ora distante, che da qualsiasi punto d’osservazione si ponga mette a nudo i momenti e i personaggi che racconta, e più si è vicini, più ci si incastra nei particolari, perdendo di vista l’insieme.
È proprio l’autrice a svelarlo, in uno degli ultimi racconti: se lo guardiamo più da vicino possiamo scoprirci tutte le sfumature esistenti del colore della pelle umana, nell’insieme, tuttavia, è di un colore vellutato scuro… A una distanza di uno-due metri si vedono solo pixel, bustine di tè secche, mentre da lontano tutto si compone in unico corpo.
Ogni racconto è dedicato a una parte del corpo, dichiarata nel titolo, ma svelata sempre in momenti diversi della storia. Se all’inizio Pixel appare, appunto, una raccolta di frammenti sparsi, a mano a mano alcune storie prendono forma, si scoprono i legami tra i personaggi e alcuni si immaginano, altri, magari, si inventano. Anche se in principio si fa fatica a riconoscere i personaggi, un po’ alla volta essi diventano familiari, così come alcuni luoghi. Personaggi diversi per età, sesso, cultura, nazionalità, stato sociale, eppure tutti accomunati da una profonda solitudine, da un vuoto interiore che ciascuno cerca di colmare a suo modo, mettendo assieme le giornate un pezzetto alla volta, sforzandosi di fare quello che facciamo tutti: amare, sopravvivere.
Fabio Sarno


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?