Per una lira è il titolo di una canzone di Lucio Battisti che comincia così: Per una lira io vendo tutti i sogni miei. E poi la voce a strisce di Battisti racconta la storia di qualcuno che a malincuore si distacca da una parte di sé. Ascoltandola, ho sempre pensato a chi scrive. In particolare agli esordienti. Chi, per la prima volta (e spesso per una lira) consegna il proprio destino al mondo. Nell’incertezza e nell’imprecisione, un esordio insegna a scrivere più di un capolavoro (anche quando le due cose coincidono: David Foster Wallace, La scopa del sistema, 1987). Per una lira è uno spazio dove leggendo le nuove voci della narrativa, italiana e straniera, metteremo in luce alcuni aspetti di un romanzo legati al gesto dello scrivere per la prima volta, ovvero alla scoperta della propria voce.
Alessandra Minervini è nata a Bari ma si sposta continuamente per studio, lavoro e amore (a seconda dei periodi). Dopo la laurea in Scienze della comunicazione a Siena (2003), si è diplomata alla Scuola Holden nel 2005, ha frequentato il master Rai in sceneggiatura. Collabora con la Scuola come consulente editoriale e docente di scrittura. È editor freelance, si occupa di orientamento editoriale. Suoi racconti sono apparsi sulle principali riviste letterarie italiane e francesi. Ha pubblicato Overlove (LiberAria 2016); Bari, una guida (Odos Edizioni); Una storia tutta per sé. Raccontare se stessi per essere (più) felici (Les Flaneurs 2021); Una bella fetta di torta (Progetto Apri, 2023) e Scrivere storie fantastiche (Les Flaneurs 2023). Scrive di libri e di scrittrici su Exlibris20 e la Repubblica Bari. Il suo sito è alessandraminervini.info.
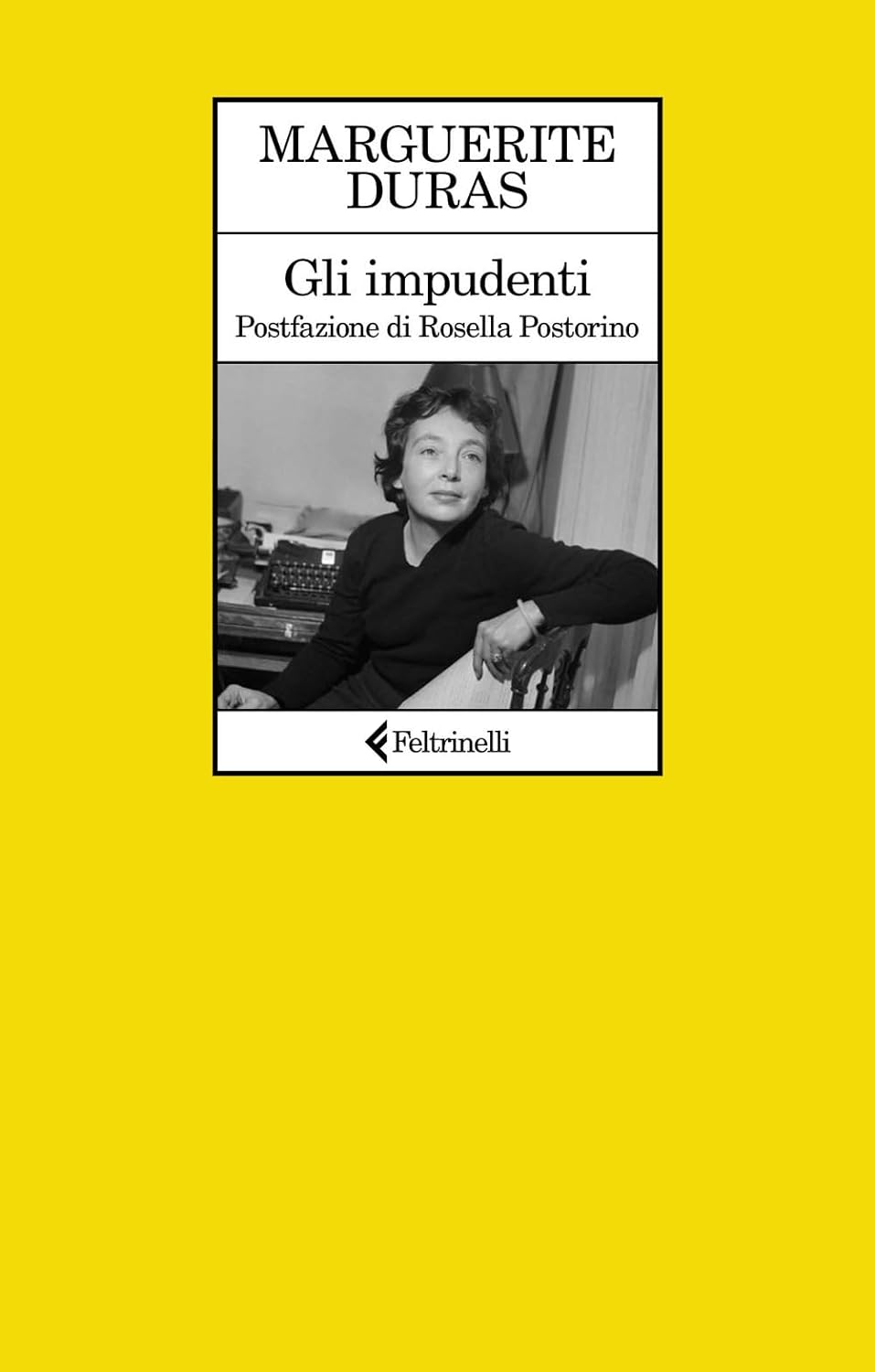
Mentre quasi tutte le opere di Marguerite Duras sono state tradotte in italiano, il romanzo d’esordio, Gli impudenti, ha rappresento finora una vistosa eccezione. In queste pagine si notano le avvisaglie della sua prosa audace e vitale e del suo stile inconfondibile, sapiente miscela di finzione e memoir.
Jacques, il fratello maggiore di Maud, la protagonista del romanzo, rimane vedovo. La madre, madame Grand-Taneran, decide dunque di trasferirsi con i figli nella loro residenza a Uderan, nel Sud-ovest della Francia, nella speranza che possa giovare al figlio in lutto. Ma Jacques sembra avere in mente tutt’altro. Così come ha sempre fatto a Parigi, anche in campagna assume con autorità il ruolo patriarcale. Perseguita la sorella Maud, plagia il fratello Henri e manipola la madre, sempre pronta a legittimare le sue ignobili azioni. Maud assiste impotente alle angherie di Jacques che, insieme alla madre, progetta di farla sposare a un uomo che non ama per difendere i suoi meschini interessi.
feltrinellieditore.it
Lezione n. 60
Madri di famiglia tra vita e letteratura
-->
Avevo raccontato di esordi lontani nel tempo ma non nello spazio narrativo e dentro la percezione umana, quando ho scritto dell’opera prima di Anna Maria Ortese e Rina Durante. Torno sul passato, ma è solo una circostanza. Poco è più attuale, e in questo senso di una bellezza devastante, della famiglia Grand Taneran, protagonista del primo romanzo di Marguerite Duras – pseudonimo di Marguerite Germaine Marie Donnadieu. Gli impudenti è una storia morbosa e ossessiva nella quale la scrittrice mostra come i legami di famiglia diano vita a relazioni torbide, non solo, e non tanto dal punto di vista sessuale, ma emotivo. Il controllo dell’altro è alla base delle vicende di Jacques e di sua sorella Maud, la protagonista del romanzo. Quando il fratello resta vedovo, la madre decide di trasferirsi con i figli in una residenza nel Sud-ovest della Francia, per dare conforto al dolore di Jacques. Invece sembra avverarsi quel vecchio detto per cui il comfort è il veleno. L’incedere della storia lascia chi legge avvinto a un archetipo letterario, di Duras (e non solo) al quale non si riesce a dare una ragione e proprio per questo assilla: cos’è la cattiveria e perché esiste? E dove si annida la cattiveria nell’egoismo o nell’impotenza? Quando il fratello capisce di avere campo libero per manifestare autorità e priorità a suo vantaggio, Maud è troppo debole per reagire e sua madre totalmente abbindolata dal figlio. Può il dolore privato mascherare un alibi o viceversa? Che cos’è un abuso senza l’amore puro della vittima verso chi lo pratica? Mi sono chiesta questo leggendo un romanzo che finalmente è arrivato in Italia grazie all’intercessione di una pasionaria durassiana, la scrittrice Rosella Postorino.
Avevo letto articoli e riflessioni su Duras (“la scrittrice del desiderio”) di Postorino che firma la postfazione del romanzo, illuminante dopo la lettura, dove scrive: «Madre rifugio domestico, madre terra selvaggia, madre comica, madre odore puro di sapone di Marsiglia, madre che suona al piano le arie imparate a scuola, madre che grida la verità come un messaggero divino, non bisogna aspettarsi niente, niente, dalle persone, dallo Stato, o da Dio, madre che canta Sambre et Meuse imbracciando un bastone come un fucile per giocare alla guerra davanti ai figli, e poi scoppia a piangere pensando ai fratelli caduti a Verdun, madre disperata che non sa sottrarli allo spettacolo della disperazione, che è innocente mentre rovina i figli per sempre, mentre inermi ed esposti come si è solo nell’infanzia, questi figli, pur così diversi tra loro, la amano alla follia. È lei il personaggio durassiano per eccellenza, l’origine di tutto ciò che sarà. È lei a dominare la scena fin da Gli impudenti.»
Postorino, si capisce già da questo stralcio, non è solo, o non è più, la lettrice innamorata della scrittrice feticcio, non è soltanto una fedele studiosa ma la descrive dal punto di vista di una “nemica amatissima”. Qui fa scacco matto. Perché intercetta, in una connessione cognitiva, l’ancestrale esperienza di lettura che Gli impudenti genera. Noi leggendolo, guardiamo il nemico da dentro, lo odiamo ma nello stesso tempo possiamo anche comprenderlo, come si comprende un nemico di cui tutto dispiace ma forse non la sua esistenza.
Per tanti motivi sono molto grata a Rosella Postorino che ha generosamente accettato di conversare con me durante la mia lettura del romanzo.
Cosa vuol dire scrivere per Duras, e cosa ti ha insegnato leggendola e amandola come scrittrice anche e forse soprattutto dal punto di vista di una donna?
Per Duras non c’è distinzione tra vita e scrittura, anzi: la scrittura in qualche modo soppianta la vita, la riduce, la isola. «Si è qualcuno solo nei libri», diceva Duras. Il suo investimento nella letteratura fu assoluto, quasi fatale. Leggere Duras, fin da quando avevo 15 anni, è stato probabilmente uno dei motivi per cui mi sono azzardata a immaginare di poter scrivere anch’io. D’altronde non ho mai creduto che trovarsi di fronte alla grandezza inibisse, censurasse, che spingesse a desistere perché sarebbe stato comunque impossibile raggiungerla. Credo al contrario che i grandi scrittori abbiano alimentato la nostra fede nella letteratura. Duras era una donna, non veniva da una famiglia di letterati, veniva da una famiglia in cui quasi non si leggeva, benché fosse figlia di insegnanti, e da un ambiente piuttosto degradato: eppure ha trovato la forza di prendere parola, di scrivere. È stato quel coraggio, innanzitutto. Poi c’è che quando l’ho letta per la prima volta (in lingua originale) mi è parso di trovarmi di fronte a un alfabeto nuovo, anzi a una maniera completamente nuova di usare un alfabeto che conoscevo. Avevo già scritto altri tre saggi su Marguerite Duras: la mia prima pubblicazione è stata proprio un saggio incluso nella raccolta Duras mon amour 3, a cura di Edda Melon ed Ermanno Pea; poi ho scritto le postfazioni a due suoi libri tradotti da me, Moderato cantabile e Testi segreti (che raccoglie i romanzi brevi L’uomo seduto nel corridoio, L’uomo atlantico, La malattia della morte e La puttana della costa normanna). Scrivere di lei e della sua opera mi consente di analizzarne la scrittura in profondità e di trovare risonanze fra un testo e l’altro: ogni volta vedo qualcosa che non avevo visto prima, sembra un processo inesauribile. In particolare, in questo caso, volevo scoprire quanto della Marguerite Duras che conosciamo attraverso i suoi capolavori, Il viceconsole, Il rapimento di Lol V. Stein, L’amante, era contenuto in nuce ne Gli impudenti, che è innegabilmente acerbo, eppure ha in sé l’energia che si avverte in certi esordi, benché imperfetti. Basta pensare al personaggio della madre, potentissimo. La scrittura di Duras parte da quella madre, non ho dubbi.
Come mai questo romanzo non era ancora stato tradotto in Italia, che idea ti sei fatta come adepta letteraria di Duras?
È un romanzo che Duras rinnegava, lo definiva brutto, ed è in effetti un romanzo che dal punto di vista strutturale, e soprattutto sintattico e lessicale, non pare scritto da lei. Ma dal punto di vista dello sguardo, dell’impudenza di quello sguardo, appunto, e dal punto di vista delle ossessioni e pure dei personaggi, è un romanzo assolutamente suo. La madre, il fratello cattivo e però desiderato, la ragazzina che scopre il desiderio per qualcuno che è fuori dalla famiglia, la famiglia come gabbia, i soldi e i rapporti di potere: ne Gli impudenti c’è già tutta Duras. Per questo sono felice di averlo fatto pubblicare, più di 80 anni dopo la sua comparsa in Francia. È anche un testo poco studiato, non c’è quasi critica su questo libro.
Raccontaci brevemente il cuore del romanzo, dove si posa secondo te?
Potremmo definirlo un romanzo di formazione. È per me la storia di un tentativo di emancipazione: una ragazza di vent’anni cerca un modo per liberarsi dalle maglie asfittiche della sua famiglia, alla quale è però morbosamente legata. Maud cerca una maniera per affrancarsi dalla madre, che è la sua ossessione e dalla quale non si sente amata, e da un fratello mascalzone verso il quale tradisce però un vago impulso incestuoso. L’emancipazione, come per tutte le ragazze durassiane, non può che avvenire attraverso il desiderio, ma il desiderio si rivela a sua volta un’illusione.
«Maud rimase un attimo alla finestra, le braccia allungate alla ringhiera del balcone, la testa china in un atteggiamento simile a quello di una bambina oziosa. La sua faccia però era pallida e afflitta dalla noia».
Cosa vuol dire la memoria dei legami familiari per Duras e come secondo te viene rappresentata nel suo romanzo di esordio?
In un libro intervista dell’89, Marguerite Duras, La passione sospesa, Duras dice: «Non so davvero cosa spinga la gente a scrivere se non, forse, la solitudine di un’infanzia». Sono convinta che l’infanzia sia l’incubatoio che produce molte delle nostre ossessioni future, perciò è anche l’origine della scrittura. L’infanzia di Duras fu segnata dalla perdita precoce del padre (lei aveva 7 anni, malgrado spesso abbia detto di averne avuti 4, mescolando nella memoria la partenza del padre con la sua morte), e dalla truffa subita dalla madre, che aveva acquistato una terra con l’intenzione di coltivare del riso ma, siccome non aveva pagato le mazzette ai funzionari coloniali, quelli gliene avevano rifilata una incoltivabile perché ciclicamente inondata dal mare. La sua infanzia è stata segnata dalla pazzia della madre, che fece assurdamente erigere una diga per arginare le onde, e dal crollo di quella diga, che simboleggia il fallimento materno e la rovina della famiglia. C’è insomma, nella sua infanzia, il senso di una radicale ingiustizia, alla quale Dio è indifferente. Credo sia il nucleo stesso della scrittura di Duras. Quest’ingiustizia senza rimedio è già nel primo romanzo. I personaggi dipendono l’uno dall’altro, eppure sono soli, incapaci di venirsi incontro, incapaci di volersi bene in un modo che non sia molesto. Il desidero erotico sembra poter liberare almeno i figli da questo schema, ma è fugace. Però c’è nel gesto di desiderare una rivendicazione di autonomia, un tentativo di fuga, che Maud è la prima dei personaggi durassiani a intraprendere.
Qual è il tuo capitolo/situazione/personaggio preferito nel romanzo?
Mi piace molto il primo incontro fra Maud e Georges Durieux, perché non è un incontro vero e proprio, anzi: è semplicemente uditivo. Maud, che cammina da sola verso Uderan, sente un rumore molto forte, e in principio lo associa al battito del proprio cuore; poi si rende conto che sono in realtà gli zoccoli di un cavallo al galoppo. Su quel cavallo c’è Georges Durieux, ma lei lo ignora. Immagina un cavaliere coraggioso, come una qualunque principessa che debba essere liberata dalla torre in cui è imprigionata. Mi piace questo gioco letterario: mentre allude al cliché dell’amore romantico e salvifico, Duras lo smonta. L’errore di percezione di Maud – il suono che sembra avere a che fare con il cuore e invece è altro – è un’idea sottile e ironica, che con efficace sintesi racconta la parabola illusoria dell’amore.
Quali sono le ossessioni della scrittrice che emergono in nuce nella storia de Gli impudenti?
La madre e la sua follia, la madre come calamità; l’assenza paterna, che è metonimia dell’assenza di Dio; l’incesto come prima forma del desiderio e come desiderio per antonomasia; il desiderio come epifania e forza centrifuga che spinge a oltrepassare un perimetro segnato da altri; i rapporti gerarchici e di potere che si dispiegano nella società; il triangolo come forma elettiva della relazione; la contraddizione inevitabile e senza soluzione dell’incontro con l’altro da sé.
A proposito della madre della scrittrice, nella tua postfazione al romanzo, dici “è lei il vero personaggio durassiano”. Puoi dirci qualcosa di più, dal punto di vista del racconto “materno” di Duras.
Madame Grand-Taneran è sicuramente il personaggio più forte de Gli impudenti, anche se non è ancora la figura mitologica che sarà la madre di Una diga sul Pacifico o de L’amante, e non è ancora la figura fiabesca – crudele e innocente, come spesso i personaggi delle fiabe – che sarà la madre di Ernesto in La pioggia d’estate. La madre è stata un’ossessione per Duras e molte delle sue protagoniste sono madri, anche le più impensabili come tali, ad esempio Lol V. Stein o Anne-Marie Stretter. La madre di Duras, su cui Madame Grand-Taneran è ricalcata, è una specie di archetipo contrapposto alla figura di Anne-Marie Stretter: l’una è votata ai figli, schiacciata dalla sorte e priva di desiderio sessuale; l’altra, benché madre, è «di chi la vuole», e riassume in sé il dolore del mondo.
«Non so cosa spinga la gente a scrivere, se non, forse, la solitudine di un’infanzia.»
Di recente hai raccontato Duras in uno splendido podcast, Genealogie, edito dal Corriere della Sera. Che idea ti sei fatta, leggendola per tutta la vita, della vergogna nella letteratura di Duras e che idea possiamo farci noi della stessa leggendola?
Bellissima domanda. Ne La vita materiale Duras dice: «la vergogna copre tutta la mia vita». L’origine di quella vergogna è ancora una volta nell’infanzia (con la parola infanzia Duras intende per lo più l’intero periodo vissuto nell’Indocina francese, dove la madre insegnava e dove lei è rimasta fino a 18 anni), e riguarda il declassamento subito a causa della truffa: la madre, piena di debiti, arrivò a chiedere soldi agli usurai indù, e questa era la vergogna più grande per un bianco, nelle colonie. I bianchi – raccontò spesso Duras – evitavano la sua famiglia. C’è stata anche la vergogna di essere una ragazzina che, proprio a causa della miseria, usava la propria desiderabilità per farsi dare soldi dagli uomini, con il tacito consenso della madre, che tuttavia doveva fingere di opporsi alla libertà sessuale della figlia, e quindi, se implicitamente la spingeva a una forma di prostituzione, ufficialmente la picchiava per punirla. I prodromi di queste tipologie di vergogna – economica, sociale, morale – si intravedono già ne Gli impudenti. C’è però una vergogna superiore e per così dire ontologica, nell’opera di Duras. È la vergogna di appartenere al genere umano, quello che ha commesso il crimine dell’Olocausto, del quale tutti, secondo lei, devono ritenersi colpevoli: in definitiva, è la vergogna di far parte di una specie capace di compiere il male.
Piccola bibliografia
Marguerite Duras, L’amante, Feltrinelli 2015
Marguerite Duras, Moderato cantabile, Nonostante 2013
Marguerite Duras, Il viceconsole, Feltrinelli 2023
Clicca qui per leggere le altre 59 lezioni


 RSS - Articoli
RSS - Articoli
E tu cosa ne pensi?